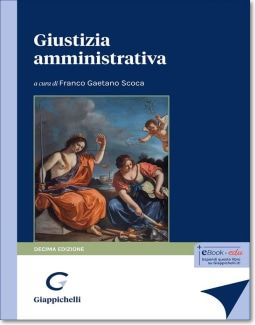Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 3 luglio 2014, n. 7068
FATTO
1. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR (in seguito, anche "Associazione" o "UARR"), odierna esponente, rappresenta quanto segue.
1.1. Essa è l'unica associazione italiana che aggrega gli atei e gli agnostici, costituita di fatto nel 1987 e legalmente, come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. c.c., con atto notarile del 13 marzo 1991.
1.2. Con l'odierno gravame, notificato in data 3 febbraio 2004, depositato il successivo 19 febbraio 2004, l'UAAR impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Governo italiano aveva rifiutato di avviare le trattative finalizzate ad una intesa ex art. 8, comma terzo, della Costituzione.
Come l'Associazione chiarisce, nella nota della Presidenza del Consiglio del 5 dicembre 2003, oggetto dell'odierno giudizio, si leggeva che "il Consiglio dei Ministri ha condiviso il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene che la professione dell'ateismo, certamente da ammettersi al pari di quella religiosa quanto al libero esercizio in qualsiasi forma, individuale ed associata, purché non integrante riti contrari al buon costume (art. 19 della Costituzione), non possa essere regolata in modo analogo a quanto esplicitamente disposto dall'art. 8 della Costituzione per le sole confessioni religiose. La possibilità ivi contemplata di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese è infatti, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Sostiene inoltre l'Avvocatura Generale nel citato parere che per "confessione religiosa" si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale. La connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell'art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo, di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie".
1.3. La ricorrente Associazione, sull'assunto del proprio carattere di "confessione religiosa", deduce i seguenti motivi di ricorso:
I - Violazione dell'art. 1, comma 1, lett. ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13:
L'impugnato diniego sarebbe stato esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e non invece con decreto del Presidente della Repubblica, che sarebbe, invece, richiesto per tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
II - Violazione dell'art. 8 Cost. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti:
Al di là dei contestati aspetti formali, in ogni caso, contrariamente a quanto opinato dalla Presidenza del Consiglio, l'UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione;
III - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione di norme interne e prassi, con conseguente disparità di trattamento;
All'erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe conseguita l'omissione dell'istruttoria circa l'idoneità della richiedente ad essere soggetto stipulatario di intesa con lo Stato.
IV - Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 per omessa motivazione e, comunque, eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua:
Gli atti impugnati non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all'intesa de qua, limitandosi a rinviare al parere dell'avvocatura dello Stato.
V - Violazione degli artt. 2, 3, comma 1, e 18 Cost.:
La negazione della specifica identità della ricorrente, sottostante al diniego di stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost., equivarrebbe al disconoscimento della causa associativa del gruppo, traducendosi nella violazione del diritto di associarsi liberamente.
VI - Violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost. per disparità di trattamento:
Se l'ateismo è esercizio di libertà di religione, il rifiuto di trattare la ricorrente come una confessione religiosa integrerebbe una disparità di trattamento, in violazione dei disposti costituzionali sull'eguaglianza senza distinzione di religione e sull'eguale libertà di tutte le confessioni religiose.
VII - Violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.):
Risulterebbe altresì violato il principio costituzionale di laicità dello Stato, il quale impone equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose, tra le quali sarebbe ricompreso anche l'ateismo in forma organizzata.
VIII - Eccesso di potere per sviamento:
Il potere di concludere intese con ogni singola confessione religiosa, costituzionalmente conferito al Consiglio dei Ministri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla migliore garanzia del diritto di libertà religiosa, sarebbe stato utilizzato per negare l'interesse legittimo della ricorrente, disconoscendone il carattere religioso e gli interessi religiosi dei suoi associati.
2. Nel presente giudizio si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso in epigrafe.
La difesa erariale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame per difetto assoluto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, ex art. 31 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione alla natura politica della gravata delibera del Consiglio dei Ministri, come tale sottratta tout court al sindacato giurisdizionale; nel merito, insisteva comunque per il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Le confessioni religiose evocate in giudizio in veste di controinteressati non si costituivano.
3. Con la sentenza 5 novembre - 31 dicembre 2008, n. 12539, la Sezione, in accoglimento della spigata eccezione erariale, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione.
In accoglimento dell'appello successivamente interposto dall'UAAR avverso la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 4 - 18 novembre 2011, n. 6083, annullava la sentenza n. 12539 del 2008 del TAR per il Lazio, con rinvio al giudice di primo grado.
L'UAAR riassumeva quindi il presente giudizio dinanzi a questo Tribunale, con ricorso notificato il 9 febbraio 2012 e depositato in data 17 febbraio 2012.
4. In seguito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava avanti alla Corte di Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, la decisione del Consiglio di Stato n. 6083 del 2011.
Con la sentenza 12 marzo - 28 giugno 2013, n. 16305, le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingevano il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e confermavano la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.
L'UAAR riassumeva pertanto, il presente giudizio, con ricorso nuovamente notificato in data 27 settembre 2013 e depositato in pari data.
5. Nel frattempo, tuttavia, questo Tribunale aveva dichiarato la perenzione del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a., con decreto 12 aprile 2013, n. 8194.
Tale decreto veniva in seguito revocato dallo stesso Tribunale con ordinanza 20 novembre - 9 dicembre 2013, n. 10592, pronunciata nel giudizio di opposizione a perenzione promosso dalla UAAR; con tale ordinanza la Sezione fissava l'udienza pubblica per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 85, comma 4, c.p.a.
6. La ricorrente Associazione, per scrupolo di difesa, con atto notificato in data 22 - 23 gennaio 2014 e depositato il 30 gennaio 2014, confermava dunque la riassunzione del giudizio introdotto con l'epigrafato gravame avanti al TAR per il Lazio, già promossa dopo la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 16305 del 2013.
7. Alla Pubblica Udienza del 26 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 17 aprile 2014.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, sul piano formale, la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. ii) della legge n. 13 del 1991, che prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica per "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri", lamentando che nel caso all'esame il provvedimento gravato, i.e. l'atto decisorio di rifiuto dell'avvio delle trattative con l'UAAR ai fini della conclusione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, non presenterebbe i necessari requisiti di forma, in quanto difetterebbe la prescritta emanazione con d.p.r., essendo stato lo stesso provvedimento esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, delegatario della funzione di condurre le trattative con le confessioni religiose in vista dell'intesa in argomento.
1.1. La censura deve essere disattesa.
1.2. A tal riguardo, in primo luogo si osserva che, come si desume dalla rubrica della legge n. 13/1991, e come è confermato dall'esame delle tipologie provvedimentali richiamate nell'art. 1 in questione, l'emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica è prevista esclusivamente per "gli atti amministrativi", e non anche per gli atti avente contenuto oggettivamente politico, quale quello all'esame.
In secondo luogo, va tenuto presente che nell'attuale assetto dei pubblici poteri, la "emanazione" di cui si discorre è atto di competenza del Presidente della Repubblica, connotato da una funzione di controllo dell'opportunità politica e, lato sensu, della legittimità costituzionale dei provvedimenti dell'Esecutivo; tuttavia, nella fattispecie in questione, non è rinvenibile alcuna determinazione provvedimentale, atteso che il Consiglio dei Ministri ha assunto una "determinazione negativa", deliberando di non stipulare intesa alcuna ex art. 8, comma 3, Cost., con l'UAAR.
1.3. A fronte di siffatta decisione di segno negativo, priva di effetti modificativi della realtà giuridica e fattuale e non costitutiva di vincoli per il Governo, sia pure solo sul piano politico, nei confronti di alcuno, la formalità dell'emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica non solo non si rendeva necessaria, non essendovi alcuna determinazione da sottoporre al previo vaglio presidenziale, ma non era neppure configurabile, dovendosi escludere, nel richiamato assetto dei pubblici poteri, che il Presidente della Repubblica, se coinvolto nel procedimento, potesse esprimersi sulla mancata stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost., essendo ogni decisione al riguardo riservata dalla Costituzione al Governo.
1.4. Poiché il Presidente della Repubblica non poteva interloquire riguardo alla decisione di procedere o meno alla stipula, dovendo egli invece essere consultato solo in merito all'intesa eventualmente già stipulata dall'Esecutivo, ne discende anche l'inammissibilità della doglianza all'esame per carenza di interesse, atteso che l'impugnata deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche se emendata del dedotto vizio formale, non avrebbe potuto comunque avere un contenuto diverso.
2. Con i successivi motivi la ricorrente sostanzialmente deduce, nel merito, che, contrariamente a quanto opinato dal Governo, l'UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione.
Dall'erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe poi conseguita l'omissione dell'istruttoria circa l'idoneità della richiedente a stipulare l'intesa con lo Stato; in particolare, i prescritti pareri della Direzione Generale Affari di Culto presso il Ministero dell'Interno e della Commissione Consultiva sulla libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, sarebbero stati illegittimamente surrogati, in via del tutto anomala, dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, organo diverso da quelli normalmente coinvolti nel procedimento di intesa.
Gli atti impugnati, inoltre, non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all'intesa, limitandosi a rinviare al parere reso dall'Avvocatura dello Stato.
La negazione della specifica identità confessionale dell'UAAR, infine, si tradurrebbe nella violazione del diritto di associarsi liberamente; risulterebbero, altresì, violati il principio di uguaglianza di cui agli artt. 3, comma 1, ed 8, comma 1, Cost. rispetto alle altre confessioni religiose, nonché il principio costituzionale di laicità dello Stato.
3. Le richiamate censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.
3.1. La questione giuridica sostanziale, sottesa all'intera vicenda in controversia, risiede nella controversa natura dell'UAAR, sostenendosi da parte ricorrente che si tratterebbe di una vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione, laddove la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invece negato tale natura, così pervenendo al contestato rifiuto dell'avvio delle ripetute trattative con l'Associazione.
3.1. A tale riguardo, il Collegio deve preliminarmente considerare che con la sentenza n. 16305 del 2013, resa tra le parti sul ricorso del Governo ai sensi dell'art. 111 u.c. Cost., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo sulla vicenda contenziosa all'esame, hanno sostanzialmente affermato che le confessioni religiose sarebbero portatrici di una pretesa costituzionalmente tutelata (e quindi azionabile in giudizio) all'apertura delle trattative per la stipula dell'intesa di cui all'art. 8, comma 3, Cost., e all'implicito riconoscimento della loro natura confessionale.
3.2. Orbene, seppure è vero, per costante giurisprudenza di legittimità, che la Corte di Cassazione, quando regola la giurisdizione, è giudice del "fatto" - nel senso che, agli effetti dell'identificazione del giudice munito di giurisdizione, può apprezzare elementi probatori acquisiti al processo - ciò non di meno, è parimenti incontestato che le valutazioni del materiale istruttorio effettuate dalla S.C. ai fini della individuazione del giudice munito di potestas iudicandi non condizionano la decisione di merito della controversia, che rimane comunque riservata in via esclusiva al giudice individuato dalla Corte regolatrice (Cass. n. 9325/2007). Ne discende pertanto che la sentenza n. 16305 del 2013, nel ritenere che la presente controversia sia devoluta alla cognizione del G.A., non spiega tuttavia un effetto vincolante quanto alla definizione nel merito del presente giudizio e, nella specie, in particolare, quanto all'accertamento della natura giuridica dell'UAAR.
3.3. Peraltro, la richiamata sentenza n. 16305 del 2013 reca alcuni interessanti enunciati che conviene senz'altro richiamare ai fini della decisione del presente gravame.
3.3.1. È utile prendere le mosse dalla osservazione, che la S.C. trae dalla relazione dell'ufficio del Massimario, secondo cui "la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce ad ogni confessione un interesse giuridicamente qualificato per l'accesso agli status promozionali, anche su base pattizia; impone alle autorità nazionali di predisporre criteri di accesso non discriminatori e di adottare congrue motivazioni d'esercizio; ammette il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza dei criteri predisposti e sull'idoneità delle motivazioni adottate, in funzione di tutela della posizione soggettiva incisa" (CEDU, 31 luglio 2008, n. 40825/98; 19 marzo 2009, n. 28648/03; 30 giugno 2011, n. 8916/05; 9 dicembre 2010, n. 7798/08; 6 novembre 2008, n. 8911/00)."
Afferma quindi il Giudice di legittimità che "l'assenza di normazione specifica sui fenomeni religiosi non è di per sé un impedimento a contrastare in sede giurisdizionale il rifiuto di intesa che sia fondato sul mancato riconoscimento, in capo al richiedente, della natura di confessione religiosa". E, nel confermare la correttezza di fondo della soluzione prescelta dal Consiglio di Stato nella sentenza 6083 del 2011 (che nella presente controversia ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo), la decisione n. 16305 all'esame prosegue, stabilendo che "Il principio di laicità dello Stato, 'che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica' (Corte Cost. 203/1989) implica che in un regime di pluralismo confessionale e culturale sia assicurata l'eguale liberta delle confessioni religiose"; che "Al tempo stesso i rapporti tra Stato e confessione religiosa sono regolati secondo un principio pattizio, con la stipula delle intese"; che "Anche se l'assenza di una intesa con lo Stato non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dell'attuazione della eguale libertà religiosa che la Costituzione prevede che normalmente laicità e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose", non senza specificare, infine, che "si devono garantire contemporaneamente, di regola, tramite le intese: l'indipendenza delle confessioni nel loro ambito, nell'accezione più estesa; il loro diritto di essere ugualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l'una dall'altra; ma anche la garanzia per lo Stato - ecco il senso della regolamentazione dei rapporti - che l'esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione, per quanto è possibile, con le sfere in cui si manifesta l'esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni Cittadino è tenuto".
3.3.2. La pronuncia delle Sezioni Unite perviene quindi all'affermazione che lo "stabilire la qualificazione di confessione religiosa è una premessa basilare per la salvaguardia dei valori di cui si discute"; e, a tal riguardo, la stessa sentenza richiama l'enunciato della Corte costituzionale secondo il quale (v. ancora Cost. 346/02) "all'assenza, nell'ordinamento, di criteri legali precisi che definiscano le «confessioni religiose» si può sopperire con i "diversi criteri, non vincolati alla semplice autoqualificazione (cfr. sentenza n. 467 del 1992), che nell'esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali"; e, ancora, "(C. Cost. 195/93) [la quale] aveva ritenuto che la natura di confessione può risultare 'anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione'".
Per concludere che "È nel giusto quindi la sentenza impugnata quando sostiene che rientra tutt'al più nell'ambito della discrezionalità tecnica l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa".
3.3.3. Tanto considerato, la Corte ritiene, per quanto di interesse nel presente giudizio, che "Il procedimento di cui all'art. 8 è in funzione [...] della difesa delle confessioni religiose dalla lesione discriminatoria che si potrebbe consumare con una immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali"; che "La posizione del richiedente l'intesa mira dunque a ottenere che il potere di avviare la trattativa sia esercitato in conformità alle regole che l'ordinamento impone in materia, che attengono in primo luogo all'uso di canoni obbiettivi e verificabili per la individuazione delle confessioni religiose legittimate"; che "L'attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell'esecutivo, che è incompatibile con la garanzia di eguale liberta di cui all'art. 8 c. 1 [Cost.]".
3.3.4. I richiamati enunciati della Corte risultano in linea con le chiare indicazioni recate dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6063 del 2011, che, in relazione all'avvio di trattative finalizzate all'eventuale stipula di intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost., aveva già evidenziato l'ampia discrezionalità che indubbiamente le connota, con riferimento sia all'an dell'intesa, sia - prima ancora - alla stessa individuazione dell'interlocutore in quanto confessione religiosa; e, ciò che più in questa sede rileva, aveva ritenuto connotato da discrezionalità tecnica l'accertamento preliminare relativo alla riconducibilità alla categoria delle "confessioni religiose" dell'organizzazione richiedente, con conseguente acclarata possibilità, nell'esercizio di tale discrezionalità tecnica, di escludere motivatamente che il soggetto interessato presenti le caratteristiche che gli consentirebbero di rientrare fra le "confessioni religiose" (come è avvenuto nel caso di specie).
4. Alla luce dei principi espressi dalle richiamate pronunce deve dunque ritenersi che la questione della natura giuridica dell'UAAR, sollevata dalla odierna ricorrente, si sostanzia nella contestazione degli esiti dell'accertamento preliminare compiuto dal Governo in merito alla riconducibilità dell'Associazione richiedente alla categoria delle "confessioni religiose", accertamento connotato da una lata discrezionalità tecnica; esso rimane dunque assoggetto al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo secondo le regole e nei limiti elaborati dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
4.1. Nel caso all'esame, il secondo motivo di impugnazione si profila nel suo complesso inammissibile, poiché con esso si sollecita lo scrutinio dell'adìto Giudice sull'operazione di accertamento compiuta dall'Autorità resistente sulla natura confessionale dell'Associazione ricorrente, al fine di sostituirla con una diversa valutazione basata su una diversa ricostruzione dei caratteri e degli indici rilevanti per una siffatta qualificazione, proposta dalla ricorrente; scrutinio all'evidenza non consentito al Giudice, senza invadere l'ambito della discrezionalità tecnica riservato all'Autorità, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., III, 2 aprile 2013, n. 1856; id., 28 marzo 2013, n. 1837; Tar Lazio, I, 21 giugno 2013, n. 6259; Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2007, n. 550; Cons. St., VI, 10 marzo 2006, n. 1271; TAR Lazio, I, 24 agosto 2010, n. 31278; id., 29 dicembre 2007, n. 14157; id., 30 marzo 2007, n. 2798; id., 13 marzo 2006, n. 1898) e come, da ultimo, autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte, in tema di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa nella materia del diritto della concorrenza, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità tecnica, ricordando che "Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità - come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza - detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini" (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
4.2. E nel caso all'esame, non sembra che l'odierna intimata abbia esorbitato dai margini dell'opinabilità propri dell'attività tecnica - nello specifico, di scelta, ricostruzione e valutazione dei caratteri distintivi propri delle confessioni religiose - esercitata al fine dell'accertamento preliminare da compiersi nella fattispecie concreta, essendo viceversa pervenuta al risultato ottenuto, riproducendo il ragionamento logico ed analiticamente argomentato seguito dall'Avvocatura generale dello Stato nel parere a tal fine espresso, così come complessivamente si evince dalla motivazione della nota della Presidenza del Consiglio, oggetto dell'odierno gravame.
4.3. In tale nota si evidenzia che la possibilità contemplata nell'art. 8, comma 3, della Costituzione, di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese, è, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; che nel citato parere l'Avvocatura Generale ha sostenuto che "per 'confessione religiosa' si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale"; che la connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell'art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo.
Di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma costituzionale non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie.
4.4. Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine al carattere non confessionale dell'Associazione ricorrente, in quanto richiama una concezione di confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale presupposto, "un fatto di fede rivolto al divino" - escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto a negare l'esistenza del trascendente e del divino - non sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando viceversa coerente con il significato che, nell'accezione comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino; e tenuto altresì conto del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello "Statuto") "organizzazione filosofica non confessionale", che "si propone di rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso": con ciò autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell'ambito delle confessioni religiose.
E pertanto il motivo all'esame va disatteso, unitamente ai motivi terzo e ottavo, in quanto formulati sul presupposto che l'Associazione ricorrente sia una confessione religiosa.
5. Del pari infondato è il quarto motivo di gravame, con cui si denuncia un presunto vizio di motivazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna deducente, gli atti impugnati illustrano in modo compiuto ed esauriente l'iter logico giuridico seguito dal Governo per addivenire alle determinazioni censurate, come sopra già illustrato.
D'altra parte, pienamente legittima è la motivazione per relationem, quando l'atto richiamato, nella specie il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia reso disponibile alla parte (art. 3, comma 3, l. 241/1990); e nella specie, l'UAAR, a seguito di istanza di accesso in data 5 novembre 2003, ha ricevuto copia, tra gli altri atti, anche del suindicato parere reso sulla questione.
6. Da disattendere è anche la censura svolta col quinto mezzo, poiché il diniego di stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost. in alcun modo incide sul diritto di associarsi liberamente ai sensi dell'art. 18 Cost., né sulle garanzie di cui agli artt. 19 e 21 Cost., che nulla hanno a che fare con le ripetute intese.
7. Del pari inconferenti si appalesano le doglianze articolate con il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, sull'eccesso di potere per disparità di trattamento e per sviamento.
La negazione della asserita identità "confessionale" dell'UAAR non comporta profili di disparità di trattamento, essendo ovviamente ragionevole una disciplina diversa in riferimento a situazioni ritenute non coincidenti.
8. Per le ragioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e va respinto.
9. Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto della delicatezza e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.