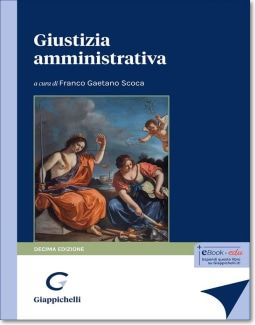Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 4 ottobre 2018, n. 24173
Presidente ed Estensore: Olivieri
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 23 ottobre 2014, n. 6487, ha rigettato l'appello proposto da M.M.P. e confermato la decisione del Tribunale ordinario di Roma, ritenendo infondata la pretesa risarcitoria formulata dall'appellante nei confronti di Gruppo Editoriale "L'Espresso" s.p.a., del giornalista M.L., del direttore responsabile del periodico D.H., nonché del Ministero della Giustizia, per i danni alla propria reputazione subiti a causa della pubblicazione in data 8 settembre 2005 sul periodico "L'Espresso" di un articolo intitolato [omissis] nel quale veniva riportato, con modalità eccedenti i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, il contenuto di una conversazione telefonica - emersa dalle intercettazioni telefoniche disposte nel corso di indagini preliminari aventi ad oggetto l'accertamento di fatti di corruzione - tra il collega C. ed il P., entrambi magistrati in servizio presso il Tribunale di Napoli, nel corso della quale il primo raccomandava un interessamento del secondo a favore del proprio figlio avvocato in relazione al possibile conferimento di eventuali incarichi professionali da parte della Sezione fallimentare.
Il Giudice territoriale rilevava: a) che il fatto nella sua oggettività non era contestato; b) che le modalità dell'esercizio del diritto di critica inteso a segnalare la irritualità della condotta tenuta dai magistrati, non eccedeva i limiti della continenza formale né trasmodava in un gratuito attacco alla integrità morale del P.; c) che, in ogni caso, ove anche si fosse configurato il reato di cui all'art. 684 c.p., e pur considerata la natura plurioffensiva di tale fattispecie penale, la corrispondenza a verità dei fatti narrati integrava la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.
Non poteva ritenersi fondata neppure la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Ministero della Giustizia, sul presupposto della imputazione ad ignoto dipendente di tale Amministrazione statale della illecita divulgazione della "informativa" in data 15 febbraio 2005 - che riportava il contenuto della intercettazione telefonica - trasmessa dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Roma, in quanto difettava la prova che l'atto in questione fosse coperto da segreto atteso che, nelle more della pubblicazione dell'articolo di stampa, erano stati adottati sulla base della predetta informativa provvedimenti di perquisizione domiciliare e di sequestro preventivo, oggetto di richieste di riesame da parte dei difensori degli indagati, e dunque non poteva escludersi che il contenuto della conversazione fosse reso noto nella motivazione dei provvedimenti di perquisizione notificati agli indagati, ovvero che la stessa informativa fosse stata depositata nella cancelleria del Giudice penale, con la conseguenza che, venuto in tal modo meno il segreto, persisteva soltanto il divieto di "integrale pubblicazione del testo" di tale atto, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.p., che poteva quindi essere, pertanto, legittimamente utilizzabile anche dal Ministero nell'espletamento della sua attività ispettiva.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da M.M.P. con dieci motivi.
Resistono con controricorso il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.L. e D.H.
Non ha svolto difese il Ministero della Giustizia.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalle parti resistenti nel controricorso, sul presupposto della omessa trascrizione integrale dell'intero articolo di stampa, è priva di pregio atteso che il ricorrente si duole esclusivamente delle specifiche espressioni a lui riferibili, contenute nell'articolo, e che trascrive compiutamente alla pag. 4 del ricorso per cassazione, assolvendo quindi all'onere di specificità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Venendo all'esame dei motivi del ricorso il Collegio osserva quanto segue.
Primo motivo: violazione art. 21 Cost.; artt. 51 e 595 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente censura la sentenza di appello per non aver ravvisato la violazione del limite della continenza formale.
Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a richiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione di merito inerente l'apprezzamento del carattere offensivo della proposizione "C. disturba un giudice fallimentare... E M. si mette a disposizione" utilizzata dal giornalista per descrivere il rapporto tra le parti della conversazione telefonica intercettata.
Deve, infatti, ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto cronaca e di critica costituscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 15510 del 7 luglio 2006; Id., Sez. 3, Sentenza n. 17395 dell'8 agosto 2007; Id., Sez. 3, Sentenza n. 80 del 10 gennaio 2012).
Il motivo si incentra interamente sull'assunto secondo cui la indagine giornalistica deve essere fornita di un apparato argomentativo congruo: il che è a dire che non rientra nel diritto di critica la mera illazione, o la insinuazione arbitraria, lesive della dignità personale.
Se tale affermazione può ritenersi del tutto condivisa in giurisprudenza laddove ai fini del legittimo esercizio del "diritto [di] critica" - che non deve rispondere, per sua natura, a criteri di oggettività ma, in quanto manifestazione di opinione, non può che riferirsi ad una personale e dunque soggettiva riflessione intellettuale sui fatti compiuta dal giornalista - si richiede, comunque, il requisito della "continenza sostanziale", ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 379 dell'11 gennaio 2005), tuttavia l'esame in concreto della adeguatezza del ragionamento critico svolto dal giornalista rispetto al predetto interesse pubblico, pertiene esclusivamente al Giudice di merito, il quale soltanto è chiamato a verificare se il limite della continenza sostanziale sia stato o meno osservato: diversamente opinando il sindacato di legittimità verrebbe a risolversi in un inammissibile terzo grado del giudizio di merito.
La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha esaminato non soltanto il requisito della "continenza formale" ritenendo formalmente neutre le singole espressioni verbali utilizzate dal giornalista nella descrizione del fatto-notizia, ma ha puntualmente evidenziato anche la stretta correlazione tra le predette espressioni verbali e la esposizione del pensiero critico del giornalista in ordine ai fatti riferiti.
Non appare dirimente al riguardo la distinzione, prospettata dalla difesa dei resistenti, tra "giornalismo d'inchiesta", nella quale il giornalista si fa parte attiva nella ricerca degli elementi indiziari idonei, se non a ricostruire la vicenda, quanto meno ad orientare lo sviluppo della acquisizione della notizia di reato da parte della autorità di polizia giudiziaria e, quindi, delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica, e "giornalismo di informazione", nell'ambito del quale il giornalista recepisce l'accaduto limitandosi a divulgare la notizia attraverso la narrazione (verbale, scritta, visiva) del fatto, distinzione ben nota alla giurisprudenza e che si riscontra in tutti i casi in cui il "diritto di cronaca" si innesta e viene a costituire il presupposto della - susseguente - attività riflessiva volta ad attribuire un determinato "senso compiuto" ai fatti narrati, secondo il punto di vista del giornalista e la sua personale interpretazione, nel che consiste la espressione di opinione che caratterizza l'esercizio del "diritto di critica". Ed infatti, anche nel caso di congiunto esercizio dei due diritti, entrambi riferibili alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., deve sempre operarsi il bilanciamento con il contrapposto interesse, anch'esso assistito da copertura costituzionale ex art. 2 Cost., alla tutela della moralità individuale o della dignità professionale della persona oggetto di critica, venendo - peraltro - ad atteggiarsi diversamente, nel diritto di critica rispetto al diritto di cronaca, la verifica del requisito della utilità sociale o dell'interesse pubblico in considerazione del differente oggetto (la descrizione dell'accadimento del fatto - nel diritto di cronaca - ed il significato che al fatto accaduto viene attribuito - nel diritto di critica -), coincidendo nel diritto di critica il requisito della "utilità sociale" con lo stesso interesse della comunità ad acquisire differenti opinioni ed apporti critici su determinati fatti rilevanti per la vita sociale. Come più volte ribadito da questa Corte, il legittimo esercizio del diritto di critica è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse: ove, tuttavia, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 20 giugno 2013; Id., Sez. 3, Sentenza n. 841 del 20 gennaio 2015; Id., Sez. 3, Sentenza n. 5005 del 28 febbraio 2017).
Orbene la sentenza impugnata si è conformata a tali indicazioni avendo la Corte di merito, da un lato, esaminato il requisito della "verità oggettiva" della notizia, pervenendo a verificare la corrispondenza del contenuto della conversazione riprodotto nell'articolo di stampa a quello riportato nella nota informativa del Reparto operativo dei Carabinieri, e dall'altro, avendo sottoposto a verifica il contenuto critico-riflessivo dell'articolo di stampa accertando che la conversazione telefonica in questione, nel contesto complessivo della indagine penale in corso, non rendeva del tutto arbitrario, inverosimile e fantasioso il sospetto di possibili scambi di favori e poteva legittimare, pertanto, il dubbio sulla ritualità dei rapporti all'interno dello stesso ufficio giudiziario (cfr. sentenza appello in motivazione, pag. 4), risultando rispettato inoltre anche il carattere della continenza formale, in quanto le espressioni usate dal giornalista per descrivere il fatto (C. disturba e M. si mette a disposizione), non trasmodavano nella invettiva personale e gratuita.
L'affermazione del ricorrente, secondo cui il giornalista avrebbe dovuto giustificare ulteriormente il proprio pensiero critico, prospettando al pubblico anche ipotesi interpretative diverse dei fatti, non assolve ai requisiti di deduzione del vizio di legittimità, venendo piuttosto ad incidere sul contenuto, più o meno sviluppato, dell'argomentazione logica sottesa all'esercizio del diritto di critica, che non può costituire parametro di valutazione della illiceità della condotta, venendo ad essere oltrepassato il limite imposto dal requisito di pertinenza all'interesse pubblico della libera manifestazione del pensiero esclusivamente nel caso in cui la opinione espressa sia basata, non su fatti realmente accaduti ma su mere ipotesi congetturali (difettando in tal caso lo stesso "oggetto" della riflessione critica), ovvero sia formulata in modo totalmente avulso dai fatti realmente accaduti, così da apparire frutto di ipotesi meramente fantasiose e dunque assolutamente arbitraria ed ingiustificata, come tale diretta soltanto ad arrecare nocumento alla integrità morale della persona.
La contestazione rivolta, con la censura in esame, alla sentenza impugnata viene a tradursi nella prospettazione di una possibile differente valutazione del contenuto della richiesta telefonica effettuata dal collega all'altro magistrato, ma è appena il caso di ribadire come sia proprio l'alternativa tra possibili diverse valutazioni del medesimo fatto che integra il proprium dell'esercizio del diritto di critica, sicché il tentativo di accreditare come maggiormente ragionevole una tesi interpretativa piuttosto che un'altra, non esclude perciò stesso la riconducibilità anche della tesi contestata nell'ambito della legittima manifestazione della opinione critica sul fatto. In tal senso va individuata la ratio decidendi della sentenza di appello intesa a riconoscere la scriminante ex art. 51 c.p. nella valutazione dei fatti compiuta dal giornalista pure se "non giustificata od opinabile" (cfr. motivazione della sentenza di appello), dovendo evidentemente essere inteso correttamente il primo termine della proposizione (complemento predicativo verbale) nel significato di non univocamente e necessariamente condivisibile da chiunque altro.
Secondo motivo: motivazione "apparente" e caratterizzata dal contrasto tra affermazioni inconciliabili ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo si palesa inammissibile.
Premesso che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Corte cass., Sez. un., Sentenza n. 22232 del 3 novembre 2016) e premesso ancora che il vizio di contraddittorietà di motivazione presuppone un'insanabile inconciliabilità tra le varie ragioni ed argomentazioni poste dal giudice a giustificazione della soluzione adottata, sì da elidersi a vicenda e da rendere impossibile l'individuazione del procedimento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 3286 dell'11 giugno 1979; Id., Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 4 giugno 2001), occorre rilevare che, quanto al vizio di contraddittorietà insanabile, la censura non rispetta il canone di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., essendo stata omessa la trascrizione delle proposizioni testuali tratte dalla sentenza impugnata e tali per cui non potrebbe in alcun modo individuarsi la ratio decidendi su cui è fondata la decisione di rigetto della domanda risarcitoria (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 2 marzo 2012), non assolvendo all'indicato requisito di ammissibilità la riproduzione del contenuto parziale della "relazione" dell'organo ispettivo del Ministero della Giustizia, della quale non [è] dato rinvenire alcun riferimento nel testo della sentenza impugnata. Occorre rilevare, peraltro, come alcun elemento di contraddittorietà logica sia dato ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata sul presupposto della accertata - successivamente - infondatezza delle ipotesi di reato oggetto delle indagini preliminari e delle irregolarità deontologiche oggetto della ispezione ministeriale, atteso che la verifica del rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale dell'esercizio del diritto di critica va eseguita attraverso una valutazione della condotta del giornalista da compiersi al momento della pubblicazione dell'articolo di stampa, risultando irrilevanti a tal fine elementi istruttori (atti e documenti) formatisi in tempo successivo (cfr. Corte cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12013 del 16 maggio 2017).
Analogamente si palesa inammissibile la censura di "mera apparenza" della motivazione della sentenza di appello, atteso che, se - da un lato - il provvedimento risulta corredato di adeguato sviluppo argomentativo sui diversi elementi costitutivi del diritto di cronaca e critica, dall'altro lato il ricorrente imposta la censura alla sentenza impugnata interamente sul piano del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, tendendo ancora una volta ad affermare la tesi secondo cui il giornalista avrebbe dovuto meglio illustrare i termini della questione, acquisire ulteriori notizie e quindi pervenire alla formazione di una diversa opinione sui fatti: e come si è già rilevato la migliore o peggiore qualità argomentativa logica della critica svolta dal giornalista esula dal controllo demandato a questa Corte circoscritto alla osservanza dei limiti (continenza formale e sostanziale; verità oggettiva del fatto narrato) entro i quali trova applicazione la scriminante di cui all'art. 51 c.p.
Terzo motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di verificare la esistenza del requisito dell'"interesse pubblico" alla conoscenza della notizia, quanto alla divulgazione del nome del magistrato che aveva ricevuto la telefonata, e dell'"interesse pubblico" alla conoscenza della opinione espressa sul punto dal giornalista.
Ferma la inammissibilità della censura quanto al secondo profilo, non risultando indicato nel motivo alcun "fatto storico decisivo" omesso nella attività di rilevazione e ponderazione delle prove da parte del Giudice di appello, il motivo si palesa infondato anche in relazione all'altra censura concernente la indicazione nell'articolo di stampa del "nome di battesimo" del magistrato destinatario della telefonata, tenuto conto che il Giudice territoriale ha esaminato il testo dell'articolo di stampa in cui veniva riferito il contenuto della intercettazione telefonica riportato nella nota informativa dei Carabinieri, ed ha verificato che quanto riportato dal giornalista corrispondeva a tale contenuto senza alcuna alterazione, con ciò ritenendo verificato l'interesse pubblico alla conoscenza della informativa di PG e della conversazione telefonica nella sua integralità, escludendo una diversa modulazione del predetto requisito di continenza sostanziale in re[l]azione a singole parole o singoli elementi del contenuto divulgato. Pertanto la Corte d'appello: a) non ha omesso di rilevare e considerare il fatto indicato, ma ha formato il proprio giudizio in ordine alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica anche in relazione a tale fatto, in quanto risultante dal documento esaminato: la critica formulata dal ricorrente eccede, quindi, i limiti di deducibilità del vizio motivazionale consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis alla presente controversia, in quanto viene a contestare non la omessa considerazione di un fatto storico decisivo, quanto piuttosto la sufficienza logica del ragionamento nell'accertamento della scriminante, laddove il Giudice di merito ha ritenuto sussistere il requisito dell'interesse pubblico alla notizia, comprensiva anche della indicazione del nome di battesimo dell'interlocutore telefonico; b) l'assunto difensivo secondo cui il nome di battesimo eccedeva l'interesse pubblico della notizia, oltre a risolversi in una censura di merito, inammissibile, collide con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso ricorrente, tenuto conto che, nella specie, il nominativo non appare frutto di autonoma ricerca del giornalista, ma risulta direttamente dalla trascrizione della intercettazione telefonica e che, in tema di cronaca giornalistica, ricorre l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta "pertinenza"), nonostante il coinvolgimento di persona estranea al procedimento penale, qualora la notizia emergente dall'atto venga pubblicata come parte di un'informazione sulla vicenda penale riguardante l'indagato e non attenga a fatti del tutto eccentrici o privi di similarità e di identità di termini e contenuto rispetto a quelli oggetto del procedimento penale (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 21404 del 10 ottobre 2014), non essendo stata, peraltro, neppure allegata dal ricorrente la ipotesi di una capziosa scelta, operata dal giornalista, nel riportare "soltanto" il nome di quell'interlocutore telefonico e non anche di altri, giacché non risulta in alcun modo provato che fossero emersi anche altri nomi dalle altre intercettazioni telefoniche riportate nella informativa di PG.
Quarto motivo: violazione dell'art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura pare rivolta alla asserita violazione da parte della Corte distrettuale del "principio di non contestazione" in quanto i convenuti in primo grado non avevano specificamente controdedotto all'affermazione, contenuta nell'atto di citazione, secondo cui la Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, presso la quale per diversi anni era rimasto in servizio il magistrato, aveva applicato rigorosamente il criterio di rotazione degli incarichi professionali.
Il motivo è inammissibile in quanto diretto a disconoscere - ma con argomento a posteriori - la fondatezza della opinione critica manifestata dal giornalista in ordine alla nota intercettazione telefonica al tempo della pubblicazione dell'articolo sul periodico L'Espresso.
Come noto la verifica della illiceità della condotta lesiva della reputazione altrui commessa con il mezzo della stampa deve essere compiuta, tanto con riferimento alla pubblicazione della notizia, quanto con riferimento alla espressione della opinione critica su detta notizia, in relazione ai fatti noti al tempo della pubblicazione, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi (cfr. Corte cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12013 del 16 maggio 2017; vedi: Corte cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11233 del 9 maggio 2017).
È del tutto evidente l'errore logico in cui cade il difensore del ricorrente laddove confonde la valutazione postuma dei fatti, risultante dall'accertamento ispettivo e dalla non contestazione delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, con le possibili diverse interpretazioni formulabili ex ante, cui il fatto riferito nella sua verità oggettiva poteva dare adito.
Del tutto inconferenti appaiono inoltre le argomentazioni svolte nella esposizione del motivo in ordine alla verità oggettiva che è requisito attinente al fatto-notizia e non alla opinione critica.
Quinto motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.; art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Settimo motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 185 e 684 c.p.; art. 74 c.p.p.; artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nono motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 684 c.p., 114 e 116 c.p.p. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con i motivi in esame il ricorrente censura, in relazione a diversi profili di legittimità, la statuizione della sentenza di appello secondo cui non era stata fornita prova che la informativa dei Carabinieri, recante la trascrizione della intercettazione telefonica, fosse atto coperto dal segreto e comunque atto soggetto a divieto di pubblicazione.
I motivi possono essere oggetto di esame unitario vertendo tutti sulla questione concernente la segretezza ovvero la non pubblicabilità della informativa di PG recante il contenuto della intercettazione telefonica.
A) La Corte d'appello ha statuito che i contenuti delle intercettazioni erano stati portati a conoscenza degli indagati anteriormente alla pubblicazione dell'articolo, essendo state ordinate perquisizioni domiciliari e sequestri, oggetto di richiesta di riesame da parte dei difensori. Sostiene il ricorrente che tale pronuncia avrebbe accolto la relativa eccezione in senso stretto formulata dagli appellati per la prima volta nella comparsa di risposta in secondo grado e dunque in quanto tale inammissibile, stante il divieto alla proposizione di nuove eccezioni disposto dall'art. 345 c.p.c.
La censura (quinto motivo) non coglie nel segno, tenuto conto che nell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. la connotazione di illiceità della condotta in quanto non jure rientra nei fatti costitutivi della pretesa, la prova dei quali grava su colui che agisce in giudizio. Consegue che, nella specie, non si verte in tema di eccezione di merito in senso stretto, quanto piuttosto di contestazione del fatto allegato a sostegno della pretesa, potendo peraltro rilevarsi, ad abundantiam, che dalla trascrizione parziale delle deduzioni svolte nella comparsa di primo grado (riprodotte nello stesso ricorso, pag. 31), emerge che i convenuti - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - avevano contestato, inequivocamente, che l'atto di informativa della PG fosse coperto da segreto, assumendo che "alla data di pubblicazione dell'articolo... i contenuti delle intercettazioni erano conosciuti o conoscibili dagli imputati".
B) La Corte d'appello, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che la segretezza dell'atto di informativa di PG doveva ritenersi incontestata ed il Giudice di merito, comunque, avrebbe operato una non consentita praesumptio de praesumpto, operando la inferenza della conoscibilità da parte del giornalista della informativa di PG sulla base di atti delle indagini preliminari dei quali non era stata fornita prova.
La censura (sesto motivo) è infondata.
Se, da un lato, - come rilevato nell'esame della precedente censura - il fatto della segretezza dell'atto risulta al contrario contestato dai convenuti fin dal primo grado di giudizio, dall'altro il vizio di error juris dedotto in ordine alla violazione dello schema legale della prova presuntiva, viene a fondarsi sul presupposto della inesistenza del fatto certo (adozione di provvedimenti relativi alle indagini preliminari notificati agli indagati) da cui operare la inferenza cognitiva, che risulta smentita dalla sentenza di appello, avendo la Corte territoriale accertato in base alla documentazione prodotta in giudizio che i provvedimenti vennero invece emessi (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 5: "dagli atti risulta anche che nel luglio 2005 sulla base della detta informativa furono ordinate perquisizioni e sequestri"). Qualora il ricorrente avesse invece inteso contestare l'errore commesso dal Giudice di appello circa la esistenza agli atti del giudizio di merito della prova del fatto che nel "luglio 2005" fossero stati emessi i provvedimenti di ricerca della prova, risulta evidente allora come la censura non investa la questione di diritto della corretta applicazione dello schema legale della prova presuntiva, né la questione di fatto dell'omesso esame di un fatto decisivo, venendo piuttosto a configurarsi, eventualmente, un vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., non deducibile con il ricorso per cassazione.
Deve ritenersi, pertanto, irrilevante l'errore di fatto (censurato con il settimo motivo) commesso dal Giudice di appello nel rilevare che la richiesta di estrazione di copia degli atti del fascicolo penale, effettuata dal difensore di uno degli indagati, era antecedente la pubblicazione in data 8 settembre 2005 dell'articolo di stampa, quando invece risultava essere stata formulata solo successivamente in data [omissis] 2005, non incrinando tale errore l'argomento logico per cui le richieste di riesame - pur se successivamente proposte dai difensori - rendevano plausibile che nella motivazione dei provvedimenti impugnati, notificati agli indagati, fosse stato trasfuso il contenuto della informativa di PG in cui era riprodotta anche la conversazione telefonica intercettata.
C) Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello aveva omesso di considerare che la violazione del divieto di pubblicazione degli atti della indagine penale integrava il reato di cui all'art. 684 c.p. anche nel caso di trascrizione del contenuto o di riproduzione testuale di un atto di indagine "non coperto da segreto", e che pertanto la divulgazione del contenuto della intercettazione telefonica comportava la fondatezza della pretesa risarcitoria per danno alla reputazione, non trovando applicazione l'art. 114, comma 7, c.p.p. atteso che il giornalista non si era limitato a riassumere il contenuto della informativa ma ne aveva riprodotto - in parte - il testo (in virgolettato). Sostiene, inoltre, il ricorrente che, anche nel caso in cui non volesse riconoscersi al reato di cui all'art. 684 c.p.p. natura "plurioffensiva" dovendo escludersi una piena sovrapposizione tra l'illecito penale e la fattispecie illecita diffamatoria fonte di responsabilità civile, in ogni caso la acquisizione della informazione inerente l'atto di indagine era da ritenersi illecita, in quanto compiuta in violazione della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003), e comportava, dunque, un danno risarcibile, come affermato nel precedente della Corte di legittimità n. 17602/2013.
Le censure (ottavo e nono motivo) sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
Le Sezioni unite di questa Corte, venendo a risolvere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto maggiormente aderente al sistema di bilanciamento degli interessi contrapposti, entrambi di rilevanza costituzionale (assicurare l'osservanza dei principi fondamentali del processo accusatorio e garantire la libertà di manifestazione del pensiero), una interpretazione degli artt. 684 c.p. e degli artt. 114 e 329 c.p.p. che, facendo perno sull'ultimo comma dell'art. 114 c.p.p. ("È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto") e sullo scopo perseguito dal Legislatore - come evidenziato nella Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale -, viene ad individuare il bene protetto dalla norma penale incriminatrice nella lesione dell'interesse pubblico a non pregiudicare i risultati delle indagini preliminari e ad evitare (consentendo la pubblica[zione] del "contenuto", ma non anche la "riproduzione testuale" dell'atto non coperto da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine della udienza preliminare) "la cristallizzazione di pre-giudizi del giudice del dibattimento".
Dalla qualificazione del reato in questione come "monoffensivo" deriva la conseguenza che "nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione della norma incriminatrice in discorso [art. 684 c.p.], salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento", con l'ulteriore precisazione che "la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio penalistico di necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore, nonché, sul piano civilistico, di quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità, espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. di tolleranza della lesione minima, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata" (cfr. Corte cass., Sez. un., Sentenza n. 3727 del 25 febbraio 2016).
Pertanto, anche a seguire la tesi difensiva del ricorrente secondo cui, pur considerando l'atto di indagine preliminare non più coperto da segreto ex art. 329, comma 1, c.p.p., il giornalista avrebbe comunque violato l'art. 684 c.p. riproducendo - parzialmente - testualmente l'atto di informativa di PG recante la trascrizione della intercettazione telefonica (la frase virgolettata, trascritta nell'articolo di stampa, è riportata in ricorso alla pag. 43), la violazione della norma penale non sarebbe ex se sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, atteso che - in ogni caso - la verifica della lesione della reputazione personale e l'affermazione della responsabilità civile per danno, in quanto concernente un diverso bene rispetto alla tutela dell'interesse pubblico cui si riferisce il precetto penale di divieto, deve necessariamente transitare per un ulteriore e distinto accertamento giudiziale, inteso a valutare la effettiva idoneità offensiva della pubblicazione - totale o parziale - del "testo" dell'atto di indagine riprodotto nell'articolo di stampa. Tale diversa considerazione degli interessi pubblici (alla corretta amministrazione della giustizia, alla imparzialità del giudice, alla efficienza della attività di indagine) e privati (alla dignità ed alla reputazione personale) coinvolti nella medesima vicenda della pubblicazione del contenuto (o della riproduzione testuale) di atti della indagine penale, e la esigenza di un distinto accertamento giudiziale in relazione a ciascuno di detti interessi (sì che accertato l'illecito penale, per ciò stesso non può ritenersi integrata l'offesa alla personale reputazione delle persone coinvolte nella indagine), trova pieno riscontro anche nella giurisprudenza del Giudice di Strasburgo: cfr. Corte EDU, sentenza in data 1° luglio 2014, causa A.B. c. Suisse, ricorso n. 56925/08; Id., sentenza in data 29 marzo 2016, causa Bédat c. Suisse, ricorso n. 56925/08; Id., sentenza in data 6 giugno 2O17, causa Y c. Suisse, ricorso n. 22998/13.
Orbene osserva il Collegio che, da un lato, il ricorrente ha omesso del tutto di specificare se la questione inerente la "riproduzione testuale" parziale (di una sola proposizione estratta dalla intercettazione della conversazione telefonica) dell'atto di indagine, oltre che quella - oggettivamente diversa - della illecita "divulgazione del contenuto" dell'atto di indagine, abbia costituito oggetto di puntuale allegazione nell'atto introduttivo del giudizio quale condotta materiale integrante i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, impedendo così di verificare se anche la predetta questione fosse ritualmente ricompresa nell'originario thema controversum e - ove dedotta con puntuale motivo di gravame - nell'oggetto devoluto alla cognizione del Giudice del gravame, non potendo, pertanto, ritenersi superato il rilievo della novità della questione preclusivo dell'accesso al sindacato di legittimità. Dall'altro lato la censura appare comunque infondata, atteso che il Giudice di appello ha valutato l'illecito diffamatorio in relazione anche al contenuto della intercettazione telefonica (integralmente richiamato nella comparsa di risposta degli appellati: cfr. ricorso cassazione pag. 18, nota 1), venendo a concludere nel merito sia per il legittimo esercizio del diritto di cronaca in relazione alla sussistenza del requisito della verità oggettiva, sia in relazione all'esercizio del diritto di critica avendo ravvisato nella specie la continenza sostanziale (ossia la "pertinenza" delle riflessioni svolte nell'articolo all'interesse pubblico della notizia) e quella formale (concernente le modalità espressive), avendo escluso la Corte distrettuale che l'articolo di stampa contenesse un gratuito ed ingiustificato attacco, privo di alcun collegamento con i fatti narrati, all'onore ed alla reputazione del magistrato. Su tale accertamento di merito, non può essere richiesta una revisione delle valutazioni riservate in via esclusiva alla Corte territoriale, le cui statuizioni, come rilevato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, vanno esenti dai vizi di legittimità denunciati.
Decimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 684 c.p., 114 c.p.p., 2050 c.c., dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003.
Il ricorrente ha impugnato la statuizione della sentenza della Corte d'appello con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della Giustizia per illecito trattamento dei dati personali (tale essendo il contenuto della intercettazione telefonica) in violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, sebbene alcuna prova liberatoria fosse stata fornita dall'Amministrazione statale in ordine all'adempimento dell'obbligo di custodia e controllo dei dati in suo possesso ed alla adozione di tutte le misure idonee ad evitare il rischio di danni alla persona cui si riferiscono i dati trattati. Secondo il ricorrente l'argomento a supporto della decisione impugnata secondo cui l'atto di indagine era stato legittimamente utilizzato nell'esercizio della attività ispettiva condotta dal Ministero, era inficiato dalla errata affermazione che il contenuto dell'atto fosse pubblicabile e che "quanto riportato nell'articolo costituisse una mera pubblicazione del contenuto dell'atto e non del suo contenuto".
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello si è limitata ad accertare che, venuta meno la segretezza dell'atto di indagine - in quanto trasfuso nei decreti di perquisizione e sequestro notificati e quindi venuti a conoscenza degli indagati -, doveva ritenersi legittimo l'utilizzo del contenuto della informativa di PG recante la trascrizione della intercettazione telefonica ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva.
Nella esposizione del motivo di ricorso, non viene adeguatamente descritta la vicenda processuale, in quanto non [è] dato individuare se l'illecito contestato alla Amministrazione statale avesse ad oggetto l'asserito illegittimo utilizzo della informativa di PG da parte degli ispettori ministeriali, trattandosi di atto coperto da segreto istruttorio - fatto sul quale soltanto si è pronunciato il Giudice di appello -, o invece la diversa condotta illecita relativa alla mancata adozione da parte del Ministero delle misure di custodia e controllo dei dati trattati (trascrizioni della intercettazione telefonica) atte ad impedire la indebita divulgazione dei dati al giornalista ad opera di funzionari infedeli - fatto in ordine al quale la Corte d'appello non ha pronunciato -, venendo quindi a palesarsi una inemendabile incertezza che si riflette evidentemente sulla carenza del requisito di specificità del motivo che deve essere ritenuto, conseguentemente, inammissibile, tenuto conto, in ogni caso, che la prima censura sarebbe comunque infondata, essendo risultata indenne la sentenza impugnata dai vizi di legittimità denunciati in punto di accertamento della cessazione della segretezza dell'atto di indagine con la notifica agli indagati dei provvedimenti di perquisizione e sequestro preventivo; mentre la seconda censura attinente la violazione delle norme del d.lgs. n. 196/2003 sarebbe comunque inammissibile sotto il duplice profilo della errata individuazione del parametro normativo assegnato al sindacato di legittimità (non avendo la Corte distrettuale affatto pronunciato sulla questione, la omessa pronuncia andava impugnata per vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.) ed ancora prima per novità della questione, non avendo il ricorrente specificato se e quando la condotta illecita integrante la violazione delle norme del d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, fosse stata ritualmente dedotta con gli atti difensivi fin dal primo grado di giudizio, rimanendo in conseguenza precluso l'esame della censura per novità.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella sentenza.