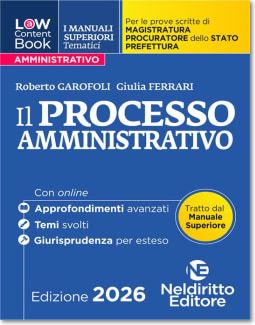Corte dei conti
Sezione I centrale d'appello
Sentenza 3 febbraio 2021, n. 22
Presidente: Lasalvia - Estensore: Bussi
FATTO
Con atto d'appello, nell'interesse di Vincenzo Giuseppe G., è stato promosso giudizio di impugnazione verso la sentenza non definitiva n. 265 del 26 ottobre 2017 e la sentenza n. 378 del 22 novembre 2018 della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria con le quali, previo rigetto delle questioni pregiudiziali e preliminari proposte in sede difensiva, il medesimo è stato condannato a rifondere il Ministero della Giustizia per la somma di euro 113.970,00.
L'Ufficio requirente aveva citato a titolo di danno all'immagine l'appellante, in qualità di Presidente della Sezione misure cautelari del Tribunale di Reggio Calabria, per aver tenuto una condotta illecita, integrante i reati di corruzione, di rivelazione di segreto d'ufficio e di favoreggiamento personale, già oggetto di sentenza penale.
Dette condotte delittuose, per la Procura, avevano avuto ampia diffusione - anche mediatica - recando un danno al prestigio e alla credibilità dell'istituzione, presso cui il convenuto ricopriva il ruolo di Magistrato.
Con il gravame indicato in epigrafe, sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
1) inammissibilità dell'azione per estinzione dell'obbligo risarcitorio per via della sua natura di effetto penale della sentenza di condanna.
L'appellante ha richiamato a conforto della propria prospettazione giurisprudenza ordinaria e contabile, la quale deporrebbe nel senso della stretta correlazione della fattispecie erariale rispetto agli accertamenti di reato. Da ciò discenderebbe l'applicazione dell'art. 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario con estinzione degli effetti penali della condanna per essersi verificata la condizione ivi prevista (esito positivo dell'affidamento in prova) e la conseguente inammissibilità dell'azione in questa sede. Inoltre, la misura risarcitoria sarebbe in contrasto con il diritto eurounitario, nel quale è sancito il principio fondamentale del ne bis in idem, come elaborato nel tempo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui precedenti sono stati riportati in modo articolato. L'istituto del danno all'immagine, indissolubilmente connesso alla condanna per un fatto delittuoso, contribuirebbe ad ampliare in modo significativo l'afflittività della risposta statale alle condotte incriminate.
2) Erroneità dei parametri fattuali ai quali è stato collegato il clamore mediatico.
Sul punto, nel rilevare l'illegittimità dell'interpretazione seguita nel provvedimento impugnato, perché non avrebbe tenuto conto dei criteri di verità, di pertinenza e di continenza che rendono corretto l'esercizio del diritto di cronaca, è stata evidenziata una serie di imprecisioni che riguarderebbero il concreto comportamento dell'appellante, rispetto alle notizie riportate sugli articoli di stampa posti a fondamento dell'avversata pronuncia.
3) Illegittimità della decisione in relazione ai criteri di calcolo del danno.
L'esito del giudizio sarebbe censurabile oltre che per non aver escluso dal computo l'incidenza del delitto di favoreggiamento, che sulla base della formulazione dell'art. 7 della l. 97/2001 non rientrerebbe tra le fattispecie considerate, anche per aver adoperato a tal fine un elemento esterno, costituito dal presunto maggiore trattamento retributivo realizzato dal coniuge dell'appellante a titolo di contropartita, in realtà rimasto estraneo alla vicenda corruttiva.
4) Congiunta al precedente motivo è anche la lamentata illegittimità in relazione al mancato riconoscimento della regola del doppio, in applicazione del meccanismo di quantificazione introdotto dall'art. 1, comma 1-sexies, della l. 190/2012, ritenendo erroneamente che la disposizione avesse natura sostanziale e non processuale. Comunque, la determinazione del danno andrebbe fatta in via equitativa, considerando l'effettiva utilitas prodotta dal comportamento dell'appellante e le gravi conseguenze già subite dallo stesso (sia in termini di perdita di attività lavorativa e conseguente retribuzione e sia in termini pensionistici).
5) Illegittimità della condanna alle spese.
La Procura generale, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello, ha osservato quanto segue:
- con riguardo all'invocata violazione del principio fondamentale del ne bis in idem, è stato considerato che nella giurisprudenza europea e nazionale trova conferma il rapporto di reciproca autonomia tra giudizio di responsabilità civile in sede penale e giudizio di responsabilità erariale. È stato, altresì, confutato che l'obbligo risarcitorio de quo possa essere inquadrato nel novero degli effetti penali nel senso voluto dall'appellante;
- in merito all'effettivo clamor fori, è stato precisato che il danno all'immagine è correlato al discredito derivante dalla conoscenza che la collettività ha dell'agire illecito del funzionario infedele e tale fattore costituisce uno degli indici di riferimento per la sua quantificazione. Gli episodi resi noti sono gli stessi che hanno dato luogo alla condanna penale, come risulta dagli articoli di stampa che vengono richiamati;
- sulla quantificazione del danno, in ordine al metodo individuato dalla legge 190 del 2012, è stata esclusa l'applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, in quanto limitata all'ambito penalistico, e affermata la natura sostanziale e non processuale della disposizione. Il Giudice di primo grado avrebbe correttamente proceduto alla valutazione in via equitativa, in base ai parametri seguiti dalla giurisprudenza.
All'udienza del 29 ottobre, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La fattispecie oggetto della decisione di cui si chiede il riesame attiene alla responsabilità erariale ascritta all'appellante per il danno da perdita di immagine causato all'amministrazione di appartenenza, in costanza di reati accertati in via definitiva.
Le ragioni addotte a sostegno del gravame, per quanto concerne i diversi profili pregiudiziali e preliminari, nonché attinenti al merito, delle due sentenze indicate, salve le precisazioni di seguito esposte, sono infondate e, in quanto tali, non possono che condurre al rigetto.
1) Alcun esito positivo, nei termini richiesti dall'appellante, può sortire la prospettata questione delle interferenze tra gli effetti penali della condanna e i doveri risarcitori derivanti dall'azione in rassegna, al fine di ritenere che il relativo obbligo sia posto nel nulla dall'estinzione prevista dall'art. 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario, e ciò a seguito del superamento del periodo di affidamento in prova. Tantomeno potrebbe ammettersi il pur sostenuto travolgimento del decisum per violazione del principio del ne bis in idem, per mancato rispetto dei canoni di proporzionalità e di equilibrio del trattamento sanzionatorio complessivo.
Su tale ultimo punto, la pronuncia in esame non presenta le carenze o i vizi motivazionali denunciati e pertanto la doglianza non appare meritevole di accoglimento, in ragione della pluriacclarata autonomia e indipendenza dei due ambiti giurisdizionali - penale ed erariale - ciascuno dei quali diretto ad accertare i fatti costitutivi delle distinte responsabilità che ne costituiscono l'oggetto, sulla base di regole e di presupposti differenti.
Nel caso di specie, infatti, non può essere invocato detto divieto - del ne bis in idem - nell'accezione recepita dall'ordinamento europeo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) richiamata dall'interessato. Le relative disposizioni hanno una funzione circoscritta all'alveo penale e non attingono, nei termini rappresentati, alla sfera erariale, come confermato con la sentenza CEDU del 13 maggio 2014, emessa su ricorso n. 20148/09, che ha ammesso la natura risarcitoria e sui generis di tale forma di responsabilità rispetto a quella derivante da reato, avente carattere prettamente punitivo.
Simili considerazioni valgono a escludere ogni sovrapposizione anche sul piano delle conseguenze che derivano dal diverso regime di esecuzione delle decisioni emesse entro i rispettivi confini giudiziali.
Sullo specifico aspetto, nella sentenza in esame, sono stati chiaramente tratteggiati i punti di contatto, stabiliti per legge, tra l'azione per danno all'immagine e la condanna definitiva in sede penale, che ne diviene il presupposto di proponibilità (l'art. 51 del c.g.c. ha confermato l'assetto precedentemente in vigore con l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. 102 del 2009). Al netto di tale caratteristica, il ripristino dell'ordine violato attraverso la condotta illecita contestata, cui mirano i due meccanismi di reazione, non è in nessun modo equiparabile, avendo a oggetto la tutela di valori diversi, tutti ritenuti indispensabili ai fini della protezione dell'integrità dell'apparato pubblico.
Le ipotesi delittuose vagliate - artt. 319 e 326 c.p. - hanno un comune denominatore, costituito dall'esigenza di salvaguardare il buon andamento della funzione pubblica, compromesso dalla commissione di reati, quali quelli di specie, che ne attentano ai contenuti o agli scopi. In entrambi i casi, la repressione penale si basa essenzialmente sulla violazione dei doveri di ufficio, alla stessa stregua dell'azione per danno all'immagine che ne consegue. Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello, l'offesa al prestigio e alla credibilità dell'ente pubblico è, innanzitutto, determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà ai doveri d'ufficio posta in essere mediante comportamenti aventi rilievo penale (ex plurimis, Sez. II App., n. 271/2017).
Da ciò scaturisce che l'obbligo risarcitorio volto a riparare la lesione all'immagine non può in alcun modo essere incluso nel novero degli effetti penali della condanna, dando invece luogo a una distinta fattispecie che ha risvolti patrimoniali e pecuniari propri, discendenti dall'esercizio - eventuale - dell'azione erariale e giammai originati in automatico, ovvero ope legis dalle risultanze penali.
Concisamente, solo per completezza, si può aggiungere che, in disparte il tenore letterale dell'espressione "effetti penali della condanna", che ne evidenzia la natura endogena al sistema di riferimento, la misura economica a carico del danneggiante e a favore del danneggiato non costituisce un semplice risvolto di una condanna inflitta per violazione della legge penale, ma ha quale sostrato il principio che si proceda al ristoro patrimoniale del torto arrecato ad altro soggetto, seppure dai contorni affatto peculiari.
In definitiva, per quanto argomentato, i suindicati motivi di appello devono essere respinti.
2) Pari sorte va riservata alla censura sollevata dall'appellante in ordine alle motivazioni della sentenza che collegherebbero il danno all'immagine al clamore mediatico, a prescindere dai criteri, ricordati in narrativa, cui deve attenersi il diritto di cronaca.
Sul punto, il giudice di primo grado ha precisato il valore - di ulteriore prova - attribuito al clamor fori rispetto all'episodio delittuoso per cui l'appellante è stato condannato, puntualizzando che il contenuto riportato nelle testate giornalistiche non costituisce una rappresentazione ingannevole dei fatti, anche con riferimento all'asserito pericolo di confusione rispetto ad altro magistrato coinvolto nella vicenda. Questo Collegio ritiene che la ricostruzione e le valutazioni espresse dalla Sezione territoriale non siano affette dai vizi postulati; nella decisione trova sviluppo motivazionale coerente la descrizione della menomazione arrecata alla credibilità e alla reputazione dell'istituzione pubblica attraverso i gravi comportamenti sanzionati, lesivi di ambiti di azione ai quali è costantemente rivolta l'attenzione dell'opinione pubblica, particolarmente colpita da casi di infedeltà da parte di coloro che sono chiamati ad agire, in ragione della carica rivestita, a difesa della legalità.
Non è dubitabile che il vulnus prodotto nei confronti dell'ordine giudiziario, in violazione dei delicati compiti affidati all'appellante, sia tale da menomare la funzionalità dell'apparato e la sua percezione, ripercuotendosi sul sentimento di fiducia che la collettività ripone nel sistema.
È altrettanto assodato che il danno all'immagine arrecato non implica una diretta diminuzione patrimoniale, sebbene sia suscettibile di valutazione economica, e che il clamor fori rappresenta un elemento fondamentale per misurarne la portata (SS.RR. n. 10/QM/2003).
Non occorre soffermarsi oltre sulla collocazione sistematica della tipologia di offesa, alla luce della parabola interpretativa che ha interessato l'istituto, nella sua differente qualificazione, nel tempo, come danno-evento o danno-conseguenza, per avvalorare quanto detto, non venendo in particolare rilievo nel contesto reclamato.
Su questo profilo, condivisibilmente con quanto osservato dalla stessa Procura generale nelle conclusioni scritte, i fatti resi noti - anche attraverso stampa o media - concorrono a dare contezza del grado di diffusione della conoscenza dell'illecito, che per altro sarebbe sufficiente a realizzare il discredito anche se fosse rimasta circoscritta in una sfera più ristretta.
3) Con riguardo al terzo motivo di gravame, merita soffermarsi sull'obiezione avanzata dall'interessato sull'estraneità alla vicenda corruttiva, penalmente sanzionata, del parametro posto alla base del calcolo, costituito dalla maggiorazione retributiva per l'incarico ricoperto dal proprio coniuge.
Al proposito, ampie e articolate appaiono le ragioni enunciate dal Giudice di primo grado, non suscettibili di essere superate dalle doglianze espresse nella sede di gravame.
Nella stessa sentenza della Corte di cassazione sono state delineate le condotte incriminate, sia per quanto riguarda la divulgazione di notizie riservate, sia per ciò che attiene al sinallagma corruttivo ascritto al responsabile, in cui nella comunicazione di "notizie riservate utili" - al coimputato concorrente - è stata identificata la violazione delle funzioni. Si apprende, altresì, dalla pronuncia della Corte d'Appello di Milano che nelle azioni integranti il reato di corruzione entra a pieno titolo l'attivazione delle leve politiche in relazione al predetto aspetto professionale del coniuge, che si connota per il comprovato do ut des, idoneo a concretizzare la fattispecie incriminatrice. L'impianto accusatorio ha trovato conferma nell'ultimo grado di giudizio, nel quale si dà atto che il patto illecito si è perfezionato, anche se la sistemazione lavorativa non è quella promessa, essa costituisce la contropartita all'atto contrario (superata dalla nomina quale Commissario dell'Azienda sanitaria).
Per altro, come chiarito dalla stessa Procura generale, il parametro in contestazione nulla ha a che vedere con l'effettività della prestazione resa dall'interessata.
In definitiva, per le ragioni evidenziate, anche il suesteso motivo di appello va rigettato, non ravvisandosi i difetti denunciati con l'atto di appello.
4) A parziali diverse conclusioni, il Collegio ritiene invece debba giungersi per quanto attiene all'ammontare del danno addebitabile, la cui quantificazione è stata oggetto di obiezione, in ragione della mancata applicazione del cosiddetto criterio del duplo, introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 190 del 2012, nonché della carenza di elementi probatori idonei a giustificare il ricorso all'apprezzamento equitativo ai sensi dell'art. 1226 del c.c.
Sostiene, infatti, l'appellante che, ove la Sezione avesse applicato la nuova normativa richiamata, la condanna non avrebbe potuto eccedere il doppio dell'utilitas oggetto di accertamento istruttorio disposto nel corso del giudizio di primo grado.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che con tale disposizione è stata introdotta una regola presuntiva, suscettibile di essere superata da prova contraria, per la determinazione dell'obbligo risarcitorio a carico del responsabile, cui si perviene raddoppiando il valore dell'utilità ottenuta contra legem.
Occorre altresì ricordare che, come chiarito dalla pronuncia delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 1/QM del 18 gennaio 2011, il danno all'immagine è sempre costituito dalla lesione al prestigio e al decoro dell'amministrazione e mai si identifica con le spese necessarie al suo ripristino.
Ciò premesso, condividendo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, sulla natura sostanziale e non processuale della norma, e dunque sui limiti degli effetti sui fatti occorsi prima della sua entrata in vigore, è necessario soffermarsi brevemente sul momento in cui si debba ritenere integrato il presupposto per la sua operatività.
Nel caso di specie, il Collegio reputa che il discrimine ai fini dell'applicazione dei criteri della disciplina in oggetto possa essere costituito non dal tempo di consumazione del reato (tempus commissi delicti), bensì da quello in cui ne è derivato detrimento all'ente, con riferimento all'intervento della sentenza irrevocabile di condanna, ma anche al verificarsi del clamore sociale, quale condizione indefettibile per dirsi realizzate le conseguenze da rifondere.
In tale prospettiva, il livello di diffusione del fatto costituente reato presso la collettività, in cui, come detto, si attua il discredito, oltre ad essere individuato quale basilare parametro di stima del danno, rappresenta, nel caso di specie, un aspetto essenziale dell'effetto pregiudizievole, come sottolineato nella stessa sentenza oggetto di gravame, in cui si evidenzia, per altro, la sua coincidenza con la propagazione mediatica della vicenda.
Nella fattispecie, diversamente da quanto rilevato dal giudice di primo grado, entrambi i momenti risultano in prevalenza successivi all'entrata in vigore della legge in parola, poiché la pubblicazione degli episodi in cui l'appellante era coinvolto, attraverso gli articoli di stampa particolarmente qualificanti, valorizzati nella stessa pronuncia, risale per lo più a data posteriore al 2012, così pure l'emanazione del provvedimento penale, con conseguente verificazione, a tale periodo, del presupposto perché si concretizzi l'ipotesi dannosa e si determini la sua risarcibilità.
Alla luce di quanto chiarito, il Collegio ritiene che l'entità della lesione oggetto di azione, tenuto conto del criterio dell'utilitas, come accertata dallo stesso giudice territoriale, debba essere determinata sulla base della regola fissata dalla l. 190 del 2012, sicuramente, per quanto attiene al reato di corruzione per il quale è stato verificato tale elemento attraverso l'accertamento istruttorio, il cui esito - pur confutato - non è stato oggetto di impugnazione per le finalità dell'accusa.
Ciò non toglie, tuttavia, che nel caso di specie, per una compiuta valutazione del danno, assuma una posizione centrale, nella dinamica complessiva degli eventi, in ragione del peculiare ufficio rivestito dall'appellante, l'ulteriore condotta gravemente punita, riguardante il reato di cui all'art. 326 c.p.
Si tratta della violazione del segreto d'ufficio, rispetto al quale sia nella sentenza della Corte d'Appello di Milano (n. 4991 del 2014), sia nella pronuncia della Corte di cassazione (n. 3027 del 2016), sono dedicate espressioni chiare sul contesto in cui si sono svolti gli avvenimenti e sul ruolo esercitato dall'imputato, contravvenendo ai doveri inerenti alla funzione e al servizio intestati.
Per tali fatti indubbiamente offensivi dell'immagine dell'amministrazione della giustizia, in misura evidentemente rimarchevole nell'ambito del comportamento imputato, in assenza di evidenze sulla valutabilità delle illecite utilità, ai fini del predetto canone presuntivo, non v'è dubbio che debba farsi ricorso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, alla valutazione equitativa del giudice, da esercitarsi secondo i parametri oggettivi, soggettivi e sociali, dettati dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003.
La funzione di tale criterio è infatti quella di sopperire alla carenza di elementi, che non attingono alla prova del danno, sotto il profilo della sua esistenza, bensì all'ammontare dello stesso, per cui comunque sono rilevabili le circostanze, invocate dalla stessa Procura e riprese nella sentenza di primo grado, per giungere a una quantificazione patrimoniale, adeguatamente compensativa del pregiudizio inferto.
Occorre allora considerare, in particolare, il risalto e la delicatezza dell'attività svolta dall'autore dell'illecito, la sua posizione funzionale, le negative ricadute in termini di credibilità dell'amministrazione rappresentata, la diffusione e la gravità dei fenomeni e la risonanza suscitata nella pubblica opinione.
Alla luce di tali criteri, atteso il carattere non circoscritto della vicenda, ma valutato altresì che comunque in coincidenza con la decisione penale di condanna il medesimo risulta cessato dalle funzioni giudiziarie, evenienza riportata negli stessi mezzi di informazione, appare congruo rideterminare il quantum addebitabile a tale titolo in euro 30.000,00, che si aggiunge all'importo già calcolato di euro 22.794,00 con riferimento alla concorrente, ma distinta, fattispecie di reato, come sopra specificata.
Nessun fondamento, infine, può riconoscersi all'ultimo motivo d'appello, volto a contestare la condanna al pagamento delle spese processuali, essendo sancito dall'art. 31 del c.g.c. il principio della soccombenza, sulla base del quale la sentenza che definisce il processo deve provvedere in ordine allo specifico aspetto.
Conclusivamente, nei limiti sinora esposti, ritenuto ogni altro motivo assorbito, il gravame deve essere parzialmente accolto nella parte relativa alla determinazione del danno ascrivibile all'appellante, con integrale conferma dei restanti capi delle sentenze oggetto di impugnazione.
Attesa la parziale riforma relativa alla determinazione dell'importo di condanna, le spese del presente grado di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando, respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 265 del 26 ottobre 2017, mentre, nei termini esposti, lo accoglie parzialmente con riguardo alla sentenza n. 378 del 22 novembre 2018 e, in riforma della stessa, condanna Vincenzo Giuseppe G. al pagamento di euro 52.794,00, oltre le somme dovute per interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado a quella di effettivo soddisfo.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.