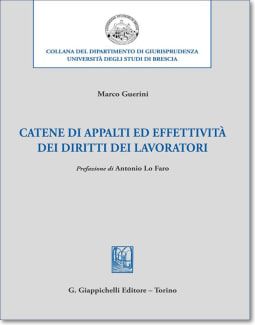Corte costituzionale
Sentenza 23 maggio 2025, n. 70
Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra il Consiglio dell'ordine degli avvocati di L. e G.L. M. con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Udita nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo».
1.1.- La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di L. avverso la sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense (CNF) aveva accolto il ricorso proposto dall'avvocato G.L. M. contro il rigetto dell'istanza di cancellazione dall'albo - avanzata in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere qualsiasi attività professionale -, opposto dal Consiglio dell'ordine in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.
La Corte di cassazione espone che il CNF aveva accolto il ricorso osservando come il professionista avesse dimostrato documentalmente le sue precarie condizioni di salute e il diritto «a fruire di trattamenti previdenziali ed assistenziali», sicché l'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione e di tutelare la dignità e i diritti fondamentali dell'istante consentivano di disporre la cancellazione, pur in pendenza di procedimento disciplinare, in via di eccezione al divieto sancito dall'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.
Il CNF - aggiunge l'ordinanza di rimessione - aveva argomentato che il godimento dei diritti fondamentali, come quello alla pensione di anzianità, la cui fruizione da parte degli avvocati è subordinata alla cancellazione dall'albo, prevale, in ragione della sua protezione costituzionale, sulla previsione dell'ordinamento forense che vieta la cancellazione in presenza di un procedimento disciplinare.
La Corte rimettente riferisce che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di L. ha affidato l'impugnazione a due motivi, con il primo dei quali ha dedotto la violazione degli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012, in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. La lettera di tali previsioni impedirebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata che introduca eccezioni al divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare ivi stabilito.
Il Consiglio dell'ordine - prosegue l'ordinanza di rimessione - ha osservato che la «ratio fondante la legittimità costituzionale della norma» risiede non solo nella necessità di scongiurare che l'istituzione ordinistica possa ricorrere alla cancellazione in via di autotutela, così compromettendo le facoltà difensive dell'incolpato, ma anche nell'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine dell'avvocatura «potenzialmente compromesse o offuscate» dalla condotta del professionista sottoposta al vaglio dell'organo disciplinare, con conseguente necessità di ripristinare il prestigio violato, anche nell'interesse generale al corretto esercizio della professione. Tali tutele sarebbero, di fatto, impedite se l'iscritto potesse eludere il procedimento disciplinare attraverso la richiesta di cancellazione.
Il giudice a quo espone che, sulla scorta di tale premessa, il ricorrente ha argomentato che la formulazione letterale della norma in esame non consente un'interpretazione che, nella prospettiva della tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, come il diritto alla salute e il «godimento delle pretese previdenziali ed assistenziali», superi la portata stessa del divieto, conseguendo un effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe produrre.
Sarebbe, pertanto, inconferente il richiamo del CNF ai propri precedenti riguardanti l'art. 17 della legge n. 247 del 2012, là dove prevede, tra le cause che giustificano la cancellazione, la sopravvenuta incompatibilità professionale, la perdita o la mancanza ab origine dei requisiti di legge, dal momento che tra dette ipotesi non rientra la compromissione dello stato di salute, non essendo richiesta, ai fini dell'iscrizione all'albo, alcuna certificazione sulle condizioni fisiche del professionista.
La Corte di cassazione riferisce, inoltre, che, con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione «degli artt. 1 e ss. e dell'art. 6» della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sul rilievo che «la questione della conculcazione del diritto al trattamento assistenziale e previdenziale» sarebbe stata introdotta per la prima volta con il ricorso al CNF, non avendo formato oggetto di deduzione nella precedente fase amministrativa presso il Consiglio dell'ordine.
La Corte rimettente espone che l'avvocato G.L. M. ha resistito con controricorso, ribadendo che le patologie da cui risulta affetto rendono assolutamente impossibile l'esercizio della professione, così che la sua condizione è equiparabile a quella della carenza dei requisiti di iscrizione, e che in nessun modo, al momento della proposizione dell'istanza di cancellazione, avrebbe potuto documentare la perdita del suo diritto alle provvidenze assistenziali, in quanto tale diritto sorge soltanto per effetto della cancellazione stessa, nella specie negata.
Lo stesso resistente - aggiunge l'ordinanza di rimessione - ha eccepito, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
2.- Tanto premesso, la Corte di cassazione ritiene rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 57 della legge n. 247 del 2012, là dove sancisce il divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare senza contemplare «l'ipotesi eccettuativa fondata sulla cancellazione volontaria richiesta dal professionista, impossibilitato ad esercitare l'attività professionale».
2.1.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la richiesta di cancellazione dall'albo presentata dalla parte resistente - e, quindi, la decisione sul ricorso di cui essa è oggetto - dipendono dall'esito dell'incidente di costituzionalità, posto che, se la disposizione censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il professionista, in ragione delle sue precarie condizioni di salute, pregiudizievoli allo stesso esercizio della professione, otterrebbe di essere cancellato dall'albo e su tale presupposto potrebbe «reclamare la tutela previdenziale prevista in caso di totale riduzione della capacità di esercitare la professione».
Aggiunge il Collegio rimettente che le argomentazioni del ricorrente, secondo cui l'avvocato resistente non avrebbe promosso l'«iter per la tutela previdenziale», non considerano che, ai fini della erogazione della pensione di inabilità, è necessaria la cancellazione dall'albo, come stabilito dall'art. 4, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).
Si precisa, ancora, che, nel caso in cui il divieto oggetto di censura fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo in ragione della mancata previsione di un'eccezione per l'ipotesi della cancellazione volontaria, «un'eventuale decisione additiva di principio per porre frattanto rimedio al difetto di normazione, in via d'individuazione della regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo, farebbe riespandere la libertà della persona, e del professionista, di cancellarsi dall'ordine, con decadenza dall'azione disciplinare».
2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che l'Ordine forense, al pari degli altri ordini professionali, è un ente pubblico associativo «con la precipua funzione di contemperare l'interesse pubblico - connesso al riconoscimento della funzione sociale della professione - all'esercizio della professione forense con quello interno alla categoria professionale (interesse all'ordinato e diligente esercizio della professione)».
La Corte rimettente osserva che la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti costituisce un «mezzo di imparziale autoregolamentazione interna» delle conseguenze delle condotte degli iscritti contrarie ai precetti deontologici e ostative al corretto raggiungimento dei fini istituzionali.
Il procedimento disciplinare è, infatti, diretto a «prevenire, dissuadere e al contempo sanzionare, dall'interno, violazioni di regole e valori fondanti della professione», a tutela dell'onore e «degli interessi corporativistici e anticoncorrenziali» della stessa, ma assume rilevanza anche per i terzi che si avvalgono della attività professionale, i quali, dunque, sono, a loro volta destinatari, sia pure indiretti, delle norme deontologiche.
Viene, inoltre, evidenziato che la potestà sanzionatoria ordinistica garantisce il mantenimento di uno standard di qualità minimo nell'esercizio della professione, nonché della credibilità e dell'affidabilità nella categoria.
Il rapporto che si instaura tra il professionista e l'Ordine, si afferma nell'ordinanza di rimessione, è caratterizzato, dal lato attivo, dal diritto di esercitare la professione e, dal lato passivo, da un complesso di obblighi diretti a impedire che l'attività professionale venga svolta in modo pregiudizievole per la collettività. In definitiva, la realizzazione di fini pubblici per mezzo delle professioni liberali si attua imponendo obblighi e conferendo diritti ai relativi esercenti.
Rimarca, infine, il giudice a quo che lo Stato attribuisce rilevanza pubblica all'interesse espresso dal gruppo professionale anche attraverso il riconoscimento e la regolamentazione del potere disciplinare dell'Ordine, il quale costituisce espressione di supremazia sugli iscritti.
I provvedimenti disciplinari mirano a far valere l'inosservanza dei doveri operanti all'interno della collettività professionale e «colpiscono il singolo soltanto in quanto appartenente» a essa. Per tale ragione può essere sottoposto a procedimento disciplinare e alla potestà sanzionatoria ordinistica soltanto chi sia iscritto all'albo.
2.3.- Ricostruito, quindi, il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, la Corte di cassazione richiama la propria giurisprudenza secondo cui il divieto in scrutinio trova fondamento tanto nella esigenza garantista di vietare che il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, mediante la cancellazione d'ufficio, sia privato della facoltà di difendersi, quanto nella necessità di evitare che lo stesso interessato, ottenendo la cancellazione, possa sottrarsi al procedimento disciplinare.
Il giudice a quo osserva che la duplice ratio sottesa al divieto di cancellazione non genera alcuna incompatibilità sul piano logico, posto che all'esigenza di tutelare la posizione del professionista può affiancarsi quella di assicurare anche la credibilità dell'Ordine professionale (viene citata, tra le altre, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 ottobre 2003, n. 15406).
L'ordinanza di rimessione richiama, quindi, la giurisprudenza disciplinare del CNF - costantemente orientata all'interpretazione conforme della normativa in scrutinio e a configurare un'eccezione al divieto di cancellazione ogni qual volta venga in rilievo la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato -, precisando, anzitutto, che essa non costituisce diritto vivente, in quanto non promana dall'organo giurisdizionale di legittimità.
In secondo luogo, la Corte rimettente non condivide la soluzione ermeneutica prospettata dal giudice disciplinare, ritenendo che essa travalichi il testo della disposizione censurata in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui l'onere di sperimentare un'interpretazione conforme a Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione.
La formulazione perentoria del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare - argomenta l'ordinanza di rimessione - costituisce un limite insuperabile all'interpretazione volta a ricavare dal testo normativo un'eccezione per il caso in cui tale divieto comporti la lesione di diritti fondamentali dell'interessato.
Tanto premesso, la Corte rimettente esclude la violazione dell'art. 32 Cost. eccepita dalle parti. La salute del professionista non sarebbe, infatti, pregiudicata dal divieto di cancellazione dall'albo per la durata del procedimento disciplinare, poiché, diversamente da quanto supposto dal resistente nel giudizio a quo, in tale lasso temporale l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non sarebbe tenuto a continuare a esercitare la professione, ove versi in uno stato di salute con essa incompatibile.
Secondo il giudice a quo, non è ravvisabile neppure la violazione dell'art. 38 Cost., parimenti eccepita dalle parti, posto che la tutela previdenziale del professionista rinviene la sua disciplina in fonti di normazione primaria e secondaria - queste ultime neanche scrutinabili da questa Corte - né risulta che il professionista ne abbia fatto richiesta e che questa sia stata rigettata dalla Cassa professionale.
3.- La Corte di cassazione, invece, censura l'art. 57 della legge n. 247 del 2012, come interpretato dal diritto vivente, sotto differenti profili.
La ricostruzione indicata dalla giurisprudenza di legittimità, ricomprendendo nel perimetro del divieto anche la cancellazione volontaria dall'albo - sia pure al fine di evitare che la rinuncia all'iscrizione diventi, per l'iscritto, un espediente per sottrarsi alla potestà disciplinare - introdurrebbe profili di «irragionevolezza intrinseca e incoerenza nel sistema normativo».
Osserva, al riguardo, il giudice a quo che la possibilità che il professionista, una volta cancellato, possa richiedere la reiscrizione all'albo, prevista, in via generale, dall'art. 17 della citata legge n. 247 del 2012, «non potrebbe ostare alla elisione del divieto giacché sarebbe sufficiente, per scongiurare qualsivoglia finalità meramente elusiva del professionista, un intervento normativo, de jure condendo, che introducesse, come strumento di salvaguardia, la sospensione dei termini di prescrizione dell'azione disciplinare per effetto della cancellazione volontaria, termini che riprenderebbero a decorrere con la reiscrizione all'ordine».
3.1.- Secondo la Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 2 Cost. e con la «protezione del nucleo essenziale della dignità umana» e il «pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali». La permanenza coartata nel gruppo professionale comporterebbe la lesione del diritto del professionista all'esplicazione della sua personalità «anche nell'organizzazione professionale ordinistica», nonché della sua libertà di autodeterminarsi. L'iscrizione all'albo, infatti, non costituirebbe più espressione di una «scelta di libertà» e tale imposizione si riverbererebbe «sulla sfera della personalità del professionista, nel suo complesso».
3.2.- La stessa previsione sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, per il tempo - incerto, perché non prevedibile ex ante - necessario all'«espressione della definitiva potestà disciplinare», impedirebbe all'avvocato di esercitare la libera scelta di cancellarsi dall'albo, anche nel caso in cui versi nell'assoluta impossibilità di esercitare la professione.
3.3.- La Corte di cassazione ritiene che il divieto di cancellazione - espressivo della «supremazia dell'ordine sui propri iscritti mediante l'esercizio del potere disciplinare» al fine di evitare una cancellazione strumentale ed elusiva della responsabilità disciplinare - nell'interpretazione fornitane dal diritto vivente, si riveli confliggente con «l'esercizio del diritto potestativo del professionista che, per versare nell'assoluta impossibilità di esercitare la professione di avvocato, si autodetermini alla cancellazione volontaria».
Osserva il giudice a quo che tale «interesse potestativo di instare per la cancellazione dall'Albo professionale» non dovrebbe subire condizionamenti in funzione degli interessi dell'organizzazione professionale, ancorché conformati «alla tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore all'interesse del gruppo professionale».
3.4.- L'iscrizione coattiva contrasterebbe, poi, con l'art. 4 Cost., «nel cui alveo va ricondotta l'attività del professionista, espressione di un diritto di libertà», peraltro «collocato in apicibus del testo costituzionale» e costituente la «matrice costituzionale fondamentale delle situazioni e dei rapporti che trovano svolgimento nel titolo terzo della parte prima della Carta costituzionale».
3.5.- La disposizione censurata, sancendo un divieto assoluto di cancellazione, violerebbe, altresì, l'art. 35 Cost., la cui portata generale include anche le libere professioni.
Ad avviso del giudice a quo, la permanenza coattiva nell'Ordine professionale, esclusivamente in funzione dell'esigenza pubblicistica «sottesa all'autogoverno del gruppo professionale», non tutelerebbe il professionista che, versando nella impossibilità di attendere all'attività professionale, «non sia in condizione di poter esercitare appieno il diritto dovere al lavoro in tutte le sue espressioni», e specialmente in riferimento alla capacità di adoperarsi nel rendere servizi professionali efficienti e assicurare «cognizioni tecnico-giuridiche, esperienza processuale, distaccata serenità, profusione di consigli che consentano di valutare adeguatamente le situazioni prospettate e controverse».
3.6.- L'art. 57 della legge n. 247 del 2012 si porrebbe infine in contrasto anche con l'art. 41 Cost., «per essere l'iniziativa economica privata del professionista, per effetto del divieto di cancellazione, avulsa dalla libera scelta dell'autonomo svolgimento di un'attività economica socialmente utile e in guisa da comprimere la dignità umana del professionista, quanto ai limiti enunciati nel secondo comma».
4.- Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le parti del procedimento principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012, che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo».
1.1.- Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione, nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, assurta a diritto vivente - secondo cui il divieto in questione opera non solo per la cancellazione d'ufficio, ma anche per quella «volontaria» -, violerebbe, anzitutto, l'art. 2 Cost., perché, imponendo all'avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare la permanenza forzata nell'Ordine, ne comprimerebbe la libertà di autodeterminazione e il diritto all'esplicazione della personalità «anche nell'organizzazione professionale ordinistica».
1.2.- La previsione censurata risulterebbe, poi, in contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza, in quanto, per tutto il tempo - incerto, perché «non prevedibile» - necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, precluderebbe all'iscritto la possibilità di scegliere liberamente di cancellarsi dall'albo, pur se versi in una situazione di assoluta impossibilità di esercitare la professione.
1.3.- Sarebbe, inoltre, leso il «diritto di libertà del professionista al lavoro» garantito dall'art. 4 Cost., quale «matrice costituzionale fondamentale delle situazioni e dei rapporti che trovano svolgimento nel titolo terzo della parte prima della Carta costituzionale».
1.4.- La disposizione in scrutinio contrasterebbe, altresì, con l'art. 35 Cost., in quanto, imponendo la permanenza nell'organizzazione ordinistica soltanto in funzione dell'«immanente esigenza pubblicistica sottesa all'autogoverno del gruppo professionale», priverebbe di tutela l'avvocato che, versando nell'impossibilità di attendere all'attività professionale, non sia in condizione di esercitare in modo adeguato la difesa tecnica.
1.5.- La stessa previsione violerebbe, infine, l'art. 41 Cost., dal momento che, per effetto del divieto di cancellazione, il professionista sarebbe privato della possibilità di scegliere liberamente di svolgere «un'attività economica socialmente utile», risultandone, altresì, pregiudicata la dignità umana dell'interessato.
2.- All'esame della questione di legittimità costituzionale è opportuno premettere la ricostruzione, anche in senso diacronico, del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione censurata.
2.1.- Il divieto di cui all'art. 57 della legge n. 247 del 2012, comportando un prolungamento coattivo dell'appartenenza del professionista all'Ordine per il tempo necessario all'accertamento disciplinare, si raccorda con il principio di obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Tale principio, espressione del potere dello Stato «di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici» (sentenza n. 120 del 1973), ha origini remote, rinvenendosene la prima enunciazione nell'art. 3, primo comma, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore), a mente del quale «[p]er assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore è necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge».
Successivamente, con l'introduzione dell'ordinamento corporativo ad opera della legge 3 aprile 1926, n. 563 (Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro), la regola della iscrizione necessaria all'albo fu ribadita, per la classe forense, dall'art. 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ai sensi del quale «[n]essuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale» e, per gli altri professionisti intellettuali, dall'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi).
In seguito, l'art. 2229, primo comma, del codice civile ha enunciato il principio per la generalità degli esercenti le professioni liberali, demandando alla legge la determinazione delle «professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi».
Quindi, con riguardo alla classe forense, l'art. 2, comma 3, primo periodo, della legge n. 247 del 2012 ha ribadito che «[l]'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato».
2.2.- L'iscrizione all'albo è un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista con efficacia erga omnes (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 2 agosto 2002, n. 11541; sezione lavoro, sentenza 4 aprile 1987, n. 3296) e assolve una funzione di pubblicità - dando notizia dei nominativi dei soggetti abilitati all'esercizio della professione - e di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità necessari allo svolgimento dell'attività professionale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 luglio 1977, n. 3235).
Il provvedimento di iscrizione, in particolare, va ricompreso «nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che [...] si concludono con atti denominati ammissioni» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34439).
2.2.1.- In quanto atto di ammissione, l'iscrizione è generalmente revocabile ed è suscettibile di annullamento d'ufficio.
In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012, la cancellazione d'ufficio può essere disposta, anche su richiesta del procuratore generale: a) quando venga meno uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; b) quando l'iscritto non abbia prestato il prescritto impegno solenne senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando venga accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21 della medesima legge n. 247 del 2012; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
Lo stesso comma 9 dell'art. 17 prevede, poi, che la cancellazione possa anche essere richiesta dall'avvocato in seguito alla rinuncia all'iscrizione, la quale costituisce estrinsecazione di un diritto potestativo il cui esercizio non è soggetto a requisiti e condizioni, fatta eccezione per quella dell'assenza di procedimenti disciplinari pendenti.
2.3.- L'iscrizione all'albo comporta l'assoggettamento del professionista al potere di supremazia speciale dell'istituzione ordinistica, di cui la potestà disciplinare costituisce la manifestazione più significativa.
L'Ordine, adottando il codice deontologico - che è fonte secondaria di produzione giuridica (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 maggio 2005, n. 9097) -, stabilisce i criteri di conformità dei comportamenti degli iscritti rispetto ai fini che intende perseguire (ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 marzo 2005, n. 6213), e, attraverso il potere di vigilanza, ne verifica l'osservanza.
A tale controllo può conseguire l'avvio del procedimento disciplinare che è «dominato da un impulso pubblicistico» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 ottobre 2006, n. 21734).
Esso è diretto ad assicurare l'«effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti [...] assegnati» alla categoria professionale (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 marzo 2023, n. 9114) e tutela sia il prestigio dell'Ordine in presenza di comportamenti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° dicembre 2014, n. 25369), sia «interessi generali della collettività, garantiti dall'ordinamento e connessi all'esercizio professionale» (sentenza n. 259 del 2019 di questa Corte).
2.4.- Nella cornice normativa e giurisprudenziale fin qui delineata si inserisce l'art. 57 della legge n. 247 del 2012, oggetto di censura, a mente del quale, come si è visto, «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo».
2.4.1.- Il divieto di cancellazione opera, dunque, dal giorno in cui il Consiglio dell'ordine che abbia ricevuto un esposto o una denuncia o sia venuto comunque a conoscenza di una notizia di illecito disciplinare a carico di un iscritto, dopo averne dato comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare deduzioni entro il termine di venti giorni, trasmette gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, il quale è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto del procedimento (art. 50, comma 4, della legge n. 247 del 2012).
In seguito a tale trasmissione si apre la fase istruttoria pre-procedimentale. Come previsto dall'art. 58, comma 1, della legge n. 247 del 2012, «il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità».
Se non viene disposta l'archiviazione, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, il quale comunica senza ritardo al professionista l'avvio dell'istruzione pre-procedimentale, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvedendo anche ai necessari accertamenti nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nell'apposito registro (art. 58, comma 2, della legge n. 247 del 2012).
Conclusa tale fase, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria (art. 58, comma 3, della legge n. 247 del 2012).
Quindi, ai sensi del successivo art. 59, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, il predetto consiglio, nell'ipotesi in cui approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.4.2.- Una enunciazione del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare si rinviene anche all'art. 17, comma 16, della stessa legge n. 247 del 2012 (secondo cui «[n]on si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58»), nel quale la clausola di salvezza è riferibile alla possibilità, contemplata, come ricordato, dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, della citata legge professionale, che il procedimento disciplinare si chiuda in limine con un provvedimento di archiviazione.
2.4.3.- Il medesimo divieto risulta, poi, riprodotto nell'art. 13 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (Procedimento disciplinare) - adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, comma 5, della legge n. 247 del 2012 -, a norma del quale «[d]al giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro».
2.5.- Dai lavori preparatori della legge n. 247 del 2012 emerge che, nel corso dell'iter parlamentare, il divieto in questione era stato così formulato: «[n]el caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione» (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010).
Il più rigido contenuto del testo normativo, alla fine approvato e confluito nell'art. 57 della legge n. 247 del 2012, ora in scrutinio, rivela la preoccupazione del legislatore di neutralizzare condotte elusive intese ad aggirare, mediante l'istituto della cancellazione volontaria, le esigenze di accertamento della violazione delle regole deontologiche sottostanti alla funzione disciplinare.
2.5.1.- Il contenuto della disposizione censurata ricalca quello dell'art. 37, ottavo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933, che ne costituisce l'antecedente immediato, ai sensi del quale «[n]on si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare».
2.6.- L'orientamento più risalente della giurisprudenza di legittimità individuava la ratio del divieto in esame nell'esigenza garantista di impedire che il Consiglio dell'ordine potesse ricorrere, in via di autotutela, alla misura della cancellazione d'ufficio nei confronti di un iscritto il cui comportamento fosse oggetto di accertamento disciplinare (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 ottobre 1993, n. 10382).
Successivamente, a partire dalla citata sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 15406 del 2003, la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento, attribuendo al divieto in questione portata generale e ritenendolo, pertanto, operante anche quando sia l'avvocato a rinunciare all'iscrizione.
La richiamata pronuncia - decidendo in base alla previgente versione del divieto di cancellazione recata nell'art. 37, ottavo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933 -, ha osservato che tale disposizione non distingue «tra le diverse ipotesi previste nel primo comma, tra le quali è annoverata in modo espresso anche la rinunzia dell'avvocato all'iscrizione, con la conseguenza che anche tale rinunzia non può sottrarsi al divieto emergente dal dettato normativo».
Alla nuova interpretazione del divieto di cancellazione ha dato continuità, con indirizzo costante, la giurisprudenza successiva.
In particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 16 dicembre 2005, n. 27695, ha evidenziato che il tenore testuale della disposizione in esame «non fornisce, invero, alcun appiglio testuale alla riduttiva tesi interpretativa», sottolineando come il divieto di cancellazione si fondi su due ragioni giuridiche concorrenti, tra le quali «non si configura alcuna incompatibilità, né sul piano giuridico né su quello logico», posto che «all'esigenza di tutelare la posizione del professionista ben si affianca quella di assicurare tutela anche alla credibilità dell'ordine professionale».
2.6.1.- La giurisprudenza del CNF, a propria volta, ha ricondotto il divieto di cui si tratta, riproposto dalla riforma del 2012, a due concorrenti rationes, osservando come esso non sia solo sia inteso a tutelare la credibilità dell'Ordine professionale e l'immagine dell'avvocatura, «potenzialmente compromesse o offuscate dalla condotta dell'iscritto sottoposta al giudizio dell'organo disciplinare» (Consiglio nazionale forense, sentenza 15 luglio 2020, n. 119), ma assolva anche l'«importante e complementare funzione di garanzia nei confronti del professionista vietando la cancellazione anche quale possibile forma di autotutela cui il Consiglio dell'Ordine potrebbe ricorrere nelle ipotesi in cui l'iscritto sia raggiunto da una contestazione disciplinare, compromettendone con ciò le facoltà difensive» (ancora, CNF, n. 119 del 2020).
L'organo di giustizia disciplinare, però, discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che il divieto in esame conosca due eccezioni.
La prima concerne le ipotesi di accertamento della carenza, originaria o sopravvenuta, di un requisito necessario all'iscrizione ovvero di una causa di incompatibilità, situazioni, queste, denotanti la sussistenza di un interesse pubblico alla cancellazione, prevalente su quello - parimenti pubblico - sotteso alle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012.
L'altra eccezione riguarda, invece, i casi in cui l'istanza di cancellazione si raccordi alla tutela di diritti fondamentali di rilievo costituzionale, come il diritto al lavoro o il diritto alla salute. In tale evenienza prevarrebbe l'interesse del singolo rispetto a quelli pubblici e collettivi espressi dall'ente professionale (ex aliis, Consiglio nazionale forense, sentenze 27 dicembre 2023, n. 335, 26 agosto 2020, n. 164 e 19 dicembre 2019, n. 193).
Attraverso questa interpretazione il CNF ha inteso riconoscere «preminenza della tutela di valori ed interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale, rispetto alla pur legittima esigenza, tutelata dall'ordinamento, di evitare che la cancellazione sottragga l'iscritto alla responsabilità disciplinare» (CNF, sentenza 25 marzo 2023, n. 35).
3.- Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione sollevata, deve, anzitutto, condividersi l'assunto della Corte rimettente secondo il quale la previsione in scrutinio offre una assoluta resistenza a una interpretazione conforme volta a scongiurare le ipotizzate violazioni costituzionali.
L'univoco tenore letterale della disposizione censurata non consente, infatti, di individuare, in via interpretativa, eccezioni alla sua portata, bilanciando le esigenze addotte dal professionista a sostegno dell'istanza di cancellazione con gli interessi, categoriali e superindividuali, che sorreggono la potestà disciplinare.
3.1.- Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012 sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost.
3.2.- Il divieto in esame mira a scongiurare il rischio che il professionista, rinunciando all'iscrizione, possa vanificare l'iniziativa assunta dagli organi disciplinari dell'Ordine forense.
Un meccanismo siffatto comporta, però, che, per l'intero corso del procedimento disciplinare, l'avvocato che intenda rinunciare all'iscrizione all'albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale - come la libertà di revocare l'adesione alla compagine professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa - che si esplicano attraverso la fuoriuscita dall'Ordine o che, comunque, la presuppongono.
3.3.- La disposizione censurata, restringendo, sia pure temporaneamente, la libertà dell'iscritto di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell'organizzazione professionale, contrasta, anzitutto, con l'art. 2 Cost.
3.3.1.- È pur vero che questa Corte, nel valutare la legittimità costituzionale del fenomeno ordinistico in riferimento all'art. 18 Cost., ha escluso che la libertà negativa di associarsi sia lesa dall'imposizione di obblighi di appartenenza a un organismo pubblico, evidenziando come tale sistema assicuri «lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati» (sentenza n. 40 del 1982).
Nella giurisprudenza costituzionale è stato anche affermato che non può «disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l'obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti» (sentenza n. 120 del 1973).
Il riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti una professione mira, infatti, «alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell'opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l'uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria» (ancora, sentenza n. 120 del 1973; nello stesso senso, ex aliis, sentenza n. 418 del 1996).
3.4.- Tuttavia, nella fattispecie in esame, il divieto si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo.
Alla stregua dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012, tale vincolo non può, infatti, essere reciso neppure quando l'avvocato versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l'avvenuta cancellazione dall'albo.
3.4.1.- Giova, al riguardo, ricordare che l'art. 3, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 dispone che la corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo, e la stessa giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al previgente regime dettato dal r.d.l. n. 1578 del 1933, ha affermato che la Cassa forense giustamente non riconosce il diritto al pensionamento di anzianità, che presuppone la cessazione di ogni attività professionale, in difetto della comunicazione della cancellazione dall'albo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 febbraio 1998, n. 1311).
Analoga disciplina è dettata, per la pensione di inabilità, dall'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 576 del 1980, a mente del quale «[l]a concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione» e dall'art. 73, comma 5, della delibera del Comitato dei delegati della Cassa forense 23 maggio 2024, n. 13 (Regolamento unico della previdenza forense), approvato con nota n. 36/0011063/AVV-L-205 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, il 27 settembre 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), ai sensi del quale «[l]a concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali forensi ed è sospesa in caso di nuova iscrizione agli stessi, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione».
3.5.- Il divieto in scrutinio contrasta anche con l'art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato che richieda di cancellarsi dall'albo avendo intenzione di cessare l'esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l'appartenenza all'istituzione ordinistica.
3.5.1.- Il precetto costituzionale suindicato «riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità; un diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino» (sentenza n. 61 del 1965).
3.5.2.- Nel caso di specie, la libertà, anche negativa, di lavoro risulta esposta a un sacrificio la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale davanti al CNF e alle sezioni unite della Corte di cassazione.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che «il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso [...] all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23593).
3.6.- È pur vero che, come questa Corte ha più volte chiarito, la libertà di scelta dell'attività lavorativa - sebbene costituisca un «fondamentale diritto di libertà della persona umana» (sentenza n. 45 del 1965; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 1994) - non è lesa da limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, dal momento che «ogni libertà trova contemperamenti al contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale» (ancora, sentenza n. 61 del 1965).
3.6.1.- Come già evidenziato, il congegno normativo in esame è strumentale al proficuo svolgimento della verifica della conformità della condotta del professionista ai precetti deontologici e, quindi, al corretto esercizio dell'azione disciplinare.
Tale potere è, a sua volta, funzionale alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona.
Infatti, la funzione disciplinare ordinistica non solo è orientata a salvaguardare il decoro, la dignità, il prestigio e l'integrità etica della categoria, di cui è depositario il gruppo organizzato, ma, assicurando «il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione» (sentenza n. 259 del 2019), tutela, altresì, l'affidamento che la collettività ripone nell'avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
3.7.- Tutto ciò considerato, deve, tuttavia, rilevarsi che, tra le diverse misure idonee a realizzare il pur legittimo fine del compiuto svolgimento dell'accertamento disciplinare, il divieto di cui all'art. 57 della legge n. 247 del 2012 non costituisce quella che restringe nel modo minore la libertà del professionista.
3.7.1.- Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti perché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali (ex aliis, sentenza n. 20 del 2019).
Il sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve, dunque, avvalersi anche «del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (ancora, sentenza n. 20 del 2019; nello stesso senso, ex aliis, sentenze n. 33 del 2025 e n. 88 del 2023).
3.8.- Ebbene, la disposizione censurata non supera tale vaglio, in quanto non impone, come già sottolineato, la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione, così ponendosi in contrasto altresì con l'art. 3 Cost.
Le soluzioni normative alternative a quella in scrutinio vanno individuate attraverso un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi al completamento dell'accertamento disciplinare, da un lato, e alla tutela della libertà di autodeterminazione e di lavoro del professionista, dall'altro: interessi parimenti meritevoli di adeguata valorizzazione e non comprimibili in misura eccessiva (ancora, sentenza n. 20 del 2019).
3.8.1.- Difatti, tra le misure idonee a garantire, con minor sacrificio per l'iscritto, la conservazione della potestà sanzionatoria dell'Ordine forense - e, quindi, maggiormente capaci di contemperare in modo equilibrato gli interessi in conflitto -, potrebbe ipotizzarsi, come segnalato dalla stessa Corte rimettente, la previsione di una causa di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare per l'ipotesi in cui l'avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare rinunci all'iscrizione all'albo.
È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge n. 247 del 2012, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto, ma, come previsto dal comma 3 della medesima disposizione, tale termine è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito nonché dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.
Il comma 3 dispone, inoltre, che «[d]a ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto».
Infine, nello stesso comma 3, viene puntualizzato che nel calcolo del termine di prescrizione «[n]on si computa il tempo delle eventuali sospensioni».
3.8.2.- Un analogo meccanismo diretto a scongiurare la vanificazione dell'azione disciplinare in caso di cancellazione dell'interessato dall'albo si rinviene nei lavori preparatori relativi alla legge n. 247 del 2012 e, in particolare, nella proposta di legge, sopra ricordata, in base alla quale, in caso di cancellazione dall'albo - d'ufficio o su richiesta dell'iscritto - il procedimento disciplinare pendente «rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione» (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010).
3.8.3.- Ancora, una soluzione normativa idonea a evitare che la fuoriuscita dell'avvocato dall'organizzazione professionale possa frustrare l'esercizio della potestà disciplinare potrebbe essere quella, rinvenibile nell'ordinamento del pubblico impiego, della espressa previsione della sopravvivenza del procedimento disciplinare nonostante le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente incolpato, sia pure al ricorrere di specifiche condizioni e limitatamente agli effetti compatibili con la cessazione del rapporto di servizio. Emblematiche, al riguardo, sono le ipotesi contemplate dall'art. 55-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - ai sensi del quale il procedimento disciplinare non si estingue se per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, ancorché, in tal caso, le determinazioni conclusive vengano assunte ai soli fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro - e dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo il quale «[q]ualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza».
3.8.4.- Va poi rammentato che, nell'ambito della disciplina notarile, lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del notaio non è impedito dalla dispensa dal servizio per rinuncia disciplinata dall'art. 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).
Secondo la ricostruzione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la dispensa volontaria incide, infatti, unicamente sul concreto esercizio delle funzioni notarili e non sullo status di notaio, che, una volta conseguito, permane, seppure in uno stato di quiescenza. Da ciò consegue che la dispensa per rinuncia che intervenga in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare a carico del notaio e, comunque, prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, «non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto d'interesse, in considerazione dell'incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del notaio dispensato per rinuncia» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 novembre 2018, n. 28905; negli stessi termini Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 marzo 2025, n. 5848).
3.9.- Ma non spetta a questa Corte indicare la soluzione più idonea a bilanciare gli interessi in conflitto, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta dello strumento a tal fine più adeguato.
Non si può tuttavia trascurare di sottolineare che l'ablazione del precetto all'origine dell'accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo al quale il legislatore potrà porre rimedio attraverso un congegno meno restrittivo della libertà dell'avvocato ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare almeno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo ai sensi dell'art. 17, comma 15, della legge n. 247 del 2012.
In attesa dell'intervento del legislatore, alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell'art. 57 della stessa legge n. 247 del 2012, la cancellazione dall'albo non può che comportare l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso.
All'estinzione del procedimento non si correla, però, il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può - e anzi deve - essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare.
È dunque necessario che, nelle more dell'intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l'aggiramento del segnalato principio di conservazione dell'azione disciplinare.
4.- In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.
5.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve, infine, essere estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012, il cui contenuto normativo riproduce quello dell'art. 57 della stessa legge.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.