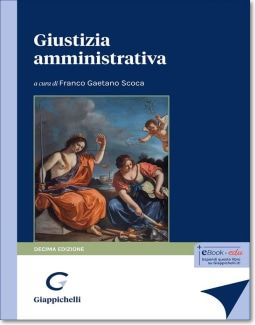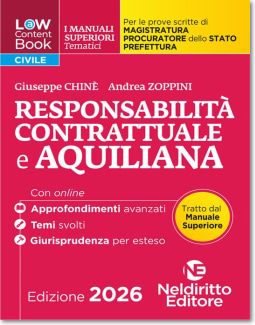Corte costituzionale
Sentenza 21 luglio 2025, n. 116
Presidente: Amoroso - Redattore: Antonini
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra R. R. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visti l'atto di costituzione di R. R., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;
uditi l'avvocato Antonio Martini per R. R. e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 4 settembre 2024, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 45 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell'autorità degli «enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza», con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Il suddetto comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 936, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), stabilisce che «[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile».
2.- Il giudice a quo deve decidere l'appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso nei confronti del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 22 agosto 2023 che, in applicazione del citato art. 12, comma 3, ha disposto lo scioglimento e la nomina del commissario liquidatore della Progetto Uomo scarl. La società cooperativa aveva infatti omesso di dare riscontro alla richiesta del revisore di prendere immediati contatti per avviare l'attività di vigilanza e alla successiva diffida, entrambe inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della società. Con lo stesso mezzo, il Ministero ha comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e, in assenza di osservazioni pervenute, ha dunque adottato il provvedimento di scioglimento.
3.- In punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, il giudice rimettente argomenta anzitutto di dovere esaminare i motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente R. R., già legale rappresentante della cooperativa, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, e dalla stessa riproposti come motivi di appello della sentenza che aveva erroneamente omesso di scrutinarli.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene non fondata la tesi secondo cui l'amministrazione non avrebbe ponderato la propria decisione con gli interessi in gioco, osservando che l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002 imporrebbe lo scioglimento dell'ente cooperativo che si sottragga alla revisione senza richiedere ulteriori verifiche, trattandosi di un «atto dovuto». Inoltre, la suddetta disposizione, nel prevedere che «[s]i applica» il provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies cod. civ., non rinvierebbe ai presupposti ivi indicati, ma, esclusivamente, al tipo di provvedimento da adottare e ai conseguenti effetti connessi, tra cui la devoluzione del patrimonio dell'ente cooperativo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
3.1.- La previsione in esame, pertanto, dettando un automatismo sanzionatorio vincolato, non conferirebbe spazi di valutazione discrezionale all'amministrazione e nemmeno si presterebbe a interpretazioni costituzionalmente orientate, le quali risulterebbero in contrasto con il dettato normativo, incentrato su una «valutazione ex ante», per cui la sottrazione all'attività di vigilanza determina automaticamente lo scioglimento.
3.2.- Inoltre, non sarebbero condivisibili le censure della omessa considerazione, da parte del provvedimento impugnato, dello stato di buona fede della appellante, nella specie non ravvisabile, e nemmeno della imputabilità dell'impedimento della revisione alla condotta illecita del commercialista incaricato per i rapporti con l'autorità amministrativa, dovendo la società rispondere dell'operato del proprio ausiliario.
3.3.- Diversamente da quanto sostenuto da quest'ultima, il giudice a quo ritiene altresì che la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002, riferendosi in generale alla sottrazione alla vigilanza, includerebbe «tutte le condotte che impedisc[o]no al revisore incaricato di accertare i requisiti mutualistici», ciò che rappresenta il fine dell'attività di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo.
3.4.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002 risulterebbero rilevanti per la definizione del giudizio, poiché ove la disposizione censurata venisse ritenuta conforme ai parametri evocati, l'appello dovrebbe essere respinto, «risultando le altre censure prive di fondamento»; al contrario, la illegittimità costituzionale della stessa «determinerebbe il venir meno della fattispecie» attributiva del potere in concreto esercitato, con conseguente accoglimento dell'appello e annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
4.- Nell'introdurre l'esposizione della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il giudice a quo segnala che, rispetto alla versione originaria della disposizione censurata - ai sensi della quale «[g]li enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione» - la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 avrebbe inasprito il trattamento sia del «mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente», sia della sottrazione dell'ente all'attività di vigilanza, «determinando anche per tale ipotesi lo scioglimento della Società Cooperativa per atto d'autorità, con obbligo di devoluzione del patrimonio».
Da ciò conseguirebbe, ad avviso del giudice rimettente, «l'applicazione di una misura (lo scioglimento e la devoluzione dei beni), che, in specie con riguardo alla sottrazione alla vigilanza ha una chiara natura meramente sanzionatoria», trattandosi «di una sanzione che, pur se non penale, assume, comunque, carattere punitivo» alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, utilizzati anche da questa Corte (della quale sono richiamate le sentenze n. 134 e n. 63 del 2019, n. 222 e n. 121 del 2018 e n. 68 del 2017). Nella specie, prescindendo dalla qualificazione formale, la natura punitiva si evincerebbe «sia in ragione della natura dell'infrazione che dalla natura o grado di severità della sanzione prevista»; in particolare, la misura in esame si connoterebbe per essere: a) «di carattere generale», non avendo «natura disciplinare»; b) dotata di «una funzione repressiva e dissuasiva e non anche risarcitoria o ripristinatoria»; c) «particolarmente afflittiva, determinando la cessazione dell'ordinaria attività» della società e l'apertura della fase finalizzata alla devoluzione del patrimonio e alla successiva estinzione dell'ente.
L'affermata «natura "punitiva" della sanzione» inciderebbe «sul controllo di proporzionalità e ragionevolezza della misura», che la giurisprudenza costituzionale ritiene applicabile anche «al settore delle sanzioni amministrative di carattere "punitivo"» (sono citate le sentenze n. 95 del 2022, n. 185 del 2021, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018).
4.1.- Su tali basi, l'ordinanza di rimessione prospetta un primo profilo di censura dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, relativo alla «proporzionalità "ordinale"», espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., violato dalla suddetta previsione che «sottopone al medesimo complessivo trattamento due ipotesi nettamente diverse sul piano del disvalore».
Infatti, la sottrazione alla vigilanza consisterebbe in una «condotta di mero impedimento delle verifiche dell'autorità amministrativa in ordine al possesso dei requisiti mutualistici a cui tali accertamenti sono finalizzati», mentre l'altra fattispecie, il mancato rispetto delle finalità mutualistiche, attesterebbe la vera e propria mancanza di queste, ovvero del «tratto caratteristico e differenziale» delle cooperative, in ragione del quale l'art. 45 Cost. riconosce a tale fenomeno la peculiare funzione sociale e solidaristica.
La natura e la tipologia della sanzione sarebbero dunque sproporzionate per la irragionevole previsione come illecita di una condotta meramente strumentale alla verifica del possesso di tali requisiti, «ma che non è, in alcun modo, indice della mancanza degli stessi».
Inoltre, la «irragionevole assimilazione» delle due ipotesi produrrebbe il «rischio (concretamente rilevato nella fattispecie oggetto del giudizio)» che persino società cooperative che esercitano la loro attività conformemente alle previsioni legali e sono, perciò, destinatarie della tutela di cui all'art. 45 Cost., «vengano sciolte per la mera sottrazione alla vigilanza, senza, quindi, accertare il possesso dei requisiti mutualistici». Pertanto, anche tale previsione costituzionale rileverebbe come parametro di legittimità costituzionale, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., quale norma che tutela i diritti incisi dalla sanzione amministrativa (è richiamata la sentenza n. 112 del 2019 di questa Corte).
4.1.1.- D'altro canto, osserva il giudice rimettente, la sanzione non potrebbe dirsi proporzionata sul rilievo che la condotta punita, «in sostanza, impedisce la verifica del possesso dei requisiti mutualistici».
Infatti, per quanto la giurisprudenza costituzionale ravvisi nella collaborazione dei privati con l'amministrazione tributaria l'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., facendo da ciò discendere «l'esigenza, per il buon funzionamento del sistema tributario, che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sia presidiata da una sanzione con un forte effetto deterrente» (è citata la sentenza di questa Corte n. 46 del 2023), tuttavia, le due situazioni non potrebbero essere ritenute «sostanzialmente identiche». Infatti, mentre l'esigenza di cooperazione sarebbe particolarmente avvertita nel sistema tributario, sia per la molteplicità dei soggetti e per la pluralità delle fattispecie impositive che vengono in rilievo, sia per la stretta connessione tra il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie e l'attuazione dei diritti costituzionali, il fenomeno cooperativo, invece, «per quanto diffuso e proteiforme», riguarderebbe un numero di società, che, «secondo un rapporto Eurisce [recte: Euricse] del 2023, era, all'epoca di 41.000 unità (escluse le organizzazioni nel settore finanziario e bancario)».
In ogni caso, la sanzione in esame non rappresenterebbe «un valido meccanismo di coazione indiretta per addivenire, comunque, all'accertamento dei requisiti mutualistici», dal momento che la previsione censurata non fa discendere dall'inadempimento dell'obbligo di sottoporsi alla vigilanza «meccanismi officiosi di verifica» - come avviene, ad esempio, nell'ipotesi di cui all'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - ma «giunge direttamente alla misura più incisiva», lo scioglimento della società, «con la conseguente "liquefazione" del nesso di strumentalità rispetto alle verifiche a cui la cooperazione del privato è finalizzata».
Inoltre, ad avviso del giudice a quo andrebbe considerata la presenza, nel sistema fiscale, di regole, come quella di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), volte a consentire una concreta e adeguata dosimetria sanzionatoria, nonché «a mitigare l'applicazione di sanzioni [...] che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano» (è citata ancora la sentenza n. 46 del 2023). In altri termini, mentre nel sistema tributario sono presenti regole che consentono di addivenire a un'applicazione proporzionata, ragionevole e adeguata delle sanzioni, nel caso in esame «questi meccanismi non sono previsti e la sanzione consegue automaticamente all'accertamento della sottrazione alla vigilanza».
4.2.- Sulla base delle considerazioni fin qui esposte l'ordinanza di rimessione ravvisa anche «la carenza di proporzionalità "cardinale" o non comparativa della sanzione prevista» dalla disposizione censurata, «intrinsecamente priva di proporzionalità e ragionevolezza», secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale che consentono uno scrutinio di proporzionalità indipendentemente dalla individuazione di un preciso tertium comparationis (sono richiamate le sentenze n. 91 del 2024, n. 136 del 2020 e n. 284 del 2019).
4.2.1.- In questa prospettiva, l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 violerebbe non soltanto gli artt. 3 e 45 Cost., ma anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. La giurisprudenza della Corte EDU, infatti, avrebbe sia «estratto dal divieto di trattament[i] inumani e degradanti ex art. 3 della Convenzione il divieto di pene "grossolanamente sproporzionate"», sia richiesto la valutazione di congruità della sanzione specialmente laddove l'attività svolta dalla persona condannata o sanzionata si inquadri nell'ambito di un diritto convenzionalmente riconosciuto, «con conseguente necessità di uno scrutinio di legittimità particolarmente stringente».
Nella specie, tale giurisprudenza assumerebbe rilievo dal momento che la sanzione in esame «incide su una situazione quale la libertà di impresa che rinviene tutela nella regola» di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
4.2.2.- La disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE; disposizioni, queste ultime, che, rispettivamente, tutelano il diritto di proprietà e sanciscono il principio della proporzionalità delle pene.
Al riguardo, l'ordinanza di rimessione osserva che, pur non potendosi nella specie disapplicare la normativa interna, in quanto l'effetto diretto del richiamato art. 49 è «limitato alla materia oggetto di normazione secondaria dell'Unione», i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alle due previsioni della Carta costituirebbero «criteri orientativi dell'interpretazione di altre garanzie costituzionali nell'intero ambito dell'ordinamento giuridico italiano» e, quindi, validi parametri di legittimità costituzionale.
4.3.- Secondo il giudice a quo, dai plurimi indici in precedenza sviluppati emergerebbe, anche alla luce dei richiamati parametri convenzionali ed eurounitari, il carattere sproporzionato e irragionevole dell'apparato sanzionatorio previsto per il caso di sottrazione alla vigilanza.
In particolare, oltre a consistere in «una misura automatica e non graduabile da parte dell'Amministrazione», la sanzione prevista è «di eccezionale severità», per una condotta che «non può neppure ritenersi sintomatica della carenza dei requisiti di mutualità che la revisione deve accertare». D'altro canto, a fronte dell'inadempimento all'obbligo di sottoporsi alla vigilanza, il legislatore non ha previsto «ulteriori strumenti» idonei a svolgere le verifiche necessarie all'accertamento dei requisiti mutualistici, se del caso mediante poteri ispettivi di carattere officioso.
Pertanto, condotte come quella oggetto del giudizio a quo - estrinsecatasi «semplicemente non dando riscontro al revisore», senza comportamenti fraudolenti - non potrebbero costituire ex se un danno per gli interessi pubblici relativi al fenomeno cooperativo, i quali, invece, sarebbero pregiudicati dalla disposizione censurata, il cui effetto sarebbe il venir meno delle attività svolte dalla cooperativa, «ledendo anche gli interessi dei soci e degli altri beneficiari» delle stesse e arrecando, in sostanza, «una "sofferenza" [...] eccessiva e, come tale, ingiusta».
4.4.- Ad avviso del giudice rimettente andrebbe, inoltre, considerato che «un sistema così draconiano» potrebbe determinare il cosiddetto chilling effect, secondo la terminologia della giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, ossia «un effetto di deterrenza» che, nella specie, non solo riguarderebbe il diritto costituzionalmente garantito alla organizzazione dell'impresa, ma coinvolgerebbe altresì gli «interessi generali del sistema cooperativistico», quali il diritto al lavoro, lo sviluppo della personalità umana e della società, la tutela della piccola proprietà, del credito e del risparmio.
Dunque, anche da questa prospettiva la misura risulterebbe irragionevole e sproporzionata, non potendosi ritenere, tra quelle in astratto ipotizzabili per ottenere l'effetto di coazione indiretta perseguito dalla norma, la meno pregiudizievole per l'esercizio di un'attività economicamente rilevante.
5.- Di qui la indicazione, da parte dell'ordinanza di rimessione, di «un trattamento sanzionatorio congruo, ricavabile dallo stesso sistema normativo, a presidio del dovere di collaborazione con l'Autorità», che questa Corte potrebbe utilizzare in sostituzione di quello censurato, ove fosse accertata la violazione dei parametri evocati, ravvisandolo, tra le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 220 del 2002, nella gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies cod. civ.
L'applicazione di questa previsione, che abilita l'autorità di vigilanza a revocare gli amministratori e i sindaci e ad affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, consentirebbe sia di mantenere un forte effetto di deterrenza dalla sottrazione ai controlli, sia di nominare un commissario che, come disposto dall'ultimo comma della stessa, «si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati»; sarebbe così possibile svolgere l'attività di vigilanza e limitare lo scioglimento della società ai soli casi in cui sia accertato, all'esito, il mancato possesso dei requisiti mutualistici.
6.- Con atto depositato il 29 ottobre 2024 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
6.1.- Secondo la difesa statale l'art. 1, comma 936, della legge n. 205 del 2017, nell'introdurre le modifiche, tra gli altri, al censurato art. 12, comma 3, «manifest[erebbe] chiaramente la propria finalità fiscale e non sanzionatoria», enunciando che queste sono apportate «[a]l fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente».
Pertanto, in considerazione della «natura sostanzialmente fiscale delle misure riparatorie previste dalla disposizione in esame», si dovrebbe «ritenere ragionevole lo scioglimento della società cooperativa quale reazione all'assenza di collaborazione alla vigilanza» (è richiamata ancora la sentenza n. 46 del 2023).
Inoltre, la disposizione censurata, rinviando alla previsione di cui all'art. 2514, primo comma, lettera d), cod. civ., comporta la devoluzione del patrimonio sociale in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o dell'erario, in caso di cooperative non associate (in base a quanto disposto, rispettivamente, dai commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 59 del 1992). Di conseguenza, la finalità dell'art. 2545-septiesdecies cod. civ., che prevede il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, andrebbe «qualificata anche in funzione promozionale del movimento cooperativo e non, invece, apprezzata unicamente per una (asserita) funzione meramente sanzionatoria».
La misura in esame assolverebbe, dunque, a una «funzione ripristinatoria dell'ordine cooperativo violato», mentre la sua afflittività sarebbe solo una conseguenza indiretta, non essendo lo scopo principale «la punizione della violazione della legalità ma la doverosa ed inderogabile cura dell'interesse pubblico specifico».
D'altro canto, osserva l'Avvocatura generale, l'assenza di natura sanzionatoria della disposizione censurata si ricaverebbe dalla stessa formulazione del censurato art. 12, comma 3, con il quale il legislatore «ha posto sullo stesso piano» la fattispecie degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza e quella del mancato rispetto delle finalità mutualistiche da parte degli stessi enti, le quali, pur essendo «diverse tra loro», «evidentemente per il Legislatore appaiono avere la stessa intrinseca natura».
Di conseguenza, così come lo scioglimento della società cooperativa che non rispetta le finalità mutualistiche non avrebbe natura sanzionatoria bensì ripristinatoria, altrettanto si dovrebbe ritenere quando la stessa misura reagisca alla sottrazione all'attività di vigilanza; situazione, questa, che per il legislatore costituirebbe «una presunzione iuris et de iure di mancanza dello scopo mutualistico», giustificando gli effetti previsti dalla disposizione censurata.
A conferma della «natura ripristinatoria» della misura in esame la difesa statale rileva che, nell'ambito dello stesso art. 12 del d.lgs. n. 220 del 2002, soltanto i provvedimenti individuati dal comma 1 sono espressamente qualificati come sanzionatori, e che, tra le condotte di sottrazione alla vigilanza, solo quella integrante il delitto di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ. «è stata ritenuta dal Legislatore come un'attività illecita e, quindi, suscettibile di una sanzione punitiva».
6.2.- In ogni caso, conclude l'Avvocatura generale, non sarebbe praticabile la soluzione proposta dal giudice rimettente, volta a rimediare al vulnus che questa Corte dovrebbe accertare ricorrendo alla previsione di cui all'art. 2545-sexiesdecies cod. civ.
Infatti, la soluzione non si inserirebbe «nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore» (è citata la sentenza n. 62 del 2022 di questa Corte), perché contrasterebbe con la volontà dello stesso «di porre sullo stesso piano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico e la sottrazione alla attività di vigilanza».
7.- Con atto depositato il 29 ottobre 2024 si è costituita R. R., legale rappresentante della Progetto Uomo scarl fino alla emanazione del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 22 agosto 2023, impugnato nel giudizio principale.
7.1.- Aderendo alle censure sollevate dal giudice rimettente in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 45 Cost., la parte sottolinea il carattere sproporzionato e irragionevole della sanzione prevista per la sottrazione all'attività di vigilanza, «vista l'inaccettabile omogeneizzazione» con l'altra condotta, «cui la prima è legata funzionalmente, che sanziona la cooperativa per difetto di perseguimento delle finalità mutualistiche».
In sostanza, il meccanismo sanzionatorio oggetto di censura finirebbe «per mortificare [...] l'obiettivo della norma, ovvero il rispetto dei caratteri mutualistici» dell'attività societaria, e «per polverizzare», come sarebbe accaduto nella specie, «il valore economico faticosamente realizzato dall'operosa attività» degli imprenditori cooperatori.
7.2.- Con riferimento alla prospettata violazione delle disposizioni sovranazionali ed eurounitarie, la parte ritiene che la misura sanzionatoria prevista dal censurato art. 12, comma 3, risulterebbe «sproporzionata anche in senso "cardinale" od assoluto perché non calibrata sul fatto concreto», «tenuto conto del suo carattere automatico e non graduabile, nonché della sua eccezionale severità», laddove, invece, il legislatore «ben avrebbe potuto prevedere diversi strumenti per rimediare al difetto di collaborazione degli organi amministrativi della cooperativa ed accertare autonomamente la sussistenza dei requisiti mutualistici».
7.3.- Da ultimo, la parte prospetta a questa Corte la possibilità di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea con una domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8.- Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la parte, hanno depositato memorie con le quali ribadiscono gli argomenti in precedenza addotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 183 del 2024), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell'autorità degli «enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza», con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Sul presupposto che lo scioglimento autoritativo costituisca una sanzione amministrativa di carattere punitivo, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata vìoli, al metro degli artt. 3 e 45 Cost., il principio di proporzionalità anzitutto nell'accezione "ordinale", prevedendo lo stesso trattamento per gli enti che non rispettano finalità mutualistiche e per quelli che si sottraggono ai controlli, nonostante la netta diversità del disvalore espresso dalle condotte rispettivamente sanzionate, poiché la sottrazione all'attività di vigilanza sarebbe solo strumentale alla verifica del possesso dei requisiti mutualistici, mentre non rappresenterebbe in alcun modo un indice della relativa mancanza.
La irragionevole assimilazione delle due fattispecie produrrebbe quindi il rischio che, per la mera sottrazione alla vigilanza, vengano sciolti enti cooperativi che esercitano la loro attività conformemente alle previsioni legali.
Secondo il Consiglio di Stato la disposizione censurata violerebbe il principio di proporzionalità anche nel suo profilo "cardinale", in quanto, indipendentemente dalla individuazione di una ipotesi di raffronto, la misura in esame, automatica e non graduabile, raggiungerebbe un grado eccezionale di severità a fronte di una condotta non sintomatica dell'assenza dei requisiti mutualistici ed estrinsecatasi, come nel caso oggetto del giudizio principale, semplicemente non dando riscontro al revisore, senza comportamenti fraudolenti.
Lo scioglimento autoritativo, determinando il venir meno delle attività dell'ente, pregiudicherebbe dunque gli stessi interessi pubblici relativi al fenomeno cooperativo, ledendo in maniera eccessiva la posizione dei soci.
Sotto questo profilo, oltre ai già richiamati artt. 3 e 45 Cost., sarebbe anche violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, espressivo del divieto di pene evidentemente sproporzionate, e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
La disposizione censurata contrasterebbe altresì con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, paragrafo 3, e 17 CDFUE, previsioni che, rispettivamente, riflettono i menzionati principi convenzionali.
2.- In via preliminare, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità delle questioni da ultimo indicate, non avendo il rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, circostanza alla quale è subordinata, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 85 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 69, n. 31 e n. 7 del 2025).
3.- All'esame nel merito delle questioni è opportuno premettere un inquadramento sistematico.
L'art. 45, primo comma, Cost. stabilisce: «[l]a Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».
Non si tratta di una disposizione comune nel panorama comparatistico: una tale valorizzazione trova infatti la sua giustificazione negli strati profondi della società di allora, che metteva di fronte ai costituenti l'imponente movimento cooperativo sviluppatosi in Italia a partire dalla metà dell'Ottocento.
Si trattava di un movimento con caratteristiche del tutto peculiari, in quanto non legato a uno degli specifici modelli che si erano via via sviluppati all'estero, poiché in realtà li aveva progressivamente abbracciati tutti, iniziando dalle cooperative di consumo, per proseguire con quelle di produzione e lavoro, quindi con le banche popolari, le casse rurali, le mutue assicuratrici, i consorzi agrari e le cooperative agricole.
Nella vita degli italiani si era quindi radicata una realtà cooperativa che operava in modo apprezzato negli ambiti più vari e che era largamente trasversale: erano fiorite cooperative social-comuniste, cattoliche e repubblicane, con le loro separate centrali cooperative e reti di imprese.
Proprio queste caratteristiche permisero al movimento cooperativo di essere fortemente valorizzato in Assemblea costituente, come emerge sin dalla relazione introduttiva svolta nella Terza sottocommissione dall'on. Emilio Canevari, dove si precisò che «[l]a cooperazione, con le sue organizzazioni basate sui principi della mutualità e ispirate ad alte finalità di libertà umana, costituisce un efficace mezzo di difesa dei produttori e dei consumatori dalla speculazione privata, e di elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici».
3.1.- L'art. 45, primo comma, Cost. si colloca all'interno di una visione pluralistica del sistema economico, completandone il quadro della disciplina costituzionale, che risulta tracciato, nelle sue linee portanti, dagli artt. 41, 42 e 43.
Con una sostanziale peculiarità: mentre rispetto all'iniziativa economica privata l'«utilità sociale» si pone come principio limitante, alla cooperazione la Costituzione «riconosce» una «funzione sociale», individuandola quindi come connaturale a questo modello organizzativo, in quanto generativo di democrazia economica e mutualità.
Tale funzione sociale si estrinseca, infatti, «nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa» (sentenza n. 408 del 1989).
In questi termini, il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacità di unire strutturalmente all'aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune.
3.2.- Il mandato costituzionale a promuovere e favorire l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei mantiene oggi una sua perdurante attualità.
L'impresa cooperativa, ascrivibile all'ambito dell'economia civile, rappresenta infatti una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit - figura istituita dall'art. 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» -, che perseguono, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, funzionale a determinare un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull'ambiente e sulla società.
A contraddistinguere l'impresa cooperativa sono, infatti, elementi del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di governance.
La riforma del diritto societario operata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) ha valorizzato sia l'elemento della democraticità, con riguardo ai principi della "porta aperta" (art. 2528 cod. civ.) e del voto per capita (art. 2538, comma 2, cod. civ.), sia quello della mutualità (art. 2511 cod. civ.).
L'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», disciplinando il principale vantaggio tributario della società cooperativa, cioè la detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile, ha poi reso palese la fondamentale differenza tra le società cooperative e le altre imprese, perché solo le prime, accantonando nel patrimonio sociale risorse necessariamente sottratte al godimento dei soci, «si configurano come enti di creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» (sentenza n. 93 del 2022), nell'ottica della mutualità esterna o di sistema, volta a sostenere la cooperazione nella sua globalità (sentenza n. 150 del 2022).
3.3.- Tuttavia, nonostante questi caratteri, che ne rendono perdurante e attuale la specifica funzione sociale, oggi il modello cooperativo sta attraversando una grave crisi, attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle imprese, che, escluso il periodo pandemico, è positivo: in sostanza, il modello cooperativo non sembra attirare più come forma di impresa.
Anche con riguardo al fatturato, la relazione al Parlamento sulla cooperazione per gli anni 2018-2021 segnala una consistente flessione del settore, iniziata già prima della ulteriore frenata registrata nel 2020 (Ministero delle imprese e del made in Italy, «Relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione», anni 2018-2021, presentata il 30 dicembre 2022, pag. 9).
A determinare tale fenomeno, rilevato negli ultimi anni, concorrono senza dubbio plurimi fattori, ma tra questi riveste un ruolo anche l'assetto legislativo, nel quale, a fronte della perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state introdotte normative non particolarmente incentivanti per questa tipologia di impresa, come quelle per contrastare la nascita di "false cooperative" - quale l'abolizione della figura dell'amministratore unico di cooperativa - e quelle che hanno favorito la nascita di modelli di impresa "quasi concorrenti", prevedendo e disciplinando altre tipologie societarie, in particolare le società a responsabilità limitata semplificate e le società benefit in forma di società di capitali.
In questi termini, la legislazione stenta a favorire realmente l'«incremento» della cooperazione «con i mezzi più idonei» secondo il mandato dell'art. 45 Cost.
Proprio al rischio di un chilling effect fa, invero, riferimento l'ordinanza di rimessione nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata, laddove evidenzia che un «sistema così draconiano» - frutto, come si vedrà, della recente evoluzione legislativa - rischierebbe di determinare «un effetto di deterrenza rispetto all'esercizio di un'attività che non solo integra un diritto costituzionalmente garantito dei consociati (l'organizzazione dell'impresa), ma che assume anche una peculiare rilevanza sociale, come espresso dall'art. 45 della Costituzione e dalle ulteriori previsioni che [...] trovano realizzazione nella dimensione collettiva cooperativista (diritto al lavoro, sviluppo della personalità umana e della Società, tutela della piccola proprietà, tutela del credito e del risparmio, etc.)».
4.- Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3 e 45, primo comma, Cost., con assorbimento dell'altro parametro evocato.
La misura censurata si inserisce nel ventaglio dei provvedimenti sanzionatori amministrativi che l'art. 12 del d.lgs. n. 220 del 2002 individua come possibili effetti della vigilanza sugli enti cooperativi e si colloca al grado massimo di afflittività, determinando autoritativamente lo scioglimento dell'ente.
Anche a essa è quindi applicabile il «principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito» (sentenza n. 266 del 2022).
4.1.- La valutazione di legittimità costituzionale si deve strutturare verificando, innanzitutto, la finalità perseguita dal legislatore, che appare, in astratto, legittima: la vigilanza cooperativa «è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici», come enuncia l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2002, e la disposizione censurata declina la previsione costituzionale degli «opportuni controlli» (art. 45, primo comma, Cost.) finalizzati ad assicurare che gli enti cooperativi mantengano sempre il carattere e le finalità della cooperazione.
Tuttavia, essa impone lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies cod. civ., con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, al verificarsi di qualsiasi condotta di inadempimento all'obbligo di consentire l'attività di vigilanza: è in questa prospettiva, in sostanza, che il rimettente lamenta la violazione del principio di proporzionalità, rilevando che la mera sottrazione alla vigilanza, che di per sé non è indicativa della mancanza dei requisiti mutualistici, nella disposizione censurata viene irragionevolmente assimilata alla situazione, di ben diverso disvalore, dell'ente che risulti effettivamente privo degli stessi all'esito dei controlli eseguiti.
A tale argomento l'Avvocatura generale dello Stato oppone che la situazione di sottrazione all'attività di vigilanza costituirebbe per il legislatore «una presunzione iuris et de iure di mancanza dello scopo mutualistico», giustificando gli effetti previsti dalla disposizione censurata.
4.2.- Questa tesi non è condivisibile e rivela, in concreto, l'impossibilità di superare i test di connessione razionale e di necessità.
Posto che la disposizione censurata, al primo periodo, mantiene fermo «quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile», il quale sanziona penalmente i comportamenti dolosi di ostacolo all'attività di vigilanza, la misura dello scioglimento anticipa senza adeguata giustificazione la soppressione dell'ente cooperativo rispetto all'accertamento della mancanza dei requisiti mutualistici.
È bensì vero che alcune modalità di sottrazione, verosimilmente realizzate per evitare che l'attività di vigilanza disveli la reale mancanza dei requisiti mutualistici, potrebbero presentare una precisa valenza sintomatica di questa situazione.
Resta il fatto, però, che la condotta sanzionata risulta quanto mai ampia, ricomprendendo non solo le condotte attive e fraudolente ma anche quelle omissive e soltanto negligenti, dal significato molto meno univoco.
Inoltre, in base alle modalità impartite per lo svolgimento della vigilanza (risalenti nel tempo e oggi contenute nell'art. 8 dei due decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, entrambi in data 5 marzo 2025, aventi a oggetto le modalità di svolgimento e l'approvazione della modulistica relative, rispettivamente, alla revisione e alla ispezione straordinaria degli enti cooperativi), a integrare la condotta sanzionata è sufficiente, come del resto è avvenuto nella fattispecie alla base del giudizio a quo, la semplice mancata risposta alla comunicazione di avvio dell'attività di vigilanza e alla successiva diffida, entrambe inviate sulla casella PEC dell'ente sottoposto al controllo, senza che sia nemmeno necessario un accesso fisico dell'incaricato presso la sede sociale.
In tal modo, anche la condotta meramente omissiva e negligente del legale rappresentante nel monitorare la PEC, viene a risultare assimilata alla situazione sostanziale della mancanza dei requisiti mutualistici.
La disposizione censurata è quindi idonea a determinare lo scioglimento per atto d'autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici.
In quest'ottica, appare evidente che, decretando lo scioglimento dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza, il legislatore abbia rinunciato a ricorrere ai least restrictive means, ovvero a strumenti più flessibili che sarebbero stati comunque in grado di dare attuazione in via coattiva alla funzione pubblica di controllo e di superare l'ostacolo ad essa frapposto.
Nel quadro normativo precedente al d.lgs. n. 220 del 2002, la prassi amministrativa, in assenza di una disciplina di fonte primaria della condotta di sottrazione all'attività di vigilanza, aveva, del resto, seguito un approccio conservativo, applicando la meno grave sanzione della sottoposizione alla gestione commissariale, che determina la sostituzione dell'organo amministrativo con un commissario nominato dall'autorità di vigilanza.
Tra il 2012 e il 2018, inoltre, il legislatore aveva previsto che la suddetta condotta venisse colpita, anziché con lo scioglimento, con una sanzione amministrativa soltanto pecuniaria (in forza del comma 5-ter dell'art. 12 del d.lgs. n. 220 del 2002, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2017).
Infine, una conferma della possibilità di ricorrere a misure meno incisive, pur sempre adeguate a tutelare la legittima finalità perseguita, si rinviene nella vigente disciplina del settore delle imprese sociali, sottoposte al potere ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, «[i]n caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva [...], il Ministero vigilante può nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto», secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106».
4.3.- La disposizione censurata non supera neanche il test di proporzionalità in senso stretto, dato il particolare favor con cui invece la Costituzione, come si è descritto, valorizza il fenomeno cooperativo; al contrario del mandato costituzionale, la disposizione censurata rischia, in effetti, di favorire il chilling effect prefigurato dal rimettente.
Inoltre, non è dubitabile che la sanzione in questione, determinando la cessazione dell'attività dell'ente cooperativo, finisce per incidere pesantemente anche sulla sfera delle persone fisiche che lo compongono, sia interrompendo l'esercizio del diritto di svolgere attività di impresa in forma cooperativa e di fruire dei connessi servizi mutualistici, sia, nei casi in cui il socio presti attività lavorativa nella cooperativa, precludendogli la possibilità di esercitare il suo diritto al lavoro.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte stigmatizzato la grave incidenza che il diritto al lavoro della persona può subire proprio per effetto di una sanzione amministrativa di particolare rigore (sentenze n. 266 e n. 246 del 2022 e n. 68 del 2021, tutte relative alla revoca della patente di guida).
Peraltro, nonostante la condotta sanzionata sia riconducibile al solo legale rappresentante (in quanto è lui che si "sottrae", non consentendo lo svolgimento dell'attività di vigilanza), gli effetti dello scioglimento si ripercuotono sull'intera compagine cooperativa, ovvero su tutti i soci.
La previsione automatica e rigida dello scioglimento dell'ente cooperativo determina, in altre parole, gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei soci, i quali potrebbero persino ignorare l'avvio dell'attività di vigilanza e la mancata collaborazione prestata dal legale rappresentante; oltre che possibili rilevanti ripercussioni sugli altri stakeholders.
5.- Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere fondate anche le censure che il Consiglio di Stato ha sollevato ravvisando nella misura dello scioglimento una sanzione caratterizzata da una sproporzione intrinseca, o cardinale, in quanto «automatica e non graduabile».
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ritenuto che «previsioni sanzionatorie rigide [...], che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbano rispondere al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione» (ex plurimis, sentenze n. 266 del 2022 e n. 212 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2023).
Nella specie, l'unica risposta attualmente prevista a qualsiasi condotta di sottrazione è lo scioglimento dell'ente cooperativo, con conseguente devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza.
Tuttavia, all'interno della vasta gamma di condotte astrattamente ricomprese dalla disposizione è dato ravvisare un insieme di fatti concreti per i quali tale conseguenza risulta non adeguatamente correlata alla gravità dell'illecito commesso, potendo questo derivare da un comportamento meramente omissivo e non necessariamente doloso del legale rappresentante, in ipotesi rimasto inerte a fronte delle due comunicazioni formali inviate a mezzo PEC dal revisore alla cooperativa.
L'unica sanzione applicabile finisce quindi per omologare condotte sia attive e intenzionali, sia, soprattutto, omissive e soggettivamente soltanto colpose.
6.- Una volta riscontrata la fondatezza delle questioni, si deve considerare che una pronuncia meramente ablativa determinerebbe un «insostenibile vuoto di tutela» (ex plurimis, sentenza n. 46 del 2024), in contraddizione anche con la stessa previsione costituzionale che richiede la previsione di opportuni controlli affinché siano assicurati il carattere e le finalità delle imprese cooperative.
Risulterebbe, infatti, inefficace, a tali fini, la sola misura, enunciata nel primo periodo del censurato art. 12, comma 3, della cancellazione dell'ente, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi, che, peraltro, in realtà non è mai stato istituito.
È quindi imprescindibile fare ricorso, per non lasciare priva di tutela l'esigenza di apprestare una sanzione alle condotte di sottrazione all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, a una pronuncia che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione.
Al riguardo, pare congrua la soluzione proposta dallo stesso Consiglio di Stato rimettente, volta a individuare la sanzione in quella della gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies cod. civ.: all'ultimo comma, questo prevede - a seguito della novella introdotta dall'art. 1, comma 936, lettera c), numero 3), della legge n. 205 del 2017 - che l'organo nominato dall'autorità pubblica si sostituisce a quelli dell'ente, anche «limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati».
Questa misura, per un verso, può dirsi pre-data, traendosi dal medesimo ambito della vigilanza sugli enti cooperativi; per altro verso, rappresenta il provvedimento sanzionatorio immediatamente meno grave dello scioglimento, potendosi così ritenere mantenuta l'indicazione legislativa per un trattamento di rigore da riservare alle condotte di sottrazione ai controlli.
In ogni caso, la sostituzione dell'organo di amministrazione, nei termini indicati, consente lo svolgimento dell'attività di vigilanza, dal quale potrebbe emergere che l'ente debba comunque essere sciolto per atto dell'autorità, ricorrendo una delle fattispecie autonomamente considerate dall'art. 2545-septiesdecies cod. civ.; ma non si esclude che invece tale sostituzione permetta di accertare il genuino rispetto delle finalità mutualistiche.
Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
Tale soluzione si pone nell'orizzonte delle soluzioni «costituzionalmente adeguat[e]» (sentenza n. 40 del 2019), in quanto tratta da discipline già esistenti, che in ogni caso lascia però ferma «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali» qui considerati (sentenza n. 46 del 2024).
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.