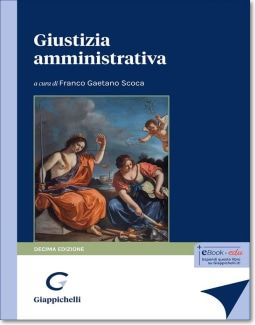Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 17 maggio 2018, n. 32058
Presidente: Paoloni - Estensore: De Amicis
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento: a) alla qualificazione giuridica del fatto ed alla errata applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., sul rilievo della confusione che si è verificata tra le somme di pertinenza erariale e quelle destinate a remunerare l'albergatore, che non ha un obbligo di istituire un conto dedicato, con la conseguente mancanza di prova dell'avvenuta interversione del possesso, la quale non può essere desunta da un mero ritardo nell'adempimento dei versamenti in favore del Comune, tenuto altresì conto del fatto che i relativi tributi sono stati spontaneamente pagati dall'imputato ancor prima di ricevere la contestazione dell'inadempimento, ovvero a seguito di una ricognizione di debito incompatibile con l'interversione del possesso; b) alla qualificazione giuridica del soggetto attivo, la cui attività di albergatore non può ricondursi alla figura dell'incaricato di pubblico servizio, poiché l'attività svolta dall'imputato è quella, puramente esecutiva e materiale, di incasso, non già di rendicontazione, che, sola, sarebbe soggetta ai principii evocati dalla impugnata sentenza là dove ha fatto riferimento alla sentenza n. 22/2016 QM 8 giugno 2015-22 settembre 2016 della Corte dei conti a Sezioni riunite, relativa alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive presenti sul territorio; c) alla mancanza di consapevolezza in capo all'imputato del possesso della qualifica di agente contabile, avuto riguardo alla novità ed alla particolare complessità della questione, anche sotto il profilo della concreta conoscibilità della norma extra-penale, contenuta in un allegato (4.2.) al d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; d) alla incostituzionalità delle norme regolamentari che attribuiscono all'imputato responsabilità contabili (in forza del regolamento n. 349/2012 della città di Torino, istitutivo della tassa di soggiorno), poiché emanate in assenza di una previsione di legge, dunque in violazione del principio di cui all'art. 23 Cost.
3. Con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 aprile 2018 il difensore del predetto imputato ha allegato copia dell'atto di quietanza liberatoria, con relativa dichiarazione di rinuncia all'azione civile, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Torino in data 19 aprile 2018.
Il Sindaco del Comune, costituito parte civile nei confronti del L., ha dichiarato, con tale atto, sia di aver ricevuto una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni e rifusione delle spese legali, sia di non avere più nulla a pretendere dal fatto per cui è causa, con la conseguente rinuncia all'azione civile proposta nei confronti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
2. Muovendo dal complesso delle emergenze probatorie compiutamente illustrate in motivazione, la Corte distrettuale ha congruamente esaminato e disatteso le medesime obiezioni difensive qui sostanzialmente reiterate, confermando le ragioni giustificative addotte a sostegno dell'epilogo decisorio cui era pervenuto il primo Giudice ed altresì evidenziando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, i seguenti, dirimenti, elementi ricostruttivi in punto di fatto: a) che il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno relativamente al primo trimestre (con scadenza il 15 aprile 2015) è avvenuto il 19 novembre 2015, mentre i versamenti relativi al secondo trimestre (con scadenza il 15 luglio 2015) ed al terzo trimestre (con scadenza il 15 ottobre dello stesso anno) sono rispettivamente avvenuti il 16 dicembre 2015 ed il 18 gennaio 2016; b) che i versamenti per gli importi indicati nell'imputazione relativamente al secondo ed al terzo trimestre sono avvenuti, con inescusabile ritardo, solo a seguito delle rispettive contestazioni e diffide presso gli uffici della Polizia municipale; c) che l'imputato era tenuto a versare entro il termine di quindici giorni dalla fine del mese successivo a ciascun trimestre di competenza le somme incassate per conto dell'ente pubblico; d) che egli, quale titolare e legale rappresentante di una struttura alberghiera torinese, era pienamente a conoscenza sia dei termini previsti nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, operativo per effetto di una delibera del Consiglio comunale sin dal 27 febbraio 2012, che della destinazione delle somme di denaro versate dagli ospiti della struttura ricettiva e da lui riscosse a titolo di imposta di soggiorno; e) che in forza delle previsioni contenute nel su richiamato regolamento comunale il gestore della struttura ricettiva può effettuare il versamento delle somme - di cui ha rilasciato quietanza al soggiornante - su un apposito conto corrente intestato al soggetto incaricato della riscossione, ossia al Comune, ovvero attraverso le procedure informatiche messe a disposizione o mediante pagamento tramite sistema bancario, con l'eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro contante.
3. La disciplina dell'imposta di soggiorno è contenuta nell'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 33 della l. 28 dicembre 2015, n. 221.
L'imposta di soggiorno propriamente denominata è esclusivamente quella individuata dal primo comma dell'art. 4, il quale dispone che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio".
Il legislatore, pertanto, ha definito i contorni della disciplina del tributo, individuandone il presupposto, costituito dal soggiorno nelle strutture ricettive localizzate entro il territorio degli enti locali impositori, nonché i soggetti passivi, rappresentati dagli ospiti di tali strutture.
In conformità al principio della riserva di legge vigente per la materia tributaria, sancito dall'art. 23 Cost. e riaffermato, nel contesto della ripartizione dei poteri tra Stato centrale ed enti locali, dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, sono state individuate la misura massima dell'aliquota nonché i criteri di modulazione della medesima, per cui il tributo deve applicarsi "secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno".
Il legislatore è altresì intervenuto con riguardo alla destinazione del gettito del tributo, disponendo che le entrate sono destinate a "finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".
La disciplina di dettaglio - demandata dall'art. 4 d.lgs. cit. all'adozione di un regolamento governativo da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. 23 agosto 1988, n. 400 - non è ancora stata varata, con la conseguenza che, in sede di regolamentazione del tributo da parte delle singole municipalità, i comuni capoluogo di provincia (e le unioni di comuni) sono espressamente autorizzati, dal comma 3 del su citato art. 4, secondo periodo, a disporre, con proprio regolamento ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "ulteriori modalità applicative del tributo", nonché a prevedere "esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo".
L'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 23/2011 espressamente statuisce, infatti, che, nel caso di mancata emanazione del regolamento nei termini previsti, i comuni possono comunque procedere alla istituzione del tributo.
Diversamente da quanto prospettato con l'ultimo profilo di doglianza, emerge con evidenza, già da una sommaria analisi del quadro normativo di riferimento, che le disposizioni contenute nel regolamento comunale trovano la loro base normativa in una espressa norma di legge volta a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo, laddove quella regolamentare viene adottata al fine di attuarne e specificarne il generale contenuto di indirizzo nella competente sede territoriale.
3.1. Per quel che attiene ai compiti affidati al soggetto che gestisce la struttura ricettiva i regolamenti comunali contemplano il più delle volte oneri accessori, strumentali e funzionali all'esazione dell'obbligazione tributaria, non già compiti di sostituzione o di responsabilità impositiva, dai quali conseguirebbero ipotesi di solidarietà tributaria. Si tratta, in particolare, di compiti relativi all'informazione, al calcolo dell'imposta dovuta, all'incasso dell'imposta, alla conservazione e compilazione della modulistica, all'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta, nonché ai connessi obblighi dichiarativi e certificativi.
I controlli sul gestore attengono essenzialmente ad aspetti quali la corretta liquidazione del tributo, l'integrale e fedele rendicontazione dell'imposta incassata, il suo integrale riversamento al comune di appartenenza.
Diversamente, l'unico obbligo previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 in capo al soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, ossia dell'ospite della struttura ricettiva, è quello del pagamento dell'imposta, non essendo infatti previsto a suo carico alcun obbligo dichiarativo proprio in virtù dell'intervento del gestore della struttura ricettiva.
La differenza è rilevante, giacché l'incaricato o responsabile della riscossione del tributo svolge un'attività ausiliaria nei confronti dell'ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione tributaria, la quale, per l'appunto, comporta l'incasso delle somme spontaneamente versate dal soggetto passivo e il conseguente obbligo di riversarle all'ente impositore di competenza.
Il sostituto d'imposta, di contro, risponde in proprio del versamento del tributo, anche nell'eventualità in cui il soggetto passivo (l'ospite) si rifiuti di pagare o comunque non versi l'imposta.
La qualifica assunta dai gestori delle strutture ricettive esula pertanto dall'ambito della responsabilità d'imposta, sicché il gestore è un terzo rispetto all'obbligazione tributaria ed il suo coinvolgimento avviene ad altro titolo, ossia quale destinatario di obblighi formali e strumentali all'esazione del tributo comunale.
Ne discende che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell'ambito di un rapporto completamente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionalmente orientato e correlato.
3.2. Il quadro normativo di riferimento si completa con il necessario richiamo alla norma generale sancita dagli artt. 74, comma 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178 del r.d. n. 827/1924, i cui principii sono peraltro ribaditi nel t.u.e.l. n. 267/2000, che, in particolare, all'art. 93, comma 2, recita: "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".
Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, che trova conferma anche nel d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, entrato in vigore dal 10 agosto 2011, che nel dettare "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi", nell'allegato n. 4/2, al punto 4.2, dispone espressamente che: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale... Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti".
Vi si prevede, altresì, nella medesima prospettiva e ad ulteriore conferma di quanto or ora illustrato, che "Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione".
4. Ciò posto in ordine al profilo di doglianza attinente alla qualificazione giuridica del soggetto attivo, deve ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte con riguardo alla materia qui esaminata (cfr. Sez. 6, n. 43279 del 15 ottobre 2009, Pintimalli, Rv. 244992), ove si consideri che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui egli ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d'ufficio.
Integra pertanto il delitto di peculato, che è un reato a consumazione istantanea (Sez. 6, n. 12141 del 19 dicembre 2008, dep. 2009, Lombardino, Rv. 243054), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus (Sez. 6, n. 53125 del 25 novembre 2014, Renni, Rv. 261680).
Nel caso di specie, come posto correttamente in risalto dai Giudici di merito, i versamenti sono stati effettuati a distanza di diversi mesi dalla scadenza del termine previsto, sebbene le somme di denaro ricevute dai soggiornanti fossero entrate nella diretta disponibilità della pubblica amministrazione non appena versate a colui che, per legge, era stato incaricato di riscuoterle.
4.1. A tale riguardo v'è da osservare, peraltro, che questa Suprema Corte si è già espressamente pronunziata (Sez. 6, n. 53467 del 25 ottobre 2017, Ranieri), sia pure con riferimento ad una vicenda storico-fattuale oggetto di un provvedimento cautelare reale, affermando che l'attività di riscossione dell'imposta di soggiorno da parte del privato si accompagna a precedenti condotte di accertamento del presupposto dell'imposta e a successive attività di registrazione dell'importo riscosso che richiedono "un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di esperienza che esulano dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine".
Ne discende che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante di una società privata che, anche in assenza di un preventivo, specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, proceda effettivamente e materialmente alla riscossione della imposta di soggiorno, in considerazione della natura prettamente pubblicistica della sua attività, sì come direttamente disciplinata dalle norme di diritto pubblico istitutive della relativa imposta.
Orientamento, quello or ora richiamato, che va ribadito, ponendosi, d'altronde, in linea di stretta continuità e progressione ermeneutica con i principii da questa Suprema Corte enunciati riguardo alla qualità di incaricato di un pubblico servizio attribuita all'amministratore e legale rappresentante di società private incaricate della gestione del servizio di riscossione di imposte comunali (Sez. 6, n. 46235 del 21 settembre 2016, Froio, Rv. 268127), ovvero con riferimento ai soggetti autorizzati alla riscossione di tasse automobilistiche, avendo questa Corte affermato che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento di tale pubblica funzione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione, sicché non esclude la consumazione del reato l'esistenza di una fideiussione a garanzia dell'obbligo di versare all'ente pubblico gli importi riscossi (Sez. 6, n. 2693 del 29 novembre 2017, dep. 2018, De Luca, Rv. 272131; Sez. 6, n. 45082 del 1° ottobre 2015, Marrocco, Rv. 265342).
4.2. Entro tale prospettiva giova altresì richiamare, in linea generale, il consolidato orientamento ermeneutico delineato dalle Sezioni unite civili di questa Suprema Corte, che hanno stabilito il principio in ragione del quale "elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte..." (cfr. Sez. un., n. 13330 del 1° giugno 2010, Rv. 613290-01, nonché Sez. un., n. 14891 del 21 giugno 2010, Rv. 613822-01 e Sez. un., n. 232 del 10 aprile 1999, Rv. 525148-01).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di enti locali, si è espressa questa Suprema Corte nei passaggi motivazionali della sentenza n. 12367 del 2001 (Sez. un., n. 12367 del 15 marzo 2001), ove si è ribadito che "la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto", rimarcando il fatto che "Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto ... Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico ... è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia".
Nella fattispecie in esame, avuto riguardo alle implicazioni sottese alle su esposte linee ricostruttive di ordine sistematico tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, è di tutta evidenza come l'esercente l'attività alberghiera sia compartecipe dell'attività amministrativa del Comune quale ente impositore, anche in considerazione degli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta di soggiorno versata dai clienti e all'integrale riversamento della stessa al Comune, obblighi peraltro sanzionati (fuori dal rapporto d'imposta vero e proprio che, come si è visto, intercorre fra il Comune ed il singolo cliente pernottante) con la previsione di specifiche sanzioni amministrative.
5. A tale quadro di principii, inoltre, si è direttamente richiamata la Corte dei conti in una recente decisione emessa in sede giurisdizionale, ove si è affermato che "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta" (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 22/2016/QM dell'8 giugno 2015, dep. 22 settembre 2016).
Si osserva in tale pronuncia, fra l'altro, che la riserva di legge posta dall'art. 23 della Costituzione in materia di imposizione tributaria comporta che sia la norma primaria a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo, stabilendo non solo il presupposto e la misura del tributo, ma anche il soggetto attivo e quello passivo dell'imposizione tributaria, aspetti, questi, sui quali non può incidere la normativa regolamentare di attuazione.
La normativa primaria intervenuta in materia è l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 che, come dianzi già evidenziato, ha individuato i soggetti passivi del rapporto tributario esclusivamente in "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive".
I regolamenti comunali, a loro volta, instaurano espressamente tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili. Infatti - prosegue la Corte dei conti nella su citata pronunzia - nella misura in cui essi affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio.
È parimenti indubbio, poi, che tale rapporto abbia un contenuto principalmente contabile, ove si consideri che, tra i compiti affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e di report al Comune dell'attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del Comune dell'esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento.
Ad un rapporto di servizio che preveda l'attività di riscossione e riversamento di denaro, e quindi implichi la "disponibilità materiale" di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un contenuto prettamente contabile.
I Giudici contabili concludono il percorso argomentativo delineato nella richiamata decisione ponendo in rilievo il fatto che, alla luce dei suddetti consolidati principii, "va indubbiamente riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all'Ente locale".
Elementi univocamente indicativi in tal senso devono ravvisarsi, in particolare: a) nel carattere pubblico dell'ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune; b) nel carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un'imposta di scopo (vedasi l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 del citato d.lgs. n. 23/2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario).
6. Discende, ancora, dalle su esposte considerazioni, che già dal momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno il gestore alberghiero è qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune.
6.1. La connotazione pubblicistica di tale attività emerge, invero, per il suo diretto collegamento al preminente interesse generale alla corretta riscossione delle entrate tributarie dell'ente locale, che ne è titolare in virtù del potere impositivo a lui riconosciuto dalla legge.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di peculato per appropriazione nella condotta del soggetto autorizzato alla riscossione che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento di tale funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione e ad esso non può essere data alcuna diversa destinazione, laddove l'eventuale imputazione delle somme incassate dai contribuenti alla copertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate e ricevute, realizza la condotta appropriativa di cui all'art. 314 c.p.
6.2. Una diversa soluzione, infatti, verrebbe a scardinare le regole generali in materia di contabilità pubblica, consentendo a coloro che ricevono comunque somme di spettanza di enti pubblici di sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento a questi ultimi di tali introiti (cfr. C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2017, n. 5545).
Con la previsione secondo cui il gestore della struttura ricettiva è tenuto, in qualità di agente contabile, a rendere al Comune il conto della gestione dell'imposta di soggiorno riscossa dai propri clienti risulta evidente che tale qualità è attribuita al titolare dell'albergo, ovvero al titolare dell'impresa alberghiera.
Secondo i principi generali, inoltre, in caso di impresa alberghiera esercitata in forma collettiva la qualità di agente contabile è attribuita al legale rappresentante dell'ente societario. I rapporti interni a quest'ultimo, infatti, e la suddivisione di compiti all'interno della struttura ricettiva, come sottolineato nella decisione da ultimo richiamata, "sono per contro irrilevanti nei confronti dell'amministrazione".
Non emergono, a tale riguardo, profili di irragionevolezza nell'attribuzione della qualifica in questione a tutti i gestori di strutture alberghiere, a prescindere dalla loro dimensione. Anche un imprenditore individuale, in ipotesi privo di dipendenti o collaboratori, è evidentemente in grado di adempiere agli obblighi previsti dalle su citate norme regolamentari.
Né, tanto meno, sono ravvisabili profili di gravosità negli obblighi strumentali alla riscossione dell'imposta previsti dai regolamenti comunali: a prescindere dal fatto che gli stessi, come osservato dal Consiglio di Stato, sono conformi alle leggi di contabilità pubblica, si tratta di obblighi facilmente gestibili per qualsiasi operatore del settore e che comportano, in estrema sintesi, una mera separazione contabile degli incassi a titolo di imposta di soggiorno rispetto a quelli rivenienti dall'esercizio dell'attività di impresa, ai fini della relativa rendicontazione e del versamento nei confronti del Comune.
7. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, peraltro, va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere conseguentemente revocate, come da dispositivo, in ragione dell'intervenuta dichiarazione di rinuncia all'azione civile nei confronti del ricorrente, come da atto di quietanza liberatoria sottoscritto in data 19 aprile 2018 dal Sindaco del Comune di Torino, costituitosi parte civile nel procedimento de quo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Rigetta nel resto il ricorso.
Depositata il 12 luglio 2018.