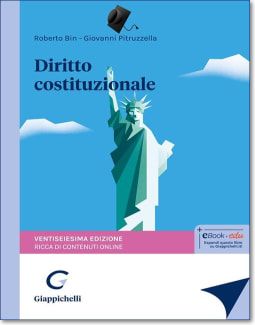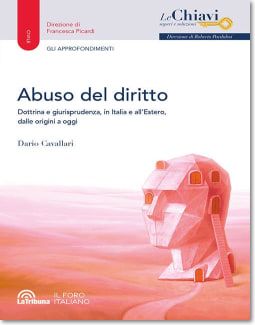Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 29 maggio 2020, n. 5736
Presidente: Savo Amodio - Estensore: Marzano
FATTO
Con ricorso notificato il 24 dicembre 2018 le società Apple Inc., società costituita ai sensi del diritto degli Stati Uniti [d']America, California, Apple Distribution International ("ADI"), società costituita ai sensi del diritto irlandese, Apple Italia S.r.l. ("Apple Italia") e Apple Retail Italia S.r.l. ("Apple Retail"), di seguito congiuntamente denominate "Società del Gruppo Apple" o "Apple", hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento dell'AGCM n. 27365 del 25 settembre 2018 (reso nel caso PS11039 - Apple Aggiornamento Software), con il quale l'Autorità ha accertato che Apple ha posto in essere due pratiche commerciali scorrette ed ha irrogato in solido alle Società del Gruppo Apple una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.000 per la realizzazione di ciascuna delle due pratiche, per complessivi euro 10.000.000, da pagare entro il 24 novembre 2018.
Tale sanzione è stata pagata in data 20 novembre 2018.
Le pratiche in questione sono le seguenti:
"A) la proposta insistente, ai consumatori in possesso di iPhone 6/6plus/6s/6splus, di procedere ad installare il sistema operativo iOS 10 e i successivi aggiornamenti (tra cui iOS 10.2.1) le cui caratteristiche e impatto sulle prestazioni degli smartphone stessi sono state descritte in maniera omissiva ed ingannevole, senza offrire (se non in misura limitata o tardiva) alcun mezzo di ripristino dell'originaria funzionalità degli apparecchi in caso di sperimentata diminuzione delle prestazioni a seguito dell'aggiornamento.
In particolare, secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo e le segnalazioni di alcuni consumatori pervenute nel dicembre 2017, Apple, in occasione della release del sistema iOS 10.1, non ha informato i clienti dei possibili inconvenienti di funzionamento che il nuovo SO avrebbe potuto provocare attesa la configurazione hardware degli smartphone in cui sarebbe stato installato (ed in particolare del grado di usura della batteria) in determinate condizioni d'uso comune.
Inoltre, in occasione della release del sistema iOS 10.2.1, Apple ha omesso di informare preliminarmente i consumatori, in maniera chiara e immediata, che per evitare alcuni rilevanti inconvenienti (quali l'improvviso spegnimento/riaccensione del proprio iPhone) tale release includeva un sistema di gestione delle prestazioni dello smartphone che avrebbe opportunamente rallentato tali prestazioni per evitare lo spegnimento inatteso - sistema mantenuto anche in successivi aggiornamenti di iOS;
B) la mancata informazione sulle caratteristiche della batteria e specificamente in merito alle condizioni per mantenere un adeguato livello di prestazioni degli iPhone, alla sua durata e alle modalità per la sua corretta gestione al fine di rallentarne la naturale usura e, quindi, in merito alla sostituzione della medesima batteria".
Con lo stesso provvedimento l'Autorità ha disposto che Apple Inc., Apple Distribution International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia S.r.l. pubblicassero, entro sessanta giorni, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, Codice del consumo, il cui testo era riportato in allegato al provvedimento.
Limitatamente a tale ultimo adempimento il provvedimento è stato temporaneamente sospeso con decreto ante causam n. 7672 del 17 dicembre 2018.
Il ricorso è affidato ai motivi di seguito sintetizzati.
Quanto alla pratica sub A).
I) Eccesso di potere per carenza assoluta di prove tecniche (o altre prove dirette) del presunto danno dell'iOS 10, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Con tale motivo la parte ricorrente, in sintesi, sostiene che gli elementi di prova addotti dall'Autorità non comproverebbero, riguardo all'iOS 10, la riduzione delle prestazioni dell'iPhone e il precoce degrado della batteria lamentando che non siano state effettuate prove tecniche per confrontare le funzionalità dell'iPhone e della batteria prima e dopo l'installazione di tale versione.
II) Eccesso di potere per inidoneità dei dati sui servizi di assistenza (Dati SAC) a dimostrare il presunto danno dell'iOS 10, grave errore di logica, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione: per sopperire al deficit istruttorio non sarebbero utili i dati del servizio di assistenza clienti, che indicano un leggero incremento nelle richieste di assistenza nell'autunno/inverno 2016, che l'Autorità, pretenderebbe di ricondurre al lancio dell'iOS 10 a settembre 2016 o dell'iOS 10.1 a ottobre 2016.
III) Eccesso di potere per carenza di prova, grave errore di logica, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione nell'individuazione della causa del leggero aumento delle richieste di assistenza nell'autunno/inverno 2016: anche ipotizzando che si possa legittimamente fondare l'accertamento della pratica sub A) sui Dati SAC, l'AGCM avrebbe omesso di considerare spiegazioni alternative più plausibili e fondate su dati tecnico scientifici.
L'AGCM non avrebbe considerato: l'invecchiamento ordinario delle batterie e il calo delle temperature; il fisiologico aumento temporaneo delle richieste di assistenza correlato al lancio degli aggiornamenti dell'iOS e altre spiegazioni tecniche; che le richieste di assistenza per il rallentamento del dispositivo non sarebbero aumentate nell'autunno/inverno 2016; che il modello SE (lanciato a marzo 2016) non sarebbe stato interessato da richieste di assistenza quando l'iOS 10 è stato rilasciato; che la mera circostanza che l'iOS 10 ha apportato nuove funzionalità non sarebbe idonea a supportare la tesi dell'AGCM; che le segnalazioni dei consumatori non erano molte. Inoltre Apple non avrebbe mai dichiarato, neanche indirettamente, che l'iOS 10.1 avrebbe provocato o aumentato il fenomeno degli UPO.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo, eccesso di potere per errata valutazione dell'onere di diligenza professionale, carenza dei presupposti, carenza assoluta della prova relativa al presunto pregiudizio causato dall'iOS 10: non sarebbe vero che Apple abbia fornito un'informativa incompleta e fuorviante delle caratteristiche dell'iOS 10.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo, eccesso di potere per errata valutazione dell'onere di diligenza professionale, carenza dei presupposti, carenza assoluta della prova relativa al presunto pregiudizio causato dall'iOS 10.2.1.: anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che Apple non abbia adempiuto ai propri obblighi di informativa rispetto ai consumatori-utenti prima dell'installazione, le iniziative intraprese successivamente avrebbero fornito un rimedio più che adeguato ad ogni eventuale disguido teoricamente patito dagli utenti (l'iOS 11.3, che ha consentito agli utenti di disabilitare la PMF; il Programma di Sostituzione della Batteria a euro 29 il rimborso di euro 60).
VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Codice del consumo, eccesso di potere per errata valutazione dell'onere di diligenza professionale, carenza dei presupposti, carenza assoluta della prova relativa al presunto pregiudizio causato dall'iOS 10.2.1: non sarebbe stata dimostrata l'aggressività della pratica; il divieto di downgrading e i promemoria sugli aggiornamenti non determinerebbero alcun indebito condizionamento tale da indurre il consumatore ad agire contro i suoi interessi; l'inibitoria disposta dall'AGCM violerebbe il principio di proporzionalità in quanto i cambiamenti richiesti sarebbero di portata tale da minare irreversibilmente la sicurezza, la facilità d'uso e la funzionalità dei modelli interessati per tutti gli utenti e da pregiudicare la libertà d'impresa e il diritto di Apple di determinare autonomamente il proprio business model e le caratteristiche dei propri prodotti; i Dati SAC non dimostrerebbero che Apple abbia adottato una politica di assistenza tecnica volta ad aumentare i costi di riparazione e di ripristino delle funzionalità per favorire il trade-in.
VII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. b), Codice del consumo, eccesso di potere per carenza di prova e travisamento dei fatti: i dati sulle vendite smentirebbero la tesi dell'AGCM secondo cui Apple avrebbe tratto vantaggio dal[la] pratica sub A).
VIII) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, e 18, comma 1, lett. e) ed m), Codice del consumo: la pratica sub A) non sarebbe in grado di incidere sul consumatore avveduto, prudente e normalmente informato.
IX) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, grave illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione: la pratica sub A) non potrebbe ritenersi ancora in corso.
Quanto alla pratica sub B).
X) Eccesso di potere per carenza di prove, travisamento dei fatti, grave illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, violazione del principio del contraddittorio, violazione e falsa applicazione e falsa applicazione dell'art. 22 Codice del consumo e del canone di diligenza professionale.
L'AGCM ha contestato ad Apple cinque profili di omessa informativa ma solo in un caso Apple non avrebbe adempiuto: si tratta della omessa informativa relativa alla "necessità di controllare cautelativamente lo stato della batteria in occasione del rilascio di nuovi aggiornamenti software, al fine di consentire un corretto uso e mantenere un adeguato livello di prestazioni dei propri dispositivi cellulari".
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché fondato su dieci nuove ipotesi di omessa informativa, sui quali Apple non avrebbe avuto modo di difendersi; tali omissioni sarebbero raggruppabili in quattro categorie di informazioni asseritamente non fornite: (1) informazioni relative al fatto che le batterie dell'iPhone hanno una vita utile limitata e che potrebbe essere necessario sostituirle; (2) informazioni relative al fatto che la batteria è un elemento importante dell'iPhone, il cui deterioramento può determinare problemi di prestazione, come gli UPO; (3) informazioni relative a come manutenere ed ottimizzare le batterie; e (4) informazioni relative alla capacità della batteria di fornire energia in tempi rapidi quando invecchia.
In ogni caso le nuove contestazioni dell'AGCM sarebbero infondate.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame l'AGCM con l'AGCom e le Associazioni Codici e Altroconsumo.
Con ordinanza n. 715 del 31 gennaio 2019 è stata respinta l'istanza cautelare sia in ordine all'inibitoria di cui all'atto impugnato, sia in ordine alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa.
Con motivi aggiunti notificati il 30 ottobre 2019 la parte ricorrente ha, poi, impugnato, in parte qua, anche il verbale della seduta del Collegio dell'AGCM del 25 settembre 2018, di cui ha avuto conoscenza a seguito di accesso agli atti.
Con tale ulteriore gravame la parte ricorrente ha denunciato vizi formali e procedurali che riverberebbero i loro effetti sul provvedimento, inficiandone la legittimità.
In particolare:
- la deliberazione, l'esame e la votazione del provvedimento non sarebbero avvenuti su uno "schema di decisione" in violazione della disciplina procedimentale applicabile;
- il collegio che ha deliberato sarebbe stato viziato nella sua costituzione atteso che la deliberazione sarebbe avvenuta con la partecipazione dell'ex Presidente Pitruzzella, ormai scaduto e quindi privo dei necessari poteri di legge: vizio aggravato dal fatto che costui aveva rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche, così rendendo dubbia la sua imparzialità;
- come risulterebbe dalle sottoscrizioni in calce al verbale, la seduta del collegio sarebbe stata condotta da due Presidenti, il prof. Pitruzzella (in qualità di Presidente) e la dott.ssa Muscolo (in qualità di Presidente facente funzioni) e con il voto di entrambi;
- la deliberazione del Collegio sarebbe stata adottata dopo la notifica del provvedimento ad Apple e dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
In vista della trattazione del merito, le parti principali hanno depositato memorie conclusive con le quali, in particolare, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame e l'Autorità ha preso posizione anche in ordine alle censure formulate con i motivi aggiunti.
La parte ricorrente ha replicato con memoria del 9 maggio 2020.
All'udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
DIRITTO
1. In seguito ad alcune segnalazioni con le quali numerosi consumatori lamentavano malfunzionamenti sui dispositivi Apple, verificatisi a seguito dell'installazione del sistema operativo iOS 10, l'Autorità, in data 10 gennaio 2018, comunicava a Apple Distribution International, Apple Italia ed Apple Retail, società appartenenti al gruppo multinazionale controllato da Apple Inc., l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11039 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo.
Nel corso del procedimento venivano svolti accertamenti ispettivi, audizioni e venivano presentati impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo che, tuttavia, venivano rigettati dall'Autorità.
Il 21 agosto 2018 Apple comunicava all'Autorità le misure adottate per rimediare e/o limitare le disfunzioni lamentate dai consumatori e, il 3 settembre 2018, depositava ulteriore memoria difensiva.
Infine, il 25 settembre 2018, l'Autorità adottava il provvedimento n. 27365 con il quale accertava la sussistenza di due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo e sanzionava le società, imponendo, altresì, la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa.
Con riferimento alla condotta sub A), l'Autorità accertava la sussistenza di una articolata pratica commerciale aggressiva e ingannevole, consistente nella reiterata e non richiesta sollecitazione dei consumatori alla installazione e al successivo aggiornamento del sistema operativo iOS 10, le cui caratteristiche e il cui impatto sulle prestazioni degli smartphone stessi venivano descritte dal professionista in maniera del tutto carente ed omissiva, stante la sola descrizione dei benefici attesi.
Con riferimento alla condotta sub B) l'Autorità accertava il compimento di una pratica ingannevole, consistente nella mancata ed insufficiente informazione su alcune caratteristiche essenziali delle batterie a litio degli iPhone (quali, in particolare, la durata media della vita e la deteriorabilità, la rilevanza e la correlazione tra queste e le prestazioni del dispositivo, nonché le istruzioni per la loro corretta ottimizzazione e per la loro sostituzione) la cui conoscenza è necessaria non soltanto ex ante per effettuare una scelta di acquisto consapevole, ma anche ex post, qualora lo smartphone risulti meno performante o presenti specifici problemi (quali gli spegnimenti improvvisi), per comprendere correttamente quale possa essere la causa di tali disfunzioni e decidere quale tipo di intervento effettuare (sostituire la batteria e prolungare la vita del prodotto o procedere alla sua sostituzione).
2. L'esame del ricorso, per ragioni di anteriorità logico-giuridica, deve principiare dai motivi aggiunti, le cui censure di tipo formale/procedurale, ove fondate, sarebbero in grado di invalidare autonomamente il provvedimento impugnato.
Con tale gravame, proposto a seguito di accesso agli atti, la parte ricorrente dubita della legittimità del provvedimento impugnato in quanto: la deliberazione, l'esame e la votazione del provvedimento non sarebbero avvenuti su uno "schema di decisione", in asserita violazione della disciplina procedimentale applicabile; la deliberazione sarebbe avvenuta con la partecipazione dell'ex Presidente Pitruzzella, ormai scaduto e quindi privo dei necessari poteri di legge: vizio aggravato dal fatto che costui aveva rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche, così rendendo dubbia la sua imparzialità; la seduta del collegio sarebbe stata condotta da due Presidenti e con il voto di entrambi; la deliberazione del collegio sarebbe stata adottata il 7 novembre 2019, ossia dopo la notifica del provvedimento ad Apple e dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
2.1. È necessario fare chiarezza sulle circostanze di fatto su cui si appuntano le riportate censure.
Il provvedimento impugnato risulta adottato dall'AGCM nell'adunanza del 25 settembre 2018 su proposta della relatrice dott.ssa Gabriella Muscolo, è stato sottoscritto dalla stessa dott.ssa Muscolo, in qualità di Presidente facente funzioni, oltre che dal Segretario Generale, Filippo Arena; è stato notificato alla parte ricorrente il 24 ottobre 2018.
Dal verbale dell'adunanza del 25 settembre 2018, in cui è stato trattato un numero rilevante di casi, risulta presente alla discussione, oltre all'altro componente prof. Ainis, anche l'ex Presidente dell'Autorità prof. Pitruzzella, il cui mandato è scaduto il 30 settembre 2018. Dalla copia stralcio del verbale esibita dalla difesa erariale, risulta: "Alle ore 17.20 il Presidente Pitruzzella lascia la riunione. La dott.ssa Muscolo collegata in teleconferenza, assume le funzioni di Presidente del Collegio".
Il procedimento che riguarda la parte ricorrente era indicato come il n. 136 all'ordine del giorno della suddetta seduta, che si è chiusa alle ore 17,55.
Il verbale concernente tutti i punti all'ordine del giorno del 25 settembre 2018 è stato sottoscritto in data 7 novembre 2018.
2.2. Le censure formulate con i motivi aggiunti sono infondate.
La parte ricorrente riferisce che, in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata il 24 luglio 2019, l'Autorità ha reso accessibile il verbale e l'ordine del giorno dell'Autorità ma avrebbe negato l'esistenza dello "schema di decisione": da ciò conseguirebbe l'illegittimità del provvedimento perché deliberato senza il rispetto delle regole procedurali. Mancando lo "schema di decisione" su cui il collegio si sarebbe dovuto pronunciare, mancherebbe la stessa deliberazione collegiale, la quale non potrebbe che essere assunta all'esito di una compiuta rappresentazione da parte del componente-relatore sia delle circostanze giuridico fattuali emerse nel corso dell'istruttoria sia della formulazione di una proposta sanzionatoria.
La tesi che precede è suggestiva ma infondata.
L'art. 16 del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM prevede che, una volta conclusa la fase istruttoria, "il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale".
Il successivo art. 17 dispone che "All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento...".
L'art. 20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, intitolato "Discussione in Autorità", prevede a sua volta che "Il relatore, tutte le volte che l'Autorità debba adottare una delibera, introduce la discussione, e, sulla base dell'andamento dell'istruttoria e delle proposte trasmesse dagli uffici, formula e illustra le proprie conclusioni".
La decisione da parte del collegio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento da ultimo richiamato, è adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Dalla riportata disciplina regolamentare risulta che la predisposizione di uno "schema di decisione" non rientra nell'iter procedurale ivi previsto, il che spiega perché di un simile "documento" non vi sia traccia né nel fascicolo istruttorio né in allegato al verbale.
La difesa erariale ha, altresì, spiegato che lo "schema di decisione", richiamato atecnicamente nel verbale della riunione del collegio del 25 settembre 2018, costituisce un mero appunto del relatore utilizzato nel corso della discussione collegiale, dunque privo degli elementi per poter essere qualificato come atto endoprocedimentale.
Il Collegio è consapevole del contenuto dell'ordinanza n. 6340 del 23 settembre 2019 con cui la Sez. VI del Consiglio di Stato, decidendo su questione relativa all'accesso allo "schema di decisione", in riforma dell'ordinanza n. 8271/2019 di questa Sezione, ha accolto l'appello ed ha ordinato all'AGCM di "rilasciare copia del documento" denominato "schema di decisione".
In quel frangente, relativo ad un altro provvedimento adottato dall'AGCM nella stessa seduta del 25 settembre 2018, il Consiglio di Stato ha ritenuto:
"che, nella specie, il regolamento, sopra richiamato, adottato dall'Autorità prevede quali sono le regole che devono essere rispettate nell'adozione del provvedimento finale;
che, in particolare, articola il procedimento in una fase di iniziativa, istruttoria, decisione e pubblicazione del provvedimento finale;
che il documento di cui si chiede l'accesso si inserisce nella fase della decisione, in quanto è espressamente richiamato dalla stessa Autorità nel verbale del 25 settembre 2018, che lo qualifica "schema di decisione";
che, pertanto, esso deve ritenersi "atto interno" afferente al momento decisorio ed, in quanto tale, rientra nel perimetro oggettivo dell'accesso documentale".
Tale decisione si fondava, dunque, sul convincimento del Giudice di appello che tale "documento", quantunque in forma di "minuta", esistesse e fosse detenuto dall'Autorità.
Al contempo il Collegio ricorda che, con successiva ordinanza n. 642 del 27 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha tenuto conto di quanto evidenziato dall'Autorità, analogamente a quanto avvenuto nel caso di specie, in merito all'assenza di un "documento" amministrativo qualificabile come "schema di decisione" e, nel rendere i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di ottemperanza, ha rilevato: "che se l'Autorità fosse priva materialmente di tale documento (si deve ritenere, preparato dagli uffici per il Collegio) perché non conservato o perché riferito ad una entità materiale differente rispetto a quella descritta nel verbale predisposto dalla stessa Autorità, ciò costituirebbe una circostanza tale da rendere oggettivamente impossibile l'esecuzione della sentenza...".
Il Collegio, nel richiamare un recentissimo precedente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, ord. 13 maggio 2020, n. 5023) ritiene che, alla luce di quanto precede e dei chiarimenti resi dalla difesa erariale sul punto, lo "schema di decisione" (che, stando al verbale (pag. 63), il relatore ha "illustrato" al collegio), altro non sia che un appunto personale dello stesso, recante la "scaletta" degli argomenti da trattare, potendosi perfino ipotizzare si tratti di un mero schema "mentale" che il relatore illustra al collegio, avendo ben chiari gli esiti dell'istruttoria e il tipo di sanzione da irrogare.
La conclusione che precede è, peraltro, coerente con la disciplina regolamentare, che non contempla la predisposizione di uno "schema di decisione" quale parte dell'iter procedimentale né quale snodo essenziale del processo decisionale, come già affermato dalla Sezione nell'ordinanza n. 8271/2019: ciò impregiudicata ogni valutazione dell'AGCM in ordine all'opportunità di continuare in futuro ad usare nella verbalizzazione espressioni "atecniche", quale quella in rassegna, foriere di defatigante contenzioso, ovvero di attivarsi nella predisposizione effettiva di uno "schema di decisione" da riversare agli atti del processo decisionale.
D'altra parte si deve rimarcare come la parte ricorrente abbia formulato tale censura rappresentando un vizio meramente formale, non avendo neanche allegato quale parte del verbale non sarebbe, in ipotesi, congrua con il contenuto del provvedimento, tanto da far dubitare che vi sia stata una illegittima alterazione del processo decisionale. Risulta, invece, dalla documentazione in atti, la piena coerenza di quanto riportato sinteticamente nel verbale della seduta con il ben più articolato contenuto del provvedimento: il che è di per sé sufficiente a fugare in radice i dubbi della parte ricorrente.
La circostanza, poi, che la verbalizzazione sia stata sottoscritta il 7 novembre 2018 non è di per sé sola indice di illegittimità del provvedimento.
Invero la deliberazione del provvedimento ha una data certa, non altrimenti censurata dalla parte ricorrente, che è quella del 25 settembre 2018, data vieppiù insuscettibile di essere messa in discussione dalla successiva sottoscrizione del verbale in data 7 novembre 2018, tenuto conto che è la stessa parte ricorrente a riferire di aver ricevuto notifica del provvedimento in data 24 ottobre 2018.
Anche tale censura, dunque, è infondata risolvendosi nella denuncia di un profilo formale, inidoneo a viziare il provvedimento il quale, a quella data, era già stato adottato, sottoscritto e notificato.
D'altra parte, come la giurisprudenza afferma, non è necessario che la verbalizzazione avvenga contestualmente o in un momento immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni, purché la verità storica dei fatti risulti dal verbale (C.d.S., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 2719).
Invero, "il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non comporta anche la necessaria contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla Commissione, così che la materiale redazione del verbale e l'approvazione dello stesso non devono necessariamente avvenire al termine di ogni seduta; ne deriva che la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione (Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 gennaio 2017, n. 2)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 19 marzo 2020, n. 3465).
Infondata in punto di fatto è poi la censura secondo cui la decisione dell'Autorità non sarebbe legittima poiché assunta con il contributo del Presidente, asseritamente privo dei necessari poteri di legge, tenuto conto che il Presidente Pitruzzella, come risulta dal verbale, non ha partecipato alla discussione relativa al procedimento Apple, avendo lasciato prima la seduta; fermo restando che, anche qualora vi avesse partecipato, il Presidente lo avrebbe fatto nell'esercizio dei suoi pieni poteri, essendo stato Presidente dell'Autorità fino al 30 settembre 2018.
Quanto precede, in ogni caso, dequota sia la censura di possibile illegittimità del provvedimento per essere stato assunto con il contributo di un componente di dubbia imparzialità, sia la censura per cui il provvedimento sarebbe stato assunto da un collegio composto da due Presidenti, uno titolare e uno facente funzioni, essendo pacifico che, alle ore 17.20, durante la seduta del collegio, il dott. Pitruzzella ha lasciato la riunione e che, all'esito, ha assunto le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità nell'ufficio, ossia la dott.ssa Muscolo la quale, dunque, correttamente risulta firmataria del provvedimento.
3. Prima di passare all'esame del ricorso introduttivo, per una migliore comprensione dei fatti di causa devono essere necessariamente descritte, per quanto possibile sinteticamente, le condotte oggetto di indagine, come ricavabili dal provvedimento impugnato.
Gli smartphone iPhone sono basati su un sistema operativo denominato iOS e contraddistinto da un numero che ne indica la versione, sviluppato da Apple Inc., che ne cura e distribuisce gli aggiornamenti, nell'ambito del rapporto post-vendita con gli acquirenti. Apple costantemente e ricorrentemente suggerisce, ai consumatori in possesso dei diversi modelli di iPhone, di procedere all'aggiornamento del firmware dei propri dispositivi. Specificamente, Apple sviluppa e rilascia con cadenza annuale delle nuove versioni di iOS, contenenti nuove funzioni o nuove caratteristiche delle funzioni già presenti nelle precedenti versioni, che vengono inserite nei nuovi modelli iPhone e proposte ai possessori dei dispositivi compatibili, invitandoli ad aggiornare iOS all'ultima versione disponibile.
Ciascuna nuova versione di iOS viene rilasciata per i precedenti modelli di iPhone ritenuti tecnologicamente compatibili, in alcuni casi con un ridotto set di nuove funzionalità.
L'installazione di una nuova versione di iOS può in alcuni casi creare riduzioni delle prestazioni dell'iPhone come chiarito dalla stessa Apple. Apple rilascia inoltre, nel periodo intercorrente fra una versione e la successiva di iOS, molti altri aggiornamenti software: la versione iOS 10 ha avuto 12 aggiornamenti.
Ogni nuovo aggiornamento viene proposto a tutti i possessori di iPhone sulla base di una verifica fra due soli possibili stati dell'apparecchio: "aggiornato" o "non aggiornato". In particolare, al momento del rilascio di un nuovo aggiornamento iOS e in occasione di tutte le modifiche successive, Apple avverte tutti i possessori di iPhone che un aggiornamento è disponibile, mediante un pallino rosso con il numero "1" che compare in altro a destra sull'icona "Impostazioni" della schermata Home dello smartphone. Nella schermata Impostazioni/Aggiornamento Software compaiono il pulsante per scaricare l'aggiornamento e un breve messaggio che descrive il contenuto essenziale dell'aggiornamento stesso.
Una volta che un aggiornamento sia disponibile, il professionista invia ripetutamente ai consumatori il messaggio che invita a scaricare e installare l'aggiornamento che è stato rilasciato, risollecitando periodicamente il consumatore fino a quando l'aggiornamento non viene scaricato: tale sollecitazione non può essere evitata. I messaggi si concludono con un pulsante virtuale denominato "Scarica e installa", unica opzione offerta al proprietario del cellulare, attivando la quale lo smartphone procede a scaricare e ad installare la nuova versione del sistema operativo.
Dall'esame dei dati l'AGCM ha rilevato:
- che, con i descritti messaggi, Apple segnala soltanto quali siano i miglioramenti attesi, con modalità tali da suggerire fortemente l'opportunità di effettuare l'aggiornamento e quindi invita ad eseguirlo ma non informa il consumatore sui possibili rischi che tali aggiornamenti possono determinare in termini di minore funzionalità degli apparecchi, in relazione sia alle loro caratteristiche hardware sia al loro specifico stato d'uso, e dunque sulla cautela con cui il consumatore deve valutare se procedere o meno all'aggiornamento del sistema operativo;
- che i messaggi che si concludono con il pulsante virtuale denominato "Scarica e installa" non chiariscono che tale processo è irreversibile;
- che i messaggi sono insistenti, non rifiutabili e non altrimenti eliminabili se non scaricando l'aggiornamento;
- che una volta effettuato un aggiornamento, Apple non consente il ritorno ad una versione precedente del sistema operativo iOS (c.d. downgrading).
Nel settembre 2016 Apple ha immesso sul mercato i modelli iPhone 7 e 7Plus, dotati di un microprocessore "A10 Fusion" QuadCore 64 bit a 2,3 GHz e coprocessore di movimento M10, RAM rispettivamente da 2 e da 3 Gigabyte e fotocamere da 7 (retro) e da 12 (frontale) megapixel, quindi maggiormente performanti e con capacità della batteria significativamente maggiore rispetto a quella delle batterie di quasi tutti i modelli iPhone 6. I modelli iPhone 7 e 7Plus vengono equipaggiati con il sistema operativo iOS 10, presentato come una versione fortemente innovativa di iOS.
Nello stesso periodo Apple ha rilasciato lo stesso aggiornamento del sistema operativo iOS per tutti i modelli iPhone delle precedenti versioni 5 e 6, ritenuti compatibili; sui meno recenti (versione 5), però, non sono operative tutte le funzionalità.
Dall'esame dei dati l'AGCM ha rilevato:
- che nel procedere al rilascio del sistema operativo iOS 10 per i modelli 6/6Plus/6s/6sPlus, Apple non fornisce alcuna informazione o avvertenza ai consumatori sulle sue maggiori esigenze in termini di prestazioni richieste all'hardware e di maggior assorbimento energetico e quindi anche sulla necessità di un buono stato della batteria per supportare i picchi energetici richiesti dalla nuova versione dell'iOS;
- che tale aggiornamento ha determinato, anche per il rapido consumo delle batterie, la minore fruibilità di molti iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus a causa di un inaspettato aumento della frequenza di improvvisi spegnimenti dei loro apparecchi (da Apple chiamati "UPO", ovvero "Unexpected Power Off"), pur in presenza di batterie sufficientemente cariche;
- che tale problema era già noto ad Apple almeno dal primo trimestre 2016, come risulta dalle istruzioni diramate nell'aprile e nel maggio di quell'anno per rispondere ai clienti che lamentavano spegnimenti (shut-down) improvvisi dei loro smartphone pur in presenza di una batteria carica più del 10%;
- che, quindi, iOS 10 ha provocato un peggioramento del problema degli spegnimenti improvvisi sugli iPhone 6 e 6s e un calo delle prestazioni della batteria, come testimoniato anche dal significativo aumento, registratosi nell'autunno 2016, dopo il rilascio dell'aggiornamento a iOS 10, sia delle richieste di assistenza in relazione al rallentamento dei dispositivi iPhone, in particolare per i modelli iPhone 6, sia degli interventi di sostituzione della batteria o dell'intero dispositivo per problematiche legate alla vita della batteria, alle prestazioni e agli improvvisi shut down;
- che il fenomeno degli UPO è particolarmente evidente per gli iPhone 6s, per i quali Apple a fine novembre ha lanciato una iniziativa di sostituzione gratuita delle batterie avendo riscontrato alcuni difetti di fabbricazione (mail interna del 9 gennaio 2017 che conduce ad una pagina del sito "apple.com" intitolata "Programma per problemi di spegnimento inatteso di iPhone 6s").
Nel dicembre 2016 Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 10.2 che prevede un'apposita funzionalità diagnostica per comprendere il fenomeno degli UPO e, nel gennaio 2017, ha rilasciato l'aggiornamento iOS 10.2.1, che contiene una apposita funzione di "power management", volta a ridurre i picchi di consumo richiesti da iOS 10 e seguenti, che possono non essere sopportati dalla batteria, provocando i descritti "UPO".
L'Autorità ha rilevato:
- che il messaggio che descriveva le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento in questione nel gennaio 2017 non menzionava la funzionalità di gestione dell'alimentazione, mentre quello successivo del febbraio 2017 parlava di tale funzionalità sottolineandone l'utilità con specifico riferimento alla capacità di evitare gli spegnimenti improvvisi, ma senza fornire alcuna informazione sul fatto che il sistema di power management avrebbe rallentato gli iPhone riducendone le prestazioni, in particolare quelle degli iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus con batteria non perfettamente efficiente;
- che, invece, solo nel comunicato del 28 dicembre 2017, successivo di circa 11 mesi al rilascio di iOS 10.2.1, lo scopo dell'introduzione di tale aggiornamento e le sue conseguenze sono stati spiegati e descritti da Apple;
- che neppure nelle istruzioni fornite agli operatori dell'assistenza Apple (Sistema informativo GSX) si trova alcuna informazione o avvertenza sulla riduzione delle prestazioni degli iPhone che l'aggiornamento iOS 10.2.1 avrebbe potuto provocare, nonostante tale riduzione fosse stata osservata dagli utenti persino sui modelli più recenti.
Dopo le notizie di stampa e in internet diffuse nel novembre-dicembre 2017 in merito ad una condotta adottata da Apple, consistente nella proposta di aggiornamenti del sistema operativo che rallentavano le prestazioni dei propri smartphone, per prevenire lo spegnimento del dispositivo nel caso in cui un picco di sforzo richiedesse troppa potenza alla batteria, e dopo alcune iniziative giudiziarie che hanno avuto un'ampia eco mediatica, assunte nel dicembre 2017 negli Stati Uniti e in Francia il 28 dicembre 2017, Apple ha diffuso sul proprio sito un comunicato nel quale (i) ha riconosciuto l'esistenza delle limitazioni tecniche delle batterie al litio utilizzate, che con il tempo riducono le proprie prestazioni, provocando il fenomeno degli spegnimenti improvvisi, (ii) ha dichiarato di avere introdotto con iOS 10.2.1 un sistema di gestione energetica dei picchi di lavoro di iPhone 6, iPhone 6Plus, iPhone 6s, iPhone 6sPlus e iPhone SE (esteso con iOS 11.2 anche alla gamma iPhone 7) che può rallentare il funzionamento degli apparecchi in modo da limitarne il consumo energetico e impedire così che vengano richiesti, a batterie non più nuove, dei picchi di energia che queste non sarebbero in grado di fornire, (iii) ha offerto la possibilità di cambiare la batteria di iPhone 6 e modelli successivi a prezzo di costo (riducendo il prezzo da 79 a 29 euro) per tutti i consumatori che lo avessero richiesto entro il 31 dicembre 2018.
Quindi l'Autorità ha rilevato che:
- per fronteggiare i problemi causati dall'aggiornamento iOS 10 Apple ha rilasciato una nuova versione del sistema operativo (iOS 10.2.1) contenente una funzione di power management che rallentava la funzionalità dei cellulari con batteria non perfettamente efficiente;
- che tale scelta è stata unilaterale, senza offrire ai consumatori alcun mezzo alternativo di ripristino dell'originaria funzionalità dell'apparecchio, ad esempio attraverso la possibilità di riportarlo nello stato precedente agli aggiornamenti con il downgrade del sistema operativo iOS o con la riduzione delle nuove funzionalità attivate sul proprio iPhone.
Apple ha, inoltre, attuato una politica commerciale finalizzata a incrementare la sostituzione, da parte dei possessori di smartphone Apple, con modelli più nuovi (c.d. "upgrade selling"), anche contando sulla obbligatoria fidelizzazione del cliente che viene indotto ad acquistare prodotti Apple e non di altre marche, dal momento che soltanto i primi "dialogano" facilmente tra loro, grazie all'unico sistema operativo iOS, ai fini dell'utilizzo delle varie app (es. "iTunes") e dei vari servizi come quello di cloud storage. Tale politica si è concretizzata nel porre attenzione al ciclo di vita degli iPhone e nell'assumere iniziative, nei confronti delle compagnie telefoniche, per la compressione del ciclo di vita degli iPhone, mediante un miglioramento delle offerte del programma annuale di sostituzioni con modelli successivi di iPhone (c.d. "Annual Upgrade Program").
Inoltre Apple è stato il primo produttore a proporre uno smartphone la cui batteria non può essere rimossa e sostituita dal proprietario se non con l'intervento di un tecnico qualificato. In aggiunta, la struttura dell'apparecchio è realizzata in modo tale da rendere necessario rimuoverne prima il sottile e fragile schermo per poterne sostituire la batteria, con la conseguenza che se lo schermo - pur funzionante - ha riportato piccoli danni che ne possono rendere dannosa la rimozione, la sostituzione della batteria diventa praticamente impossibile senza sostituire anche lo schermo.
L'Autorità ha, quindi, rilevato dalla documentazione:
- che obiettivo di Apple è mantenere e incrementare un elevato tasso di sostituzione, degli apparecchi in possesso dei consumatori, con apparecchi nuovi e che in questo contesto Apple applica e favorisce una politica di trade-in dei prodotti rispetto alla loro semplice riparazione, anche diramando istruzioni restrittive sull'ammissibilità della riparazione e sul costo da sostenere, al punto da rifiutare la sostituzione della batteria a chi abbia già effettuato precedentemente un cambio batteria presso un centro assistenza non autorizzato.
Sulla base di quanto precede l'Autorità ha concluso che Apple ha indotto insistentemente i consumatori in possesso di iPhone 6/6Plus/6s/6sPLUS alla installazione del sistema operativo iOS 10 e successivi aggiornamenti, senza fornire adeguate informazioni circa l'impatto di tale scelta sulle prestazioni degli smartphone e senza offrire (se non in misura limitata o tardiva) alcun mezzo di ripristino dell'originaria funzionalità degli apparecchi in caso di sperimentata diminuzione delle prestazioni a seguito dell'aggiornamento (quali il downgrading o la sostituzione della batteria a costi ragionevoli). Per tale via, Apple ha dunque condizionato e forzato, anche sulla base di informazioni lacunose, la scelta del consumatore medio rispetto alla necessità dell'aggiornamento del sistema operativo e ai risultati ottenibili dallo stesso, generando un potenziale limite all'utilizzo dei dispositivi e, in tal modo, accelerando la sostituzione con modelli di iPhone più recenti.
L'Autorità ha rilevato che Apple non ha modificato tali modalità di presentazione neppure quando si è resa conto dell'esistenza di un serio rischio di shut down inattesi in presenza di batterie non perfettamente efficienti, specificamente per i modelli iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus, continuando a promuovere l'installazione di iOS 10 senza informare i consumatori degli inconvenienti in cui avrebbero potuto incorrere.
Senza informare i consumatori, Apple ha incluso nell'aggiornamento iOS 10.2 un software di diagnostica attraverso il quale intendeva studiare proprio il fenomeno degli UPO osservando il comportamento degli apparecchi degli ignari consumatori ed ha poi proposto l'aggiornamento 10.2.1 introducendo una funzione di power management per ridurre la richiesta di prestazioni energetiche, senza indicare chiaramente cosa stava succedendo e permettere ai consumatori di effettuare una scelta consapevole.
Analogamente dalle evidenze è emerso che Apple ha solo tardivamente predisposto dei limitati rimedi alle riduzioni di prestazioni degli smartphone meno recenti e/o più usurati provocate dagli aggiornamenti, che non risultavano più coperti dalla garanzia legale di conformità.
Per quanto riguarda la pratica sub B) Apple dedicava alle batterie agli ioni di litio alcune pagine del proprio sito internet, nelle quali ne vantava le caratteristiche, informava su come ottimizzare autonomia e ciclo di vita della batteria per far "rendere al massimo il tuo dispositivo", avvisava che "Dopo un certo numero di ricariche la capacità diminuisce", che "Tutte le batterie ricaricabili hanno un ciclo di vita limitato" e che "alla lunga potrebbe essere necessario rivolgersi a un servizio di assistenza", e precisava che per l'apparecchio iPhone "La batteria è progettata per conservare fino all'80% della capacità originale per 500 cicli di carica completi", dove "completi un ciclo ogni volta che consumi il 100% della capacità della batteria".
Dalla documentazione, tuttavia, l'Autorità ha verificato che la problematica delle batterie, definita "annosa" in una mail interna, era nota al professionista almeno dal 2015, così come il problema degli shut down improvvisi (UPO), senza che, almeno fino agli ultimi giorni di dicembre 2017, Apple abbia fornito ai propri clienti alcuna informazione sull'esistenza di una chiara correlazione fra lo stato delle batterie e le prestazioni degli iPhone, istruzioni per la loro ottimizzazione, informazioni sul loro invecchiamento, sulla possibilità che una batteria non efficiente sia causa di spegnimenti inattesi del dispositivo o di riduzioni delle prestazioni, sull'opportunità in ultima analisi di controllare lo stato della batteria nonché di procedere ad una sua sostituzione.
Solo nel dicembre 2017 Apple ha pubblicato sul proprio sito una nuova pagina dedicata alla batteria e al suo uso affiancando il programma di sostituzione delle batterie al prezzo speciale di 29 euro per venire incontro alle numerose doglianze dei consumatori.
Dopo l'avvio del procedimento Apple ha informato l'Autorità di avere dato attuazione alle misure proposte quali impegni e di avere anche adottato altre iniziative per porre rimedi "ad ogni eventuale disguido teoricamente patito dagli utenti".
5. Le censure formulate nei 10 motivi vanno schematizzate come segue.
Con una prima e unica sostanziale censura la parte ricorrente lamenta, in estrema sintesi, il difetto di istruttoria sui vari profili tecnici sulla base dei quali l'AGCM ha ritenuto che la pratica sub A) configuri una pratica scorretta (motivi I, II, e III). Secondo Apple l'Autorità sarebbe giunta a conclusioni erronee, in assenza di prove tecniche, sul peggioramento delle performance dei dispositivi Apple e sul presunto danno arrecato dal download di iOS 10. L'Autorità, al contempo, avrebbe omesso di considerare spiegazioni alternative più plausibili e fondate su dati tecnico-scientifici, presentati nel corso dell'istruttoria da parte delle ricorrenti.
Con un secondo gruppo di motivi si sostiene che la complessiva condotta di Apple non integrerebbe gli estremi dell'aggressività e della scorrettezza, anche in considerazione dei limitati effetti che avrebbe prodotto e della durata della condotta, che sarebbe stata erroneamente stimata dall'Autorità (motivi IV, V, VI, VII, VIII e IX).
Con l'ultimo motivo, riferito alla pratica sub B), la parte ricorrente contesta di essere stata lacunosa rispetto all'informativa sulla durata della batteria affermando che le informazioni relative al normale invecchiamento delle batterie e alla conseguente necessità di sostituirle sarebbero inidonee a integrare una pratica commerciale omissiva. In ogni caso, lamenta che l'AGCM avrebbe introdotto nel provvedimento conclusivo condotte mai considerate prima, in violazione del principio del contraddittorio (motivo X).
6. L'assunto di fondo da cui muove la parte ricorrente, segnatamente nei primi tre motivi, è che mancherebbe una prova tecnica volta [a] confrontare le funzionalità dell'iPhone e della batteria prima e dopo l'installazione degli aggiornamenti iOS 10.
La parte ricorrente si sofferma a contestare che l'infrazione di cui alla pratica sub A) consterebbe di due condotte distinte e separate. Sostiene che quelle relative all'iOS 10 (e 10.1) e quelle relative all'iOS 10.2.1, all'iOS 10 e all'iOS 10.2.1 sono due diverse versioni del sistema operativo rilasciate l'una a distanza di cinque mesi dall'altra, che farebbero capo a due ipotesi accusatorie distinte che trarrebbero origine da contesti fattuali anch'essi del tutto diversi. Aggiunge che la pratica sub A) riguarderebbe anche una questione relativa all'hardware (l'ordinario invecchiamento chimico delle batterie) che l'AGCM scambierebbe erroneamente per un problema di software (il presunto pregiudizio provocato dall'iOS 10 sui modelli interessati e sulle loro batterie).
Secondo la parte ricorrente la tesi dell'AGCM secondo cui l'iOS 10 avrebbe avuto un effetto negativo sulle prestazioni dei modelli interessati e avrebbe degradato precocemente le loro batterie, sarebbe smentita dalle prove tecniche prodotte in sede procedimentale. Sostiene che l'AGCM confonderebbe l'iOS 10 con l'iOS 10.2.1 e che gli accertamenti compiuti non sarebbero in grado di sostenere la tesi dell'obsolescenza programmata e, quindi, la responsabilità a carico di Apple.
Apple ammette che la problematica esaminata, inerente la circostanza che l'iOS 10 abbia artificiosamente rallentato le prestazioni degli iPhone Serie 6 e 6s e provocato il precoce invecchiamento chimico delle loro batterie, dando luogo al fenomeno degli UPO, sia una questione tecnologica di notevole complessità, ma lamenta che l'AGCM l'avrebbe affrontata senza il supporto di prove di carattere tecnico-scientifico, rinunciando a disporre le perizie del caso. A seguire Apple si dilunga su una serie di dati tecnico-scientifici con i quali intende confutare le conclusioni cui è giunta l'Autorità.
Osserva il Collegio che la parte ricorrente fonda il suo impianto difensivo su aspetti tecnici evidentemente, per loro natura, estremamente complessi, cercando di spostare l'attenzione dalla condotta alle caratteristiche dei vari modelli di iPhone, alle specifiche tecniche dei vari aggiornamenti software e alla loro funzionalità: si tratta di argomentazioni che esulano dall'oggetto dell'accertamento svolto dall'Autorità.
La parte ricorrente, nelle sue lunghe e ripetute difese, in realtà non contesta che i fenomeni lamentati dai consumatori si siano effettivamente verificati, ma sostiene che l'Autorità non ne avrebbe dimostrato adeguatamente le ragioni tecniche.
Si tratta di un'impostazione che non coglie nel segno.
Ciò che l'Autorità ha avuto modo di accertare, sulla base di evidenze fattuali, quali le segnalazioni dei consumatori, il numero e il periodo in cui si sono verificate le richieste di assistenza, il numero elevato e le tipologie di richieste di assistenza, è che, a seguito dell'installazione di alcuni aggiornamenti, i possessori di determinati modelli di iPhone lamentavano rallentamenti nel funzionamento, limitazioni nell'utilizzo e fenomeni di improvviso spegnimento; inoltre l'Autorità ha accertato che, in concomitanza con il rilascio degli aggiornamenti e con la relativa installazione, sono aumentate vertiginosamente le richieste di assistenza da parte di utenti che lamentavano i suddetti malfunzionamenti. Fenomeni, questi, che l'utente non poteva evitare stante l'insistenza e l'aggressività con cui Apple sollecitava di scaricare gli aggiornamenti in uno con la carenza informativa circa gli effetti negativi che ne sarebbero potuti conseguire e l'irreversibilità del download, dal momento che Apple non lasciava all'utente alcuna possibilità di scelta né la possibilità di "tornare indietro" (downgrading), ossia di disinstallare l'aggiornamento colpevole dei malfunzionamenti, tornando alla precedente versione di iOS.
L'Autorità ha, infatti, accertato che ai consumatori che avevano acquistato iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus è stato insistentemente proposto l'aggiornamento del sistema operativo iOS 10 e del successivo aggiornamento 10.2.1, senza che fossero adeguatamente informati degli inconvenienti che tali installazioni avrebbero potuto comportare e senza provvedere, se non tardivamente ed in maniera limitata, a rimediare ai malfunzionamenti.
Nel provvedimento si legge che Apple ha potuto indurre i consumatori ad accettare tali aggiornamenti anche grazie all'asimmetria informativa esistente, la quale li induce a riporre fiducia in quanto affermato da Apple sulla utilità e bontà di tali aggiornamenti: uniche circostanze pubblicizzate.
Osserva il Collegio che per questi motivi, e non già sulla base delle caratteristiche tecniche dei prodotti, l'Autorità ha concluso che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo, in quanto Apple ha sviluppato e suggerito aggiornamenti firmware iOS 10 e 10.1.2 per gli iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus, già acquistati dai consumatori, che ne modificano le caratteristiche funzionali e ne riducono in maniera sensibile le prestazioni, inducendoli in errore circa la decisione di procedere all'installazione di tali aggiornamenti. Ha aggiunto, l'Autorità, che, sotto altro profilo, il professionista ha indebitamente condizionato i consumatori, da un lato, inducendoli ad aggiornare il firmware mediante l'insistente richiesta di procedere ad effettuare il download e l'installazione degli aggiornamenti, dall'altro, non prestando un'adeguata assistenza ai consumatori per ripristinare la funzionalità preesistente dei loro apparecchi, in tal modo accelerando il processo di sostituzione di tali apparecchi con nuovi modelli di iPhone.
Tali essendo gli accertamenti compiuti, è evidente che l'Autorità non si è spinta né poteva spingersi a indagare le caratteristiche tecniche dei vari modelli di iPhone così come degli aggiornamenti del sistema operativo, avendo correttamente circoscritto la sua indagine alla verifica di condotte risultate aggressive e scorrette, nonché contrarie alla diligenza esigibile da uno dei maggiori operatori mondiali del settore.
Tali conclusioni non risultano scalfite dalle argomentazioni contenute nei primi tre motivi di ricorso, le quali, come già detto, spostano inammissibilmente l'attenzione su un piano che non è quello su cui si è ampiamente soffermato il provvedimento impugnato.
Ne discende che i primi tre motivi devono essere respinti.
7. Con il secondo gruppo di censure Apple si sofferma sui problemi di irreversibilità dell'aggiornamento, di maggior assorbimento energetico, della necessità di un buono stato della batteria per evitare il rischio di shut-down e di altre ipotesi di malfunzionamento degli smartphone, sostenendo che tali fenomeni non sarebbero la conseguenza degli aggiornamenti di iOS.
In altri termini Apple non contesta che tali fenomeni negativi si siano verificati, ma afferma che non sarebbero conseguenza degli aggiornamenti del sistema operativo, come accertato dall'Autorità, senza, tuttavia, offrire una diversa spiegazione degli stessi, senza dimostrare di essersi attivata per limitarli e senza smentire di aver continuato insistentemente a sollecitare gli aggiornamenti in assenza di adeguata informazione sui prevedibili rischi.
7.1. L'Autorità ha accertato che gli aggiornamenti insistentemente sollecitati da Apple, una volta scaricati, hanno seriamente compromesso l'utilizzo dei dispositivi da parte degli utenti senza che questi ultimi fossero stati minimamente informati di ciò che sarebbe accaduto.
Osserva il Collegio che si tratta di una grave carenza informativa alla quale non può sopperire il suggerimento rivolto al consumatore, contestualmente all'invito all'installazione dell'aggiornamento, di visitare una pagina internet per avere chiarimenti sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti.
La scorrettezza della pratica commerciale, in ordine alla reale portata del prodotto, non può ritenersi sanata dalla possibilità per il consumatore di ottenere aliunde, o anche in un momento immediatamente successivo, ulteriori dettagli informativi, laddove il messaggio promozionale, attraverso il suo contenuto non trasparente, determinato dalle modalità di presentazione del prodotto, risulta già idoneo ad agganciare il consumatore al primo contatto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2020, n. 1418).
In materia di pubblicità ingannevole, la giurisprudenza ha sempre evidenziato la rilevanza primaria del messaggio che "prende l'attenzione" al primo contatto, che i relativi claims pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 8253) e che la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di "agganciare" l'immediata attenzione del consumatore, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in altri e successivi momenti, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 ottobre 2017, n. 10834).
È infatti riconducibile al claim principale l'effetto di "aggancio" del consumatore, il quale, allettato dall'offerta in esso contenuta, massimamente visibile, corre il rischio di omettere l'integrale lettura delle parti meno evidenziate del messaggio pubblicitario recanti la completa descrizione del prodotto e dei suoi effetti di assunzione, i quali vengono così resi disponibili e forse appresi in un momento successivo a quello in cui il consumatore deve, secondo il paradigma individuato dagli articoli del Codice del consumo posti a presidio della libertà di scelta del medesimo, disporre contestualmente, e con identica evidenza grafica, di tutte le informazioni utili ad assumere una consapevole decisione di natura commerciale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1158).
La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che la completezza e la veridicità di un messaggio promozionale vanno verificate nell'ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale e non già sulla base di ulteriori informazioni che l'operatore commerciale rende disponibili solo a effetto promozionale già avvenuto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 1523).
Nel caso di specie l'Autorità ha osservato che "grava sul professionista non soltanto l'onere di individuare dei modelli astrattamente compatibili con un determinato aggiornamento firmware ma, soprattutto, valutare e ponderare l'impatto degli aggiornamenti rilasciati per i dispositivi già in uso, tenendo conto del possibile stato dell'hardware sul quale il medesimo potrà essere installato (nel caso di specie il livello di usura della batteria)" (par. 130), soggiungendo che "Tale onere non può certamente ricadere sul consumatore cui è stato proposto insistentemente l'aggiornamento del dispositivo. Questo perché sussiste una totale asimmetria informativa tra Apple - che disegna l'hardware e il sistema operativo, ed è in grado di individuare bug e minacce alla sicurezza e conosce il modo in cui lo stato della batteria influenza le prestazioni dello smartphone - e il consumatore, il quale non può che affidarsi alla conoscenza tecnica e alla reputazione di Apple stessa. Ciò riguardo all'utilità e necessità di procedere agli aggiornamenti suggeriti dal professionista per la loro capacità di eliminare bug e minacce alla sicurezza e di migliorare le prestazioni del proprio iPhone".
La descrizione dei fatti smentisce, altresì, la tesi di parte ricorrente secondo cui la pratica in rassegna non avrebbe rivestito il carattere dell'aggressività, tenuto conto che, come affermato dalla Sezione, "le pratiche commerciali aggressive non sono necessariamente connotate dal ricorso alla violenza fisica o verbale, ma sono certamente accomunate dal fatto che il consumatore viene a trovarsi in situazione di stress che lo condiziona nel decidere e tale stress può essere determinato sia da condotte del professionista ripetute e irriguardose della volontà del cliente, sia dalla esistenza di vincoli contrattuali percepiti come opprimenti" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2245).
È stato anche chiarito che "l'espressione «pratiche commerciali scorrette» designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall'art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. La finalità perseguita dalla direttiva europea consiste nel garantire, come si desume dal «considerando 23», un elevato livello comune di tutela dei consumatori, procedendo ad un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, ivi compresa la pubblicità sleale, nei confronti dei consumatori.
Scopo della normativa è quello di ricondurre l'attività commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell'intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena "bilateralità", dall'altro, in termini [di] analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell'intero sistema economico.
Per «pratiche commerciali» - assoggettate al titolo III della parte II del Codice del consumo - si intendono tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente «correlati» alla «promozione, vendita o fornitura» di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti contrattuali.
Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno «scorretta», il comma 2 dell'art. 20 del Codice del consumo stabilisce in termini generali che una pratica commerciale è scorretta se «è contraria alla diligenza professionale» ed «è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori».
Nella trama normativa, tale definizione generale di pratica scorretta si scompone in due diverse categorie: le pratiche ingannevoli (di cui agli artt. 21 e 22) e le pratiche aggressive (di cui agli artt. 24 e 25). Il legislatore ha inoltre analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche commerciali (le c.d. 'liste nere') da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (artt. 23 e 26, cui si aggiungono le previsioni 'speciali' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis), senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla «diligenza professionale» nonché dalla sua concreta attitudine «a falsare il comportamento economico del consumatore»" (C.d.S., Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414).
Alla stregua dei declinati principi si può senz'altro concludere che correttamente l'Autorità ha fatto applicazione, nel caso di specie, delle norme di cui artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, avendo ritenuto violate, da parte di Apple, le regole di diligenza professionale esigibili da un operatore del settore di primaria importanza mondiale.
Ciò che, invero, è emerso dagli accertamenti svolti dall'Autorità è che Apple ha costruito un sofisticato sistema, tecnologico e di marketing, che, attraverso informazioni omissive e pratiche aggressive lungamente descritte nel provvedimento, condiziona fortemente il consumatore nelle proprie scelte, sotto diversi profili, schematizzabili a grandi linee come segue.
Il primo riguarda una sorta di fidelizzazione forzata dell'utente, discendente dal fatto che tutti e soltanto i device Apple funzionano con il sistema operativo iOS, di proprietà della stessa Apple, sistema operativo che non consente a tali dispositivi di interfacciarsi con i dispositivi di altre marche, facenti capo a professionisti altrettanto competitivi e leader sul mercato mondiale, i quali funzionano con differenti sistemi operativi: con la conseguenza che il possessore di un dispositivo Apple è indotto ad acquistare anche gli altri dispositivi elettronici di marca Apple, in modo tale che gli stessi possano agevolmente "dialogare" tra loro.
Il secondo riguarda la periodica, frequente e insistente proposizione di aggiornamenti software che, di fatto, una volta scaricati, rallentano e riducono le funzionalità dei modelli di iPhone meno recenti, senza che il possessore ne sia informato o pienamente consapevole: circostanza questa che, il più delle volte, induce il consumatore a disfarsi del vecchio modello per acquistare un iPhone di ultima generazione.
Il terzo riguarda la sostituzione della componentistica, ivi compresa la batteria (componente che, già soggetto a normale usura, subisce una repentina accelerazione nel degrado a causa dei pesanti aggiornamenti, di fatto imposti da Apple), che il possessore non può effettuare autonomamente con una semplice operazione, come avviene con gli smartphone di altri brand, ma che può essere effettuata soltanto presso un centro autorizzato Apple; per di più spesso incontrando serie difficoltà ad ottenere la sostituzione in garanzia di un componente (batteria) se ne risulta danneggiato un altro (display): circostanze che spesso inducono il consumatore ad acquistare direttamente un nuovo iPhone, pur di superare tali inconvenienti.
7.2. Quanto precede depone, dunque, per l'infondatezza anche della censura con cui parte ricorrente sostiene che non sarebbe stato dimostrato alcun vantaggio economico derivante ad Apple dalla pratica sub A), atteso che l'Autorità ha evidenziato che, non prestando un'adeguata assistenza ai consumatori per ripristinare la funzionalità preesistente degli apparecchi danneggiati dagli aggiornamenti, di fatto Apple ne ha accelerato il processo di sostituzione con nuovi modelli di iPhone: il che, ovviamente, rende palese quale sia il vantaggio economico conseguito da Apple (trade-in).
7.3. Non coglie nel segno neanche la censura per cui non sarebbe stato dimostrato l'effettivo pregiudizio arrecato al consumatore.
In proposito è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "Nell'assetto di interessi disciplinato dal d.lgs. n. 206 del 2005, le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie «di pericolo», essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all'Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 settembre 2019, n. 11097; id., 6 febbraio 2017, n. 1877).
7.4. Inconferente è poi la censura che contesta la validità dei dati tratti dall'aumento repentino delle richieste di assistenza a seguito dell'installazione di iOS 10, dal momento che la parte ricorrente nega l'evidenza del dato senza fornire una diversa spiegazione del picco di richieste, oggettivamente rilevato, affermando assiomaticamente che "il tasso di richieste relativamente alle quali si lamenta un rallentamento delle prestazioni (Device Running Slowly) è rimasto stabile nel tempo, e sempre a livelli piuttosto contenuti".
Neanche risulta sconfessata, dalle censure formulate in ricorso, l'evidenza che Apple ha anche tardivamente predisposto limitati rimedi alle riduzioni di prestazioni degli smartphone meno recenti e/o più usurati, provocate dagli aggiornamenti, che non risultavano più coperti dalla garanzia legale di conformità. Non risulta smentito che a novembre 2016 Apple ha introdotto un programma di sostituzione della batteria per alcune serie di iPhone 6s e, solo a dicembre 2017, ha comunicato ai consumatori la propria offerta di sostituzione della batteria a prezzo scontato. Viceversa, per le richieste di assistenza fuori garanzia di iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus pervenute nel periodo ottobre 2016-dicembre 2017, Apple non ha riconosciuto alcuna forma di assistenza gratuita, ponendo a carico del consumatore la sostituzione del prodotto della batteria e solo a marzo 2017 ha dotato gli Apple Store di uno strumento di diagnostica delle batterie, momento a partire dal quale inizia a risultare più frequente la sostituzione delle batterie rispetto a quella dell'intero prodotto.
7.5. Parimenti infondato è il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione del principio di separazione dei poteri, in relazione alla disposta inibitoria, asserendo che vi sarebbe stata l'indebita invasione delle competenze esclusive riservate al legislatore e alle Autorità regolamentari.
Osserva il Collegio che l'AGCM, con il provvedimento impugnato, dopo aver descritto minutamente le condotte e i diversi profili di scorrettezza, ne ha vietato la continuazione senza tuttavia imporre alcuna specifica modalità di attuazione della delibera; tale conclusione è confermata dal fatto che con la nota del 6 giugno 2019, versata in atti, l'AGCM ha dato atto dell'avvenuta ottemperanza di Apple all'inibitoria contenuta nel provvedimento impugnato.
7.6. Sostiene ancora la parte ricorrente che sarebbe errata la conclusione per cui la pratica sanzionata fosse ancora in corso alla data del provvedimento: ciò in quanto era stato già rilasciato l'iOS 11.3 (lanciato a marzo 2018) che ha reso possibile, agli utenti interessati da malfunzionamenti legati a tale funzionalità, disattivarla senza perdere nessuno degli altri importanti aggiornamenti di sicurezza e di funzionalità, sviluppati nel frattempo e resi disponibili con l'iOS; era stato attivato con successo il programma di sostituzione delle batterie a euro 29; l'iOS 10 era stato in ogni caso superato da successivi aggiornamenti che non hanno più destato preoccupazioni.
La censura non coglie nel segno se si considera che l'Autorità ha ancorato la durata della condotta anche al dato che era preclusa ai possessori di iPhone la possibilità di riportare il proprio apparecchio nella sua originaria funzionalità (downgrading).
Si tratta di una preclusione che Apple non solo ammette essere tuttora sussistente ma la considera tecnicamente non eliminabile e frutto di una precisa scelta imprenditoriale che non intende modificare, pur garantendo che le criticità derivanti dagli aggiornamenti siano state diversamente risolte, come confermato dall'Autorità con la richiamata nota del 6 giugno 2019.
Sotto tale profilo, dunque, non può ritenersi illegittima la conclusione dell'Autorità secondo cui la pratica accertata fosse perdurante alla data di adozione del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, tutte le censure che investono la pratica sub A) devono essere respinte.
8. Con riferimento alla condotta sub B), consistente nella mancata e insufficiente informazione circa alcune caratteristiche essenziali delle batterie a litio (quali la vita media, le modalità per la loro corretta gestione al fine di rallentarne la naturale usura e mantenere un adeguato livello di prestazioni degli iPhone), la parte ricorrente lamenta che nel provvedimento conclusivo l'Autorità avrebbe incluso omissioni informative mai contestate prima.
Si tratterebbe di: informazioni relative al fatto che le batterie dell'iPhone hanno una vita utile limitata e che potrebbe essere necessario sostituirle; informazioni relative al fatto che la batteria è un elemento importante dell'iPhone, il cui deterioramento può determinare problemi di prestazione come gli UPO; informazioni relative a come manutenere ed ottimizzare le batterie; informazioni relative alla capacità della batteria di fornire energia in tempi rapidi quando invecchia.
La censura, suggestivamente formulata, è tuttavia infondata in punto di fatto.
Invero, dalla lettura del capo VI.3 del provvedimento, risulta che l'Autorità ha richiamato le evidenze istruttorie, relative alle batterie al litio, già riportate nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, sulle quali le parti si erano difese nel corso del procedimento.
Infatti, nella suddetta comunicazione, l'Autorità ha puntualmente individuato i profili di scorrettezza della seconda condotta oggetto di accertamento e le possibili violazioni riscontrate.
Peraltro è la stessa Apple ad ammettere espressamente di essere incorsa in omessa informativa quanto meno in ordine alla "necessità di controllare cautelativamente lo stato della batteria in occasione del rilascio di nuovi aggiornamenti software, al fine di consentire un corretto uso e mantenere un adeguato livello di prestazioni dei propri dispositivi cellulari".
Dagli elementi acquisiti in istruttoria è risultato che solo a partire dagli ultimi giorni di dicembre 2017 Apple ha fornito ai propri clienti un'informazione adeguata: circa la rilevanza centrale della batteria per le prestazioni degli iPhone; circa le caratteristiche delle batterie in termini di ciclo di vita e la loro capacità di fornire energia in tempi rapidi; circa la necessità di controllare cautelativamente lo stato della batteria in occasione del rilascio di nuovi aggiornamenti software; circa il momento in cui potrebbe rendersi necessario procedere alla sostituzione della batteria.
Si tratta di tutte le informazioni necessarie al fine di consentire un corretto uso e mantenere un adeguato livello di prestazioni dei propri dispositivi cellulari e, soprattutto, al fine di consentire un'appropriata durata di vita del prodotto coerente con le richieste e le preferenze dei consumatori.
Fino a quel momento, infatti, le informazioni disponibili - soprattutto quelle sulle batterie degli iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus - tendevano ad evidenziarne soltanto pregi e vantaggi, omettendo le ulteriori informazioni rilevanti necessarie al consumatore per assumere decisioni di natura commerciale sia in ordine all'acquisto di un dispositivo con batteria a litio, sia in ordine alla opportunità e convenienza di sostituire la sola batteria anziché lo stesso iPhone, in caso di degrado definitivo del singolo componente.
È emerso anche che già nel 2015 la questione del ciclo di vita breve della batteria e del suo frequente impatto negativo sulle prestazioni del telefono era nota a Apple come "questione annosa", aggravatasi ulteriormente in concomitanza con il rilascio di iOS 10 e iOS 10.2 nel 2016.
Ritiene il Collegio che correttamente l'Autorità abbia considerato che le informazioni relative alla batteria riguardino aspetti essenziali del dispositivo e, come tali, sarebbero dovute essere rese disponibili ai consumatori conformemente alla diligenza professionale esigibile da società di un gruppo leader di mercato operante a livello mondiale nel settore dell'alta tecnologia.
Risulta immune da censure la conclusione dell'AGCM per cui le omissioni e le carenti informazioni sulle batterie degli iPhone da parte di Apple fino a dicembre 2017, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 22 del Codice del consumo: tale conclusione si fonda sul rilievo che la ravvisata omissione informativa, relativa ad una delle principali caratteristiche del prodotto che ne condizionavano le prestazioni e la durata, ha indotto in errore i consumatori sia nella decisione di acquisto sia, soprattutto, in quella di corretta fruizione e sostituzione degli apparecchi iPhone.
Conclusivamente, per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
9. Le spese del giudizio, nei confronti dell'Autorità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Possono, viceversa, essere compensate con le parti controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, in favore dell'AGCM, liquidandole in euro 7.000,00 (settemila) oltre oneri di legge, se dovuti.
Compensa le spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.