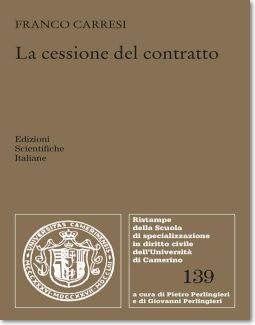Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 13 luglio 2021, n. 5307
Presidente: Montedoro - Estensore: Simonetti
FATTO E DIRITTO
1. L'odierno appellante ha premesso di essere azionista di Unicredit e di avere partecipato in tale veste all'assemblea generale svoltasi in Roma il 13 maggio 2014 per l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2013, eccependo in tale occasione l'irregolarità del bilancio per asseriti gravi errori contabili consistiti nell'omessa indicazione del conto economico di 353 miliardi di euro pari all'aggregato monetario utilizzato dalla banca per impieghi e prestiti alla clientela. Assumendo che la rettifica del bilancio consolidato avrebbe dovuto condurre a registrare un utile lordo di 487,9 miliardi anziché la perdita indicata in bilancio di 15,2, ha invocato il disposto dell'art. 930 c.c. sostenendo che alla luce di tale "scoperta" Unicredit gli avrebbe dovuto riconoscere una "ricompensa".
A fronte del rifiuto di Unicredit, ha premesso altresì di avere promosso una causa civile dinanzi al giudice civile e, avendo necessità di acquisire documentazione relativa al "rapporto riserve/impieghi relativi agli esercizi dal 2013 al 2019" e ai "mastrini contabili e flussi finanziari dei conti di servizio interni usati per le operazioni di prestito ed impiego alla clientela dei medesimi esercizi", di avere vanamente richiesto l'ostensione di tali documenti ad Unicredit.
2. Proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., qualificando il proprio interesse come "difensivo" ed assumendo che Unicredit sarebbe soggetta alla disciplina sull'accesso di cui alla l. 241/1990 in quanto investita di un'attività "di pubblico interesse" che troverebbe il suo fondamento nella tutela del risparmio di cui all'art. 47 Cost., il Tar lo ha respinto con sentenza 2270/2020.
Ciò sul fondamentale presupposto che l'attività bancaria non rientri nella definizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990 e che dunque non sia invocabile in relazione ad essa il diritto di accesso ivi disciplinato.
3. Avverso la sentenza il S. ha proposto il presente appello, deducendone l'erroneità per non avere riconosciuto la rilevanza dell'attività creditizia per il perseguimento dell'interesse pubblico, come sarebbe dimostrato dal sistema di controlli pubblici cui tale attività è sottoposta e dall'evoluzione registratasi a far data dalle crisi bancarie del 2008.
Si è costituita Unicredit, replicando con articolata memoria sia in ordine alla natura privatistica dell'attività bancaria, che renderebbe impossibile qualificare la banca quale gestore di un servizio pubblico, sia per quanto concerne l'assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, come dimostrerebbe il fatto che il giudizio civile si sia nel frattempo concluso in Cassazione con la soccombenza di parte appellante. Ha inoltre evidenziato come il diritto di accesso del socio alle informazioni sociali trovi piuttosto la sua disciplina e i suoi limiti nell'art. 2422 c.c.
Nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021, in vista della quale le difese hanno depositato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
4. L'appello è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.
Osserva il Collegio in premessa come parte appellante, pur qualificandosi quale un'azionista, ovvero un socio, della società per azioni (quotata in borsa) Unicredit, a tutela delle proprie ragioni non consta avere azionato gli strumenti e i rimedi che il diritto societario accorda specificamente agli azionisti: dal diritto di accesso alle informazioni sociali di cui all'art. 2422 c.c. all'impugnazione delle deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 2377 c.c. ove ne ricorrano i presupposti, soprattutto di legittimazione.
A tutela e in funzione delle proprie ragioni invoca invece il rimedio pubblicistico dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 241/1990, nella versione dell'accesso c.d. difensivo, invocando la previsione di cui all'art. 22, comma 1, lett. e), nella parte in cui chiarisce che per "pubblica amministrazione" si intendono anche "i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario".
Il tutto muovendo dalla tesi che l'attività bancaria rientrerebbe in tale perimetro applicativo, essendo strumentale alla tutela costituzionale del risparmio e disciplinata e sottoposta a controlli pubblici di vario tipo, a livello nazionale e comunitario.
Simile tesi, per quanto suggestiva, non è tuttavia condivisibile.
Giova premettere come la previsione della l. 241/1990 invocata da parte appellante nel fare menzione dei soggetti di diritto privato ha sempre avuto riguardo per lo più ai concessionari e gestori di pubblico servizio, legati alla pubblica amministrazione da un rapporto sicuramente (anche) pubblicistico, che ne connota l'attività, al punto da giustificare da tempo, come noto, la devoluzione delle relative controversie, tra "concedente" e "concessionario", alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a.).
Per l'attività bancaria, che nell'impianto della legge bancaria del 1936 n. 38 era stata definita come funzione di pubblico interesse e incastonata all'interno di quello che fu definito, in omaggio alla teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, l'ordinamento sezionale del credito, dopo molte incertezze la giurisprudenza aveva escluso già nel corso degli anni '80 che fosse rinvenibile la nozione di servizio pubblico e che, quindi, i dipendenti di banca fossero inquadrabili come esercenti di un pubblico servizio agli effetti della legge penale (Corte cost., n. 309/1988 citando Cass. pen., n. 5/1987 cui sarebbe seguita la pronuncia delle Sez. un., n. 10/1989).
La disciplina comunitaria sin dagli anni '70 (cfr. l'art. 1 della direttiva 77/780), tradottasi nelle riforme della legislazione italiana dei primi anni '90 (culminate in particolare nel testo unico bancario di cui al d.lgs. 385/1993, il cui art. 1, comma 1, lett. b), reca la nuova definizione), nel quadro di una rilettura dell'art. 41 Cost. e della libertà di iniziativa economica nel segno di quella che fu detta, non senza enfasi, "la nuova costituzione economica", hanno poi ulteriormente chiarito e puntualizzato come l'attività bancaria abbia carattere di impresa e come i termini e le condizioni per l'ammissione all'attività creditizia siano legati ad atti autorizzatori non più discrezionali ma del tutto vincolati e dovuti, all'insegna della liberalizzazione dell'attività creditizia. In questo contesto la vigilanza sul sistema bancario, che pure è rimasta, si giustifica su nuove basi ed è andata declinandosi sempre più in una dimensione euro-unitaria.
In questa (da più di trenta anni) mutata prospettiva, l'attività bancaria, svolta da soggetti di diritto privato, non può dunque farsi rientrare nel perimetro applicativo della disciplina sul diritto di accesso. Senza che valga richiamare (peraltro con un semplice accenno, che avrebbe meritato un ben più ampio svolgimento) le vicende delle crisi bancarie post 2008 e il tema della trasparenza per inferirne, di nuovo come un tempo, in assenza di dati di diritto positivo significativi, la possibilità di qualificare l'attività creditizia come espressione e funzione di pubblico interesse.
Dati di diritto positivo che - sia detto per completezza - non possono essere rinvenuti neppure nelle recenti misure legislative di straordinario sostegno alla liquidità, anche attraverso il forte "incoraggiamento" all'erogazione del credito da parte delle banche a beneficio di famiglie ed imprese colpite dalla pandemia, misure che, complementari a quelle di politica monetaria adottate a livello europeo dalla BCE, sono state a più riprese assunte prevedendo, tra l'altro, modalità istruttorie "semplificate" e garanzie pubbliche di ultima istanza (a partire dai d.l. 18 e 19/2020).
"Né deve fuorviare - per riprendere le parole, ancora oggi attuali, della storica pronuncia della Corte costituzionale del 1988 sopra ricordata - la sopravvivenza di direttive, controlli e obblighi che tuttora permangono nei confronti di ogni ente creditizio, perché essi non sono diversi da quelli previsti - anche in forme più penetranti - per altre attività economiche, la cui natura privatistica è universalmente riconosciuta (...). Questa ingerenza dei pubblici poteri nelle attività economiche di imprese private trova, infatti, legittimazione nell'art. 41 Cost., senza che ciò tuttavia ne adulteri la natura".
5. In conclusione, per tacere d'altro, dell'invocato diritto di accesso difetta nel caso di specie il presupposto legato alla natura degli atti e del soggetto che li detiene.
6. La peculiarità del caso in esame giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.