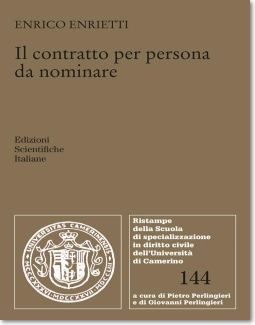Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 31 ottobre 2024, n. 28148
Presidente: Di Virgilio - Relatore: Caponi
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 il Fallimento della 3I Security International s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Apogeo s.r.l. e Alfred Oreste T., già amministratore della società 3I, in via di azione surrogatoria per la risoluzione per inadempimento del rapporto sorto in virtù di sentenza del Tribunale di Milano del 2014, che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla promissaria acquirente Apogeo per ottenere il trasferimento di proprietà di immobili del promittente venditore T., oggetto di un contratto preliminare del 2005. La domanda era stata accolta dal Tribunale di Milano, condizionatamente al pagamento del saldo prezzo (euro 227.512) in favore di T., entro 30 giorni dal passaggio in giudicato (pagamento che si sosteneva non essere poi avvenuto).
Il Fallimento allegava di aver convenuto oltre cinque anni prima dinanzi al Tribunale di Roma T. in un'azione di responsabilità relativa alla sua carica di amministratore della società e di aver ottenuto in corso di causa (nel 2011) un sequestro conservativo sui beni di proprietà del convenuto, fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.000.000 (con conversione in pignoramento, in seguito alla sentenza del 2013 con cui il convenuto era stato condannato al pagamento di euro 3.308.122). All'atto dell'esecuzione del sequestro sugli immobili, il Fallimento aveva constatato che qualche giorno prima sui medesimi beni era stata trascritta la menzionata domanda ex art. 2932 c.c. Inoltre, il Fallimento aveva poi avviato presso il Tribunale di Milano una procedura di sequestro presso terzi nei confronti di Apogeo (debitor debitoris) e di T. (debitore principale), procedura avente appunto ad oggetto il credito spettante a T. a titolo di prezzo (in seguito alla conversione del sequestro in pignoramento era stata assegnata la somma di euro 34.500 circa). (Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si è concluso in senso positivo nel 2020, a seguito di Cass. 5469/2020, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 2017).
Nel costituirsi in giudizio, Apogeo dichiarava di avere corrisposto il prezzo al T. e produceva a tal fine una quietanza notarile recante l'attestazione della consegna di tre assegni bancari. Nel 2019 il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione del difetto [di] legittimazione attiva del Fallimento a proporre l'azione surrogatoria. Promosso il giudizio di appello, Apogeo faceva valere tra l'altro di aver instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di T. una causa per il risarcimento dei danni per l'inadempimento della controparte al più volte menzionato contratto preliminare, che il processo si era concluso nel 2019 con una sentenza passata in giudicato in cui il credito risarcitorio di euro 213.728 era stato compensato con il controcredito di euro 227.512 (relativo al mancato pagamento del prezzo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 2014), che di conseguenza l'importo oggetto del suo asserito mancato pagamento era determinato in euro 13.780 circa. Tuttavia, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha accolto la domanda di risoluzione, rilevando che la quietanza notarile non attesta il pagamento e che il giudicato del 2019 sulla compensazione non esclude l'inadempimento rispetto all'obbligo scaturente dalla sentenza del 2014.
Ricorre Apogeo s.r.l. con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Fallimento con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo (p. 20) denuncia l'illegittima declaratoria di ammissibilità dell'azione surrogatoria in risoluzione proposta dal Fallimento. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere in capo al Fallimento la legittimazione a chiedere in surrogatoria la risoluzione contrattuale. Il creditore, secondo l'art. 2900 c.c., potrebbe agire solo per tutelare il patrimonio del debitore e non per proporre la risoluzione del contratto, potere il cui esercizio è sottoposto al margine di apprezzamento esclusivo del debitore, parte del contratto. Si deduce violazione degli artt. 100, 81 e 75 c.p.c.
Il primo motivo non è fondato.
Il riconoscimento al creditore della legittimazione straordinaria ad agire in via surrogatoria per la risoluzione del contratto stipulato dal debitore è discusso in dottrina. Infatti, l'art. 2900 c.c. esclude la surrogatoria per l'esercizio di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Chi nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sostiene che l'esercizio di quest'ultima è connotato da un carattere personale, poiché presuppone una valorizzazione dell'interesse alla cessazione del rapporto contrattuale prevalente sull'interesse alla prosecuzione di quest'ultimo. Tale valutazione comparativa tra i due interessi contrapposti spetta esclusivamente al debitore, affinché egli possa valutare l'eventuale prevalenza di motivi che lo sollecitano a non risolvere il contratto, nonostante l'inadempimento della controparte.
Chi sostiene invece tale legittimazione dei creditori fa leva sul carattere eccessivo degli inconvenienti scaturenti dall'accoglimento della tesi negativa: poiché il contratto con prestazioni corrispettive è uno dei principali strumenti di trasferimento della ricchezza patrimoniale, negare la legittimazione dei creditori ad agire per la risoluzione del contratto restringe in modo sproporzionato gli strumenti a loro disposizione per conservare la garanzia patrimoniale, favorendo comportamenti omissivi o collusivi del debitore.
È la tesi che nega la legittimazione dei creditori quella che convince di meno. Non tanto per l'argomento fondamentale fatto valere dai sostenitori della tesi positiva, che pure non è del tutto privo di peso. Infatti, tale argomento è affetto dalla debolezza che affligge tipicamente gli argomenti che si appoggiano essenzialmente a profili funzionali, senza condurre fino in fondo il tentativo di basare in modo circostanziato tali profili sul testo della norma giuridica (nel caso attuale, l'art. 2900 c.c.), che costituisce pur sempre il punto di partenza (e di ritorno) dell'opera interpretativa.
La tesi negativa della legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto è da criticare, in modo più convincente, sul terreno suo proprio. In primo luogo, l'azione di risoluzione del contratto non rientra certamente fra quelle che «per disposizione di legge non possono essere esercitat[e] se non dal loro titolare». In secondo luogo, essa non è da qualificare nemmeno come una specie delle azioni che per loro «natura» competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario (la parte contrattuale). Se infatti alla parola "natura" si assegna il significato dovuto ove la si rivolga ad un istituto giuridico, essa è chiamata ad indicare l'essenza ovvero le caratteristiche strutturali che definiscono quest'ultimo all'interno del sistema giuridico. Allora, anche la tesi negativa della legittimazione ad agire non è sorretta tanto da ragioni attinenti alla «natura» dell'azione di risoluzione, quanto da ragioni funzionali, dirette a preservare in capo al debitore la valutazione della prevalenza dell'interesse a mantenere efficace il rapporto contrattuale, nonostante l'inadempimento della controparte.
Ebbene, tale profilo funzionale si scontra con il testo dell'art. 2900 c.c., ma non tanto con la parola «natura» da esso recata, quanto piuttosto con il requisito dell'inerzia del debitore, che costituisce il presupposto fondamentale dell'azione surrogatoria. Infatti, se si nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sulla base dell'esigenza di proteggere l'interesse del debitore a mantenere in piedi il rapporto contrattuale (attraverso il mancato esercizio dell'azione, pur in presenza dell'inadempimento della controparte), si finisce con l'attribuire implicitamente all'inerzia del debitore la funzione specifica di realizzazione dell'interesse di quest'ultimo al mantenimento del rapporto: una funzione specifica che la pura e semplice inerzia, come tale, non può avere.
Infatti, di per sé, l'inerzia o il silenzio di un soggetto di diritto rispetto ad un'iniziativa di tutela di un interesse proprio ha un significato equivoco, ben potendo essere ricondotta all'una o all'altra di due ragioni confliggenti: la semplice trascuratezza oppure la decisione consapevole. Ed è proprio l'art. 2900 c.c. che risolve l'equivocità del comportamento inerte del debitore nel senso della trascuratezza. Pertanto, la tesi negativa della legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sostituisce - una volta per tutte, in generale - a tale valutazione legislativa una valutazione dottrinale che propende a vedere nell'inerzia (laddove concerna la scelta di domandare la risoluzione del contratto) piuttosto la conseguenza di una decisione consapevole del debitore.
Ciò costituisce un'operazione indebita.
A tale argomentazione sostanziale, che è di per sé sufficiente a scartare la tesi negativa a vantaggio di quella che afferma la legittimazione ad agire dei creditori, si aggiunge anche un'argomentazione di ordine processuale: il debitore è litisconsorte necessario nell'azione surrogatoria (art. 2900, comma 2, c.c.). Ciò consente di recuperare al dibattito processuale l'eventuale interesse del debitore a mantenere efficace il rapporto contrattuale, pur a fronte dell'iniziativa del legittimato straordinario diretta a rimuoverlo.
Tale soluzione non è contraddetta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'azione surrogatoria ha carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Sotto tale profilo, la proposizione non fa che confermare il carattere dell'art. 2900 c.c. di disposizione attributiva di legittimazione straordinaria ai creditori. Se ne è fatto discendere che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Quest'ultimo non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo (così Cass. 34940/2022, 58/2012).
Tale orientamento delinea (a contrario) il seguente corollario: se il debitore non esprime alcuna volontà di gestire il rapporto e rimane inerte, si integra il presupposto fondamentale perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale può così sindacare l'astensione del debitore dall'esercizio dei suoi diritti nell'ambito del rapporto, salva la facoltà di quest'ultimo, chiamato a partecipare necessariamente al processo avviato dal creditore, di sostanziare nel dibattito processuale le ragioni della sua inerzia, nel senso dell'interesse a mantenere in vita il rapporto contrattuale pur in presenza dell'inadempimento della controparte.
Il primo motivo è rigettato.
2. Il secondo motivo (p. 28) denuncia l'errata declaratoria di inadempimento. Essenzialmente si fa valere che, entro il termine di 30 giorni previsto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., la promissaria acquirente aveva comunque consegnato gli assegni al promittente venditore, che rilasciò una quietanza notarile. Pertanto, non si sarebbe configurato alcun inadempimento rilevante, dato che la somma era stata corrisposta e il mancato incasso degli assegni non può essere imputato alla società. Si deduce violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso rinviene il proprio asse portante nel sovrapporre l'apprezzamento di parte sul carattere importante o meno dell'inadempimento a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, la quale pertanto si sottrae a censure proponibili in sede di giudizio di legittimità. In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce questione di fatto affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020). Ne segue che può lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l'orientamento interpretativo dischiuso da Cass., Sez. un., 8053/2014.
3.1. Il terzo motivo denuncia il mancato accertamento di una compensazione atecnica (come operazione di computo reciproco di dare e avere entro un medesimo rapporto). Si deduce violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c. Si fa valere che, nel momento in cui si è trovata a verificare l'asserito inadempimento da parte della Apogeo dell'obbligo di pagamento del prezzo, la Corte avrebbe dovuto valutare la contrapposta pretesa di quest'ultima relativa al risarcimento del danno (da inadempimento del contratto preliminare), accertata con la sentenza del 2019 che ha disposto altresì la compensazione tra i due crediti e verificare se, nel rapporto di dare e avere, la somma residua (dopo la compensazione) dovuta da Apogeo fosse tale da integrare inadempimento grave.
Nella parte censurata (p. 15 s.), la sentenza sostiene che Apogeo ha invocato la compensazione tra il proprio credito risarcitorio (accertato dal Tribunale di Milano nel 2019) e il credito vantato da T. in forza della sentenza del Tribunale di Milano del 2014 e quindi ammette che tale credito non è stato estinto per pagamento. La circostanza che il Tribunale di Milano con la sentenza del 2019 (passata in giudicato) abbia effettivamente compensato tra Apogeo e Alfred Oreste T. il credito risarcitorio della prima con il credito di euro 227.512 vantato da T. (con estinzione parziale di questo) non esclude l'inadempimento della società all'obbligo scaturente dal rapporto costituito con la sentenza del Tribunale di Milano del 2014, che era da adempiere (ma non lo fu) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il controricorrente sorregge l'argomentazione della Corte di appello con due argomenti. Il primo: l'art. 1458 c.c. dispone che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti; pertanto, per verificare se ricorrano le condizioni per la risoluzione, occorre guardare al momento in cui la prestazione doveva essere effettuata. Il secondo (che è in realtà il rilievo di un fatto, non un'argomentazione giuridica): alla data della risoluzione nel 2015 non era stata nemmeno proposta la domanda di risarcimento che poi sfocerà nel 2019 nell'accertamento giudiziale della risoluzione parziale.
3.2. Il terzo motivo è fondato.
Il quesito di diritto che esso pone è il seguente: ai fini del giudizio di accertamento dell'inadempimento contrattuale posto alla base di una domanda di risoluzione del contratto devono essere considerati o meno i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in questo caso il giudicato del 2019 del Tribunale di Milano) che incidono sulla qualità dell'inadempimento (nel caso attuale, che lo rendono meno importante rispetto a quello esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione)?
Si tratta - niente di più, ma neanche niente di meno - del tema della rilevanza dei fatti che incidono sulla fattispecie del diritto dedotto in giudizio, sopravvenuti dopo l'inizio del processo. Ciò che vale in generale per questo tema deve poter valere anche per il caso attuale, salvo che esistano norme che dispongano specificamente qualcosa di diverso (tale non è l'art. 1458, comma 1, c.c., come mostra di ritenere il controricorrente, ma sul punto si ritornerà più avanti).
Si collochi innanzitutto la tesi della Corte di appello nella migliore luce possibile al fine di poterla ipoteticamente accogliere. Si esordisca quindi ricordando la teoria (chiovendiana) che ha individuato, quale ratio comune a una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura civile «una tendenza generale che si manifesta ad ogni passo nelle leggi processuali, secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione». All'interno di questa serie di norme sono distinte quelle che riguardano il vincitore attore, e che si riconducono all'idea «che la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell'attore», per cui: «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziaria».
Se si conducesse questa concezione alle conseguenze estreme sul terreno rilevante, si arriverebbe ad escludere la rilevanza della sopravvenienza nel corso del processo dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi (o del venir meno del fatto costitutivo) del diritto dedotto in giudizio dall'attore, così che l'accertamento giudiziale sarebbe ancorato al momento della litispendenza. È questa in effetti la struttura della litiscontestatio nel diritto romano, avvenuta la quale le questioni giuridiche e fattuali sollevate non potevano più essere modificate o aggiunte dalle parti. Il contenuto della controversia era cristallizzato in quel momento e il giudice doveva risolverla sulla base di ciò che era stato convenuto appunto al momento della litiscontestatio.
È questa l'idea che guida il pensiero della Corte di appello e che le fa scrivere: «alla scadenza di tale termine [quello di trenta giorni fissato dalla Tribunale di Milano nella sentenza del 2014], avvenuta anni prima rispetto alla sentenza di compensazione, la società a cui erano stati trasferiti gli immobili si rese pertanto inadempiente e T. non si adoperò in alcun modo, non attivandosi per ottenere la soddisfazione delle sue spettanze, né per la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso».
È questa l'idea che sorregge il pensiero del ricorrente nel momento in cui egli individua il momento del tempo a cui si riferisce l'accertamento della sussistenza dell'inadempimento invocando la rilevanza di un predicato - la retroattività della risoluzione - che l'art. 1458, comma 1, c.c. riferisce per l'appunto solo all'efficacia nel tempo degli effetti della pronuncia, non al referente temporale dell'accertamento dei fatti costitutivi di quest'ultima: tra gli uni e gli altri vi è tutta la differenza di «natura» che passa tra l'effetto giuridico e la fattispecie che è chiamata a produrlo.
Dunque, l'idea è che il diritto dell'attore in risoluzione ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale è da accertare con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento in cui l'inadempimento si manifesta o meglio: al momento in cui si propone la domanda giudiziale di risoluzione.
3.3. Tale concezione è destituita di fondamento.
Già il riferimento storico alla litiscontestatio del diritto romano mette sull'avviso. L'idea sottesa al processo civile moderno è opposta, come scrisse già intorno agli anni '30 del secolo scorso un insigne studioso del processo civile nato in terra sarda: il processo non determina «una sospensione della vita intorno al diritto» (sostanziale fatto valere in giudizio). Bloccando la rilevanza della sopravvenienza al momento della litispendenza, tale concezione si pone in contrasto frontale di volta in volta (a seconda del tipo di pronuncia e/o del tipo di fatti sopravvenuti) con il principio di economia processuale (esponendo il sistema a decisioni date inutilmente, in quanto i fatti sopravvenuti nel corso del medesimo processo, che potrebbero condurre a una pronuncia di contenuto diverso da quella che si va ad emanare, dovrebbero poter essere trattati in un secondo processo) ovvero con l'esigenza di emanare una pronuncia che sia (almeno programmaticamente) conforme alla situazione sostanziale esistente al tempo della decisione medesima.
D'altra parte, la concezione chiovendiana poc'anzi ricordata non può essere condotta a queste conseguenze estreme, in quanto la regola per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che risulterà avere ragione è solo una ratio comune ad una serie di norme, ma non individua un principio generale, come tale applicabile al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Sulla base di questa ratio lo stesso fondatore della scuola moderna del diritto processuale civile italiano non effettuò alcuna applicazione analogica al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Vero è che la soluzione corretta, poiché non esistono prescrizioni contrarie, è di consentire l'introduzione dei fatti sopravvenuti nel corso del processo sino all'ultimo termine per l'allegazione dei fatti, cosicché sia consentito l'accertamento giudiziale a maggiore vicinanza temporale - che sia compatibile con la struttura del processo - rispetto all'emanazione della pronuncia.
In altri termini e in conclusione, la soluzione accolta dall'ordinamento è quella di riferire l'accertamento giudiziale all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza, cosicché sia permesso all'organo giudicante di dichiarare quale sia la volontà della legge specificatasi per il caso concreto, in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile.
Tutto ciò, salvo che non esista una disposizione specifica di segno contrario, ma tale non è - come si è già anticipato - l'art. 1458, comma 1, c.c. Infatti, una cosa è - il ripetere giova - disporre che gli effetti giuridici della pronuncia di risoluzione siano retroattivi (in linea con la ratio che la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione). Altra cosa (e radicalmente diversa) è dire che il giudizio sui fatti costitutivi della pronuncia (nel caso attuale, il giudizio di importanza dell'inadempimento) debba essere ancorato al tempo dell'inizio del processo. Non vi è alcuna implicazione logica tra la seconda cosa e la prima, poiché nulla impone che una qualità temporale degli effetti giuridici debba valere anche a proiettare indietro il tempo a cui è da ancorare il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.
3.4. Va da sé che gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte specificamente rilevanti per il caso attuale si conformano a questa impostazione.
Si è così statuito che l'adempimento contrattuale (anche parziale) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto. Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all'incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Inoltre, si può delineare qualche altro tratto specifico: ove il convenuto risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non inadempiente in quanto la prestazione non era ancora esigibile a quel tempo, la sopravvenuta esigibilità in corso di causa (senza che il convenuto adempia) determina la rilevanza della vicenda al fine della pronuncia di risoluzione (così, oltre a Cass. 10490/2004, Cass. 3378/2004, 1497/1987). Ancora: l'inadempimento delle obbligazioni che vengano a scadere durante il giudizio di risoluzione è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 358/1991). L'adempimento tardivo dopo la domanda di risoluzione è considerato dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento (Cass. 10490/2004, 10632/1996, 6367/1993, 6121/1993, 1391/1989, 6959/1988).
3.5. Ad un certo punto, il controricorso insinua il sospetto che gli atteggiamenti difensivi del convenuto abbiano contribuito a propiziare l'esito espresso nella sentenza del 2019. Una volta raccolta, questa suggestione fattuale può incontrare una risposta nell'unico modo possibile in sede di legittimità: facendo segno all'art. 404, comma 2, c.p.c.
3.6. Il terzo motivo è accolto.
4. In sintesi, è accolto il terzo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi (primo e secondo), la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere (oltre che sulle spese del giudizio di legittimità) secondo la direttiva impartita nel secondo capoverso del paragrafo 3.4.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi (primo e secondo), cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.