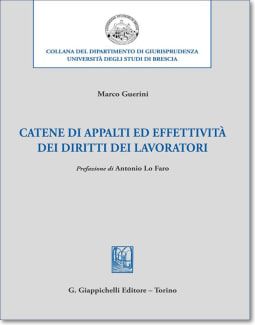Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 10 gennaio 2025, n. 5041
Presidente: De Marzo - Estensore: Fiordalisi
RITENUTO IN FATTO
1. La ricostruzione della vicenda processuale.
1.1. Giovanni Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza n. 1141 del 30 ottobre 2024 (depositata il 4 novembre 2024 e notificata al difensore il 5 novembre 2024), con la quale la Corte di appello di Roma, nella veste di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., ha rigettato l'istanza, motivata dalla sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 c.p., di revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione emessa il 18 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022) per due delitti commessi durante il suo mandato di Sindaco di Roma Capitale, ritenendo che le condotte ascritte ad Alemanno costituissero interventi quantomeno indebiti, in quanto comportanti violazione della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, essendo pubbliche le società destinatarie dell'intervento illecito. I comportamenti dell'Alemanno sono stati ritenuti posti in essere in relazione all'esercizio delle sue funzioni di Sindaco e quindi rientranti nella forma aggravata del reato, prevista ora dal quarto comma dell'art. 346-bis c.p.
Nel processo di cognizione, con la sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma del 25 febbraio 2019, che aveva ritenuto l'imputato Alemanno responsabile per i reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica posti in continuazione tra loro.
Al capo 1) erano stati attribuiti all'Alemanno fatti corruttivi, che verranno esaminati nel prosieguo, ai limitati fini necessari alla delibazione dell'odierno ricorso, considerato che, per alcune delle condotte, è intervenuta assoluzione.
Al capo 2) era stato altresì contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 7, commi 2 e 3, I. n. 195 del 1974, 4, comma 1, I. n. 659 del 1981, 110 c.p., perché in concorso tra loro, Buzzi, quale amministratore di fatto della cooperativa Formula Sociale, in accordo con Carminati, erogava nel 2014 ad Alemanno, Consigliere comunale presso il Comune di Roma, la somma di almeno 10.000 euro, che riceveva tramite la Fondazione Nuova Italia, con bonifico senza la deliberazione dell'organo sociale competente per finanziare una cena elettorale per le elezioni europee, mascherando la elargizione come finanziamento alla Fondazione, che per statuto non poteva finanziare campagne elettorali.
1.2. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che la condotta di Alemanno continui oggi a rivestire il carattere della illiceità penale e rientri pienamente nella previsione del primo comma del novellato art. 346-bis c.p., ed ha così rigettato l'istanza di revoca della condanna irrevocabile.
1.3. La difesa ha censurato il provvedimento impugnato sulla base del fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sarebbe stato abrogato il delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p., depenalizzato con la l. 9 agosto 2024 a decorrere dal 25 agosto 2024), che costituiva, per come è stato spiegato a pag. 21 della sentenza della Corte di legittimità intervenuta nella vicenda (Sez. 6, n. 40518 dell'8 luglio 2021) il "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per le cooperative riconducibili al privato committente (Buzzi), le quali sarebbero state soddisfatte nei loro crediti prima di altri creditori.
Con la sentenza n. 40518 dell'8 luglio 2021, per quanto rileva in questa sede, la Sesta sezione di questa Corte, qualificate le condotte ascritte al capo 1 nel diverso reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, comma terzo, c.p., ha evidenziato che «l'attività di mediazione onerosa, oggetto dell'accordo intercorso tra Buzzi e il ricorrente, si è caratterizzata infatti dalla illecita finalità di far ottenere alle cooperative di Buzzi un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (normativa espressamente richiamata a pag. 57 della sentenza di primo grado)».
Per il ricorrente, infatti, il reato di cui al capo 1 non sussiste, perché mancherebbe la finalità di ottenere dalle società pubbliche interessate (Eur s.p.a. e Ama s.p.a.) il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, atteso che i crediti delle cooperative erano reali e il loro pagamento costituiva atto dovuto.
La Corte di cassazione (Sez. 6, n. 40518 dell'8 luglio 2021), a questo proposito, alle pagg. 20 e 21 ha precisato che di per sé la finalità illecita della mediazione consisteva, rispetto ai crediti vantati verso le società pubbliche, nello scopo di "far ottenere alle cooperative di Buzzi un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della p.a." e che agli effetti dell'art. 346-bis c.p. è sufficiente la finalità illecita dell'accordo, sicché è irrilevante stabilire se effettivamente i pagamenti effettuati dai pubblici agenti siano stati commessi in violazione di regole specifiche di condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e come tale vada rigettato.
1.1. Con la sentenza n. 40518 dell'8 luglio 2021, come si è detto, la Sesta sezione di questa Corte, qualificate le condotte ascritte al capo 1 nel diverso reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, comma terzo, c.p., ha evidenziato che «l'attività di mediazione onerosa, oggetto dell'accordo intercorso tra Buzzi e il ricorrente, si è caratterizzata infatti dalla illecita finalità di far ottenere alle cooperative di Buzzi un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (normativa espressamente richiamata a pag. 57 della sentenza di primo grado)».
La sentenza n. 40518 del 2021 ha aggiunto:
a) che non costituiscono «oggetto di specifica censura le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sulla finalità illecita della mediazione, ovvero che essa mirava a realizzare, nell'interesse del gruppo Buzzi, il compimento da parte di pubblici agenti di atti contrari ai doveri di ufficio (in ragione della violazione della normativa sopra richiamata), ovvero la realizzazione di condotte qualificabili oggettivamente come fatti di abuso di ufficio (art. 323 c.p.)»;
b) «che nel caso in esame siamo in presenza dell'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 346-bis c.p. della "mediazione qualificata" ovvero del traffico influenze illecite che vede protagonista, come trafficante, un pubblico agente».
La Corte di legittimità ha precisato al riguardo che «il carattere illecito della mediazione c.d. onerosa realizzata dal ricorrente discende, ancor prima e indipendentemente dal risultato illecito che le parti intendevano perseguire, dalla vendita da parte di un pubblico ufficiale della sua influenza su altri pubblici agenti.
In tale evenienza, la stessa mediazione (farsi promettere o ricevere denaro in cambio della propria interferenza) costituisce per il pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri di ufficio e, quindi, sufficiente a costituire il disvalore apprezzabile penalmente tutelato dalla norma».
La Corte di legittimità quindi:
a) ha annullato senza rinvio la sentenza di merito impugnata, in relazione alla vicenda dello sblocco dei pagamenti da parte di A.M.A. s.p.a., per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili;
b) ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al residuo reato di cui allo stesso capo 1 e di quello indicato nel capo 2, nonché per le decisioni in tema di confisca con riguardo alla vicenda dello sblocco dei pagamenti da parte di A.M.A. s.p.a.
A tale sentenza di annullamento è seguito il giudizio di rinvio conclusosi con la suddetta sentenza di condanna del 18 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma (divenuta definitiva il 18 novembre 2022).
1.2. Giova precisare che, alle pag. 26 e 27, la sentenza n. 40518/21 della Corte di legittimità aveva richiamato le risultanze evidenziate nelle sentenze di merito, nelle quali era stato esposto che da dicembre 2012 al 30 aprile 2013 vi erano stati contatti tra Buzzi e il segretario del sindaco, quindi tra Buzzi, Panzironi e Alemanno, per ottenere tramite quest'ultimo lo sblocco dei crediti delle cooperative di Buzzi verso Eur s.p.a., mediante il trasferimento di fondi da parte del Comune di Roma a Eur s.p.a.
Altro incontro doveva essere effettuato con Mancini di Eur s.p.a. come promesso da Alemanno dopo il 21 gennaio 2013, anche se poi l'incontro non era avvenuto, tanto che Buzzi aveva cercato di organizzarne un secondo, tenutosi all'uscita dal Campidoglio la sera del 29 gennaio 2013.
Quindi, fino alla fine di aprile 2013, si erano verificati incontri con Buzzi per risolvere il problema dei pagamenti.
In tale contesto, a febbraio 2013 Buzzi aveva dato atto che Alemanno aveva chiamato il nuovo vertice di Eur s.p.a., Borghini, per sbloccare la situazione creditoria della cooperativa "29 giugno".
La Corte di appello nella sentenza di condanna aveva precisato che l'intervento di Alemanno (come risulta a pag. 28 della sentenza della Cassazione n. 40518/21) era stato remunerato da Buzzi con un versamento di 25.000 euro per la cena elettorale del 19 aprile 2013.
La riqualificazione dell'originario capo di imputazione di corruzione propria (art. 318 c.p.) nel reato di cui all'art. 346-bis c.p., nella forma della mediazione onerosa per Alemanno, è avvenuta, come detto, in virtù della citata sentenza n. 40518 della Cassazione dell'8 luglio 2021.
Per quanto ancora rileva, i giudici di legittimità hanno precisato altresì (pag. 17) che non era stata prospettata alcuna ipotesi di corruzione dei soggetti rispetto ai quali era stata offerta l'attività di mediazione illecita e che (pag. 18 della sentenza 40518/21) era stata definitivamente accertata (capo 17) la corruzione ex art. 318 c.p. di Carlo Pucci, dirigente di Eur s.p.a., ad opera di Buzzi e Carminati con riferimento al recupero dei crediti delle cooperative verso tale società, vicenda che i giudici di quel processo non hanno collegato (né tantomeno la sentenza impugnata) ai fatti in esame e che non ha visto il coinvolgimento del ricorrente Alemanno e di Panzironi (pag. 18).
Quanto allo sblocco dei crediti delle cooperative vantati verso la società a partecipazione pubblica, la medesima sentenza di questa Corte ha osservato che l'influenza sulle decisioni «avuta di mira dalle parti era quella di far ottenere al gruppo Buzzi un trattamento di favore, in violazione della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, e quindi implicante la commissione di fatti di abuso di ufficio. Si è trattata inoltre di mediazione onerosa realizzata dal pubblico ufficiale».
Siffatte conclusioni sono state raggiunte dalla Sesta sezione alla luce dell'orientamento che muove dalla premessa per la quale l'art. 346-bis c.p., nel testo applicabile all'epoca, non chiariva quale fosse l'influenza illecita che deve tipizzare la mediazione e non era possibile, allo stato della normativa vigente, far riferimento ai presupposti e alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (la c.d. lobbying), attualmente non ancora regolamentata.
È stato, pertanto, ritenuto necessario «ancorare la fattispecie ad un elemento certo che connoti tipizzandola la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori e per l'interprete della norma».
A tal fine, si è concluso nel senso che l'unica lettura della norma che soddisfi il principio di legalità è quella che fa leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente [e, infatti, in tal senso si esprime il secondo comma dell'art. 346-bis, quale introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della I. 9 agosto 2024, n. 114): appunto, nel caso di specie, l'abuso d'ufficio].
1.3. La richiesta al giudice dell'esecuzione di annullamento della condanna si era concentrata proprio su tale profilo, traendo dall'intervenuta abrogazione dell'art. 323 c.p. la premessa per sostenere che è venuto meno quel profilo di illiceità penale del fine della mediazione che solo giustificava, nella prospettiva della sentenza di condanna, e che giustifica oggi, alla luce del nuovo tenore dell'art. 346-bis c.p., la penale rilevanza della condotta dell'Alemanno.
2. La cornice giurisprudenziale di riferimento.
Secondo Sez. un., n. 2451 del 27 settembre 2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238197-01, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso, se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Ad ogni modo, come si è appena detto, è lo stesso secondo comma dell'art. 346-bis c.p. attualmente vigente a richiedere esplicitamente che, ai fini di cui al primo comma dello stesso art. 346-bis, per "altra mediazione illecita" si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
Tuttavia, le specifiche condotte attribuite al ricorrente hanno avuto la finalità di indurre il soggetto pubblico, che nella specie era legittimato ad impegnare le società (il cui carattere pubblicistico è stato accertato nel procedimento), a commettere un reato che tale rimane, nonostante il fenomeno di abolitio parziale descritto nel paragrafo che segue.
3. Lo stato della giurisprudenza con riguardo al rapporto tra abuso d'ufficio e peculato.
Prima degli interventi riformatori dei quali si dirà infra, con la l. 26 aprile 1990, n. 86, nel riscrivere la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., il legislatore aveva eliminato dalla previsione normativa la condotta della "distrazione", lasciando - quale condotta tipica esclusiva - la sola "appropriazione".
Costituisce tuttavia principio di diritto acquisito dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 6, n. 36496 del 30 settembre 2020, Vasta, Rv. 280295-0, sulla scia di Sez. un., n. 19054 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, Vattani, in motivazione) che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 4 giugno 2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070-01).
Cionondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale.
Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20 giugno 2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766-01).
In altri termini, la destinazione del denaro pubblico al soddisfacimento sincronico degli interessi privati dell'agente e istituzionali dell'ente, contemporaneamente sussistenti, impedisce di ravvisare la diversione del denaro dalla destinazione pubblica ad esso immanente, che dà luogo all'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p.
In tale situazione avrebbe potuto, se del caso e naturalmente prima dell'abrogazione della relativa norma incriminatrice da parte dell'art. 1 della I. 9 agosto 2024, n. 114, ravvisarsi la diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio.
Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi prima dell'abrogazione dell'art. 323 c.p., infatti, ferma la ravvisabilità del delitto di peculato nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi essenzialmente privatistici dell'agente, era invece configurabile l'abuso d'ufficio in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si fosse concretizzata in un uso indebito del bene che non ne avesse comportato la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente di appartenenza (Sez. 6, n. 12658 del 2 marzo 2016, Tripodi, Rv. 266871-01; Sez. 6, n. 19484 del 23 gennaio 2018, Bellinazzo e altri, Rv. 273783-01) ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico fosse avvenuto in violazione delle regole contabili e fosse funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti (Sez. 6, n. 41768 del 22 giugno 2017, dep. 13 settembre 2017, P.G., P.C. in proc. Fitto e altri, Rv. 271283-01; Sez. 6, n. 27910 del 23 settembre 2020, Perricone, Rv. 279677-01).
4. Cronologia degli interventi di riforma del 2024.
4.1. Con l'art. 9 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, è stato inserito nel codice penale l'art. 314-bis, che introduce il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, a decorrere dal 5 luglio 2024 (art. 15, comma 1, d.l. n. 92 del 2024).
Tale disposizione stabilisce che «Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
In questa sede non è rilevante soffermarsi sul fatto che, con la legge di conversione n. 112 del 2024 (dunque, con effetto solo dal 10 agosto 2024) è stato introdotto un secondo comma nel corpo dell'art. 314-bis c.p., a mente del quale «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».
Nel preambolo del decreto-legge vi è l'espressa attestazione che l'intervento è giustificato per «la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente».
Secondo una condivisibile puntualizzazione dottrinaria, il riferimento si correla agli obblighi di incriminazione derivanti dal diritto dall'Unione europea per effetto del disposto dell'art. 4, par. 3, della direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF).
Va, al riguardo, aggiunto che il citato art. 4, par. 3, stabilisce che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato» e precisa subito che «ai fini della presente direttiva, s'intende per "appropriazione indebita" l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione».
Il successivo paragrafo 4 dell'art. 4 precisa poi che ai fini della direttiva s'intende per «funzionario pubblico» un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo».
Nella relazione governativa di accompagnamento del decreto-legge è stato specificato che lo scopo dell'intervento traeva origine dagli effetti prodotti dalla l. n. 86 del 1990 che, nel ridisegnare l'intera disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, aveva formalmente ristretto la portata applicativa dell'art. 314 c.p., limitandone l'applicazione alle sole forme di peculato per appropriazione, escludendo il riferimento alle forme di peculato per distrazione che la giurisprudenza aveva poi fatto rientrare nello spettro operativo del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.
Da qui, si legge in quella relazione, la necessità «di chiarire definitivamente i termini di punibilità di tali condotte non appropriative, anche in ragione della necessità di preciso adeguamento alla normativa euro-unitaria».
Ancora va osservato che l'introduzione della nuova figura dell'art. 314-bis c.p. ha anticipato di pochi giorni l'adozione della l. 9 agosto 2024, n. 114, che (con effetti a partire dal 25 agosto 2024, posto che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024), ha abrogato l'art. 323 c.p.
La preoccupazione del legislatore nazionale, dunque, è stata evidentemente quella di evitare che l'abrogazione del reato di abuso di ufficio determinasse l'apertura in sede UE di una procedura di infrazione per violazione della suddetta direttiva, posta - in particolare - a presidio degli interessi finanziari dell'EU.
4.2. La nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314-bis cit. presenta, per un verso, chiare analogie con il reato di peculato:
- il soggetto attivo è lo stesso (trattandosi di reato proprio che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio);
- l'oggetto materiale della condotta è il medesimo (il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui);
- è uguale il relativo presupposto dell'azione (possesso o disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio);
- muta invece la condotta, perché invece dell'appropriazione è punita la indebita destinazione.
Per altro verso, la fattispecie riprende alcuni dei tratti dell'abuso d'ufficio:
- la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare, così come avveniva sotto l'art. 323 c.p., con specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità;
- in termini identici è descritto l'evento del reato (l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto);
- uguale è la descrizione dell'elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale.
4.3. Ai fini che rilevano nel presente procedimento, occorre considerare se si versi in presenza di una innovativa fattispecie di reato o se sia ravvisabile una sostanziale continuità normativa con il reato di abuso di ufficio, sì che risultino in parte limitati gli effetti dell'abolitio criminis attuato con l'altro provvedimento legislativo, rimanendo punibili (sia pur con un trattamento sanzionatorio più lieve) alcune condotte distrattive già sanzionate ai sensi dell'art. 323 c.p.
La soluzione che risulta recepita dall'unico precedente che allo stato risulta intervenuto (Sez. 6, n. 4520 del 23 ottobre 2024, dep. 2025, Felicita) è nel senso che l'introduzione dell'art. 314-bis c.p. non ha comportato l'abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge, ma soprattutto che la fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p. sanziona le condotte "distrattive" che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio; resta fermo che l'ambito applicativo del peculato di cui all'art. 314 c.p. non risulta modificato.
4.4. Tale soluzione appare persuasiva, innanzi tutto alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'incipit del nuovo art. 314-bis c.p. ("Fuori dei casi previsti dall'art. 314"), la quale rivela che il delitto di peculato mantiene i suoi contenuti e che l'art. 314-bis va a operare sulle condotte finora sussunte all'interno dell'art. 323, ossia le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell'ente.
Ne discende che le distrazioni già qualificabili prima delle riforme del 2024 come peculato per appropriazione distrattiva, con le quali l'autore ha destinato i beni a finalità esclusivamente private, sottraendoli definitivamente dalla finalità pubblica, non sono, pertanto, suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, restano punibili ai sensi dell'art. 314 c.p.
Al contrario, i casi di indebita distrazione di beni che risultino soddisfare, comunque, interessi pubblici coesistenti con il perseguimento di interessi privati, ovvero che non ne comportano la perdita per la pubblica amministrazione, già punite come forme di abuso di ufficio, restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis c.p., fermo restando che quest'ultima previsione realizza una parziale abolitio criminis, rendendo non più punibili, tra l'altro, le condotte distrattive che non comportino violazione di specifiche disposizioni di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità.
Ulteriori forme di abolitio parziale (in questa sede non rilevanti, alla luce delle peculiarità della condotta, quali rilevate supra) scaturiscono dal fatto che l'art. 314-bis richiede che la destinazione ad uso diverso riguardi beni di cui il pubblico agente ha il possesso o la disponibilità "per ragioni del suo ufficio o servizio", mentre l'art. 323 c.p. richiedeva solo che la condotta fosse realizzata "nello svolgimento delle funzioni o del servizio".
Inoltre, l'art. 314-bis indica come oggetti materiali solo il "denaro o altra cosa mobile altrui", lasciando fuori dalla portata applicativa della nuova disposizione altri beni, quali gli immobili o le prestazioni lavorative, che invece potevano considerarsi contemplati dal "vecchio" art. 323 c.p.
5.1. Tirando le fila delle suesposte considerazioni, si osserva che la finalità illecita perseguita attraverso la condotta dell'Alemanno e avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche per pagare debiti in violazione, secondo quanto rilevato dalla sentenza n. 40518 del 2021, della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione, già sussumibile nella fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio, continua oggi ad assumere rilievo penale nella misura in cui, pur in presenza di un oggettivo, concorrente interesse della pubblica amministrazione (ciò che esclude la qualificazione come peculato di cui all'art. 314 c.p.), esprimeva l'intento di realizzare una destinazione dei beni ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.
Il tema già emerge dagli accertamenti in fatto che avevano condotto a ritenere configurabile l'abuso d'ufficio; infatti, il Tribunale di Roma nella sentenza del 25 febbraio 2019 alla pag. 57 richiamata a pag. 20 dalla suddetta sentenza della Sez. 6 n. 40518 dell'8 luglio 2021 aveva precisato:
"A tal proposito deve evidenziarsi che in base alla normativa che disciplina i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e, più in generale, l'agire della P.A., gli organi competenti per i provvedimenti adottati, nello specifico la Giunta Comunale e il Consiglio comunale, devono assumere le decisioni relative ai pagamenti di crediti liquidi ed esigibili in sede di programmazione e, pertanto, prima dell'anno di esercizio cui si riferiscono rispettando un ordine temporale.
Proprio con riferimento al principio generale del rispetto dell'ordine cronologico, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso (v. sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 18.06.2003). Quanto appena affermato non è altro che l'applicazione del generale principio informatore dell'attività della P.A. di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 241 del 1990 che nello stabilire principi generali dell'attività amministrativa, stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retata da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".
5.2. Orbene, si deve in questa sede prendere atto che la sentenza della Sez. 6 n. 40518/2021, nel qualificare la condotta di Alemanno come finalizzata alla consumazione da parte dei soggetti operanti nel Comune di Roma e nelle società pubbliche interessate (nei cui confronti si era impegnato ad intervenire ed è intervenuto) di un delitto di abuso di ufficio, secondo l'ultima formulazione dell'art. 323 c.p., ha esplicitamente qualificato le norme destinate ad essere violate come regole di condotta previste dalla legge sugli enti locali dalle quali non residuano margini di discrezionalità, sicché tale punto non può essere rimesso in discussione in questa sede. Identiche conclusioni valgono in relazione all'elemento soggettivo e ai restanti elementi rispetto ai quali, alla stregua delle superiori considerazioni, si è giustificata la conclusione della continuità normativa.
Pertanto, agli effetti dell'art. 314-bis c.p., inserito dall'art. 9, comma 1, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024, n. 112, si deve affermare la puntuale continuità normativa con l'abrogato art. 323 c.p. quale norma incriminatrice nella quale è sussumibile l'obiettivo perseguito dall'imputato.
Ne discende la conferma dell'infondatezza della pretesa esercitata dal ricorrente.
6. Stante l'infondatezza del ricorso, lo stesso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata il 7 febbraio 2025.