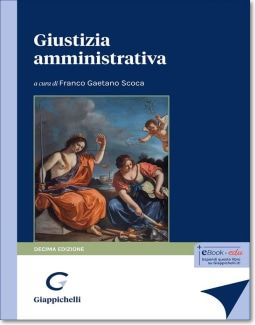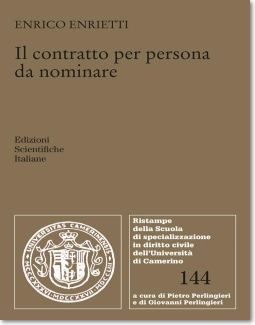Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 11 marzo 2025, n. 2014
Presidente: Pescatore - Estensore: Fedullo
FATTO E DIRITTO
L'odierno appellante, cittadino rwandese, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta in data 5 giugno 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 14 novembre 2019.
A fondamento del diniego, l'Amministrazione ha posto l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'8 maggio 2015, irrevocabile il 19 maggio 2015, con la quale, in relazione alla imputazione a carico del richiedente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. (commesso in data 8 dicembre 2014), veniva disposta la sospensione del processo per messa alla prova ex art. 464-quater c.p.p., sul rilievo che "il soprariportato carico penale è indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla sicura e rigorosa osservanza della legge penale", con la conseguente "mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza", costituente oggetto di doverosa valutazione ai fini dell'esercizio del relativo potere.
Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. 20522 del 19 novembre 2024.
Dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla natura del potere de quo, alle valutazioni all'uopo demandate all'Amministrazione, agli effetti che derivano dal suo esercizio ed ai limiti che incontra il relativo sindacato giurisdizionale, ha osservato il T.A.R. che «il giudizio prognostico compiuto dall'Amministrazione, a prescindere dalle conseguenze effettivamente riportate sul piano penale (in cui il giudizio si è concluso con una pronuncia di estinzione a seguito dell'esito favorevole della messa alla prova), non può essere ritenuto irragionevole. Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell'autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di "indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità", risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione, che a ragione (e prescindendo dall'intervenuta estinzione del reato) lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il mancato rispetto delle regole poste a fondamento della comunità nazionale».
«Non può giungersi a valutazioni diverse" - ha concluso il T.A.R. - "neanche considerando quanto genericamente allegato dal ricorrente sul proprio inserimento sociale e lavorativo, che autonomamente considerato non può superare il giudizio prognostico sfavorevole operato dall'Amministrazione in base alla condotta tenuta dal ricorrente sul territorio nazionale».
Il T.A.R. ha altresì condannato il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte, nella complessiva misura di euro 1.000,00.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l'appello in esame, dall'originario ricorrente.
Egli, dopo aver evidenziato alcuni riferimenti non pertinenti contenuti nella sentenza appellata, lamenta che il T.A.R. non ha rilevato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, non avendo l'Amministrazione preso in considerazione i molteplici indicatori dell'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dall'istante nel corso del periodo ultraventennale di permanenza sul territorio italiano (anche attraverso l'attività di volontariato dal medesimo svolta), ampiamente documentati in sede procedimentale e processuale, al fine di compararli con l'unico precedente penale a suo carico.
Deduce altresì l'appellante che anche se il fatto-reato deve essere guardato nella sua materiale storicità, l'Amministrazione è comunque tenuta a motivare in ordine alla sua concreta - e non meramente astratta - incidenza sulla condivisione da parte dell'interessato dei valori fondanti la comunità nazionale.
Deduce quindi l'appellante che l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze di seguito illustrate:
- la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, c.p., accordata con ordinanza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2015 (erroneamente qualificata in sentenza come "ordinanza di condanna"), la quale sottende l'esclusione di un giudizio di abitualità e professionalità della condotta criminosa ovvero di tendenza a delinquere (ex art. 168-bis, comma 5, c.p.);
- il pronto ravvedimento del ricorrente, che ha risarcito interamente le persone offese ed ha "regolarmente svolto l'attività di pubblica utilità ed ha osservato le prescrizioni impostigli", dando prova di concreta partecipazione al percorso sociale previsto al fine della messa alla prova: peraltro, l'appellante ha continuato positivamente il rapporto di collaborazione con la [omissis] ove ha svolto il periodo di messa alla prova, anche successivamente al termine dello stesso;
- l'adozione da parte del Tribunale di Milano di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Infine, l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite recata dalla sentenza appellata, deducendo la sussistenza dei presupposti per disporne la compensazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, l'appello è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza della Sezione (cfr. tra le tante C.d.S., Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178) ha chiarito, quanto all'obbligo di motivazione cui l'Amministrazione deve assolvere in sede di esercizio (negativo) del potere di concessione della cittadinanza italiana, che essa "è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in relazione alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, non potendosi limitare, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell'interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Quindi, la valutazione discrezionale sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto di eventuali pregiudizi penali a carico dell'interessato ma non può prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e dal giudizio sulla gravità - e sull'esito - della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto. (...) la valutazione di opportunità demandata all'Amministrazione, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero che ne abbia fatto richiesta, deve avere necessariamente carattere complessivo, ergo deve abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l'effettivo grado di adesione dello straniero ai valori fondativi dello Stato (quale forma di aggregazione, anche sulla base di quei valori della comunità in esso costituitasi), poiché solo dall'inquadramento delle singole vicende, anche penalmente rilevanti, che abbiano costellato il vissuto del richiedente entro una cornice più ampia e tale da inglobare l'intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare dell'interessato, antecedente o successivo, è possibile apprezzarne compiutamente il peso nella determinazione della scelta sottesa alla presentazione dell'istanza di inclusione nella comunità dei cittadini e del formale riconoscimento dello status civitatis (C.d.S., Sez. III, 1° dicembre 2021, n. 8022)".
Ebbene, non vi è dubbio che, ai fini della perimetrazione - quantitativa e qualitativa - dell'onere motivazionale dell'Amministrazione, laddove l'elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana sia rappresentato dai trascorsi penali dell'interessato, non può non muoversi dall'analisi del tipo di provvedimento emanato a suo carico (a seconda, cioè, della fase del procedimento penale in cui esso si colloca, e, quindi, del grado di pregnanza dell'accertamento giudiziale sul quale esso si fonda), della natura della fattispecie criminosa contestata e dell'entità della sanzione eventualmente inflitta, sì che il suddetto onere si amplia, ad esempio, man mano che dalla mera denuncia si passi ad una fase più avanzata di progressione processuale, fino a sfociare nella sentenza definitiva di condanna, e si restringe, per contro, laddove il reato contestato presenti tratti di particolare gravità, tali da sottendere il compimento da parte dell'interessato di scelte di vita insanabilmente in conflitto con quelle che si richiedono a chi aspiri a far parte di una comunità costituita in forma democratica e fondata sul rispetto dei diritti della persona, come singolo e nelle formazioni sociali di appartenenza.
Deve inoltre osservarsi che sebbene il potere valutativo dell'Amministrazione sia autonomo rispetto a quello proprio del giudice penale - per cui conserva la possibilità di attribuire rilievo ostativo a fatti di reato, laddove contrastanti con l'interesse pubblico sotteso al riconoscimento della cittadinanza italiana, anche quando il relativo procedimento penale si sia concluso con una pronuncia di archiviazione, di assoluzione o di estinzione del reato - essa tuttavia, nel compimento delle valutazioni di sua competenza, non può disinteressarsi degli sviluppi che hanno contraddistinto la vicenda penale, prendendo isolatamente in considerazione il fatto di reato indipendentemente dalle valutazioni che in ordine allo stesso abbia espresso il giudice penale nell'esercizio del suo magistero punitivo e rieducativo: se infatti la rilevanza sfavorevole attribuita in tali ipotesi alla condotta dell'interessato trae pur sempre origine dal disvalore che essa presenta in quanto astrattamente prevista (e punita) da una norma penale, che sintetizza le fondamentali regole di convivenza civile tra i consociati, quando siffatto disvalore sia ritenuto dall'Autorità giudiziaria, nella concreta evoluzione del processo penale ed in ragione del comportamento successivo dell'interessato, come attenuato se non addirittura estinto, seppure nell'ottica di valutazioni proprie della sfera penale, l'Amministrazione non può sottrarsi al dovere di verificare se, pur così ridimensionato nella sua effettiva significatività negativa sul piano della valutazione della personalità e dello stile di vita del richiedente la cittadinanza, permanga la sua valenza ostativa alla concessione dello status civitatis.
Il precedente potenzialmente ostativo deve quindi essere riguardato non nella sua dimensione statica, quale episodio negativo (battuta di arresto) del percorso di vita e di integrazione dello straniero, ma in quella dinamica, ovvero inserito nel processo rieducativo cui abbia dato stimolo e di cui sono testimonianza più immediata i provvedimenti, sanzionatori o di altra natura, adottati dal giudice penale.
Tale esigenza scaturisce direttamente dalla funzione più moderna del diritto e del processo penale, non più orientato alla punizione del responsabile del reato, ma al suo recupero ad una stabile e convinta posizione di rispetto delle leggi e di condivisione dei valori che le stesse esprimono, la quale ha trovato attuazione negli istituti che, come quello previsto dall'art. 168-bis c.p. ("Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato"), inserito dall'art. 3, comma 1, l. 28 aprile 2014, n. 67, mirano, con riferimento ai reati meno gravi, a sostituire la pena (ed il relativo processo) con misure finalizzate ad indurre nell'imputato un percorso critico di riflessione sugli errori commessi e di consapevole accettazione di un atteggiamento di vita fondato sui valori della solidarietà e del rispetto dell'altro.
Applicando le suindicate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che il reato per il quale il ricorrente è stato sottoposto a giudizio (art. 337 c.p., rubricato "Resistenza a pubblico ufficiale") non debba essere sottovalutato quale indice del grado di integrazione del richiedente la cittadinanza nel tessuto di relazioni, giuridicamente regolate, che compongono l'assetto strutturale della comunità nazionale: esso infatti denota il mancato riconoscimento del ruolo rivestito dall'autorità al fine di assicurare l'ordinata convivenza civile e, quindi, di uno dei principi sui quali si regge l'organizzazione statale.
Deve tuttavia osservarsi che, sovente, tale atteggiamento di insofferenza verso le regole dello Stato e coloro che sono istituzionalmente deputati a farle osservare non costituisce la manifestazione di una scelta volontaria e deliberata di contrapposizione verso il principio di autorità, ma di una impostazione culturale, tipica delle nazioni che non hanno concluso il loro processo di maturazione democratica, che esalta nelle figure detentrici del potere il ruolo meramente coercitivo ed oblitera quello di garanti della legalità e dell'ordine sociale.
L'incontro tra lo straniero e l'ordinamento dello Stato, pur innescato da un evento infausto quale non può non essere il fatto criminoso, può quindi paradossalmente rappresentare l'occasione per l'accelerazione del percorso di integrazione svolto sotto la supervisione del giudice penale ed avvalendosi degli strumenti, di recente conio, finalizzati come si è detto a far crescere nel responsabile del reato la consapevolezza del valore della legalità e del senso della comunità.
La doverosa valorizzazione dei fatti successivi all'episodio criminoso, ed in particolare dei relativi sviluppi processuali, rispecchia del resto la ratio del potere concessorio de quo, il cui esercizio di segno eventualmente negativo non risponde ad una funzione sanzionatoria di precedenti condotte dell'interessato, ma all'esigenza di valutare la sua idoneità ad apportare alla comunità nazionale il suo operoso contributo, in un'ottica non solo (negativa) di non offensività verso i valori che la incarnano, ma (positiva) di arricchimento delle energie vitali e solidali che ne garantiscono il progresso e ne rafforzano la coesione.
Ciò è quanto risulta essersi realizzato nella specie, se si considera che il ricorrente, con l'ordinanza del Tribunale Penale di Milano del 18 maggio 2015, è stato ammesso ai sensi della disposizione citata alla "messa alla prova", la quale, come essa recita, "comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali" ed è "inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato".
Ebbene, con la sentenza n. 9950/16 del 27 settembre 2016, il Tribunale di Milano, rilevato che l'imputato "ha documentato di aver risarcito il danno alle persone offese" e che "nella relazione dell'UEPE si dà atto che l'imputato ha regolarmente svolto l'attività di pubblica utilità ed ha osservato le prescrizioni impostegli", ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti essendosi il reato estinto, ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., secondo cui "decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato...".
Deve inoltre rilevarsi che l'osservanza da parte dell'interessato delle misure costitutive della messa alla prova non appare essere stata opportunisticamente dettata dalla volontà di sottrarsi alla pena, ma dalla radicale e stabile modifica del suo atteggiamento di vita, come si evince dalla documentazione attestante la prosecuzione del suo rapporto di collaborazione con il mondo associativo e con le istituzioni civile e religiose, iniziato nell'ambito della suddetta esperienza processuale.
Meritevole di attenta considerazione, ai fini della formulazione di un giudizio attuale e completo sul grado di integrazione raggiunto dallo straniero, è poi la documentazione attestante il suo stabile inserimento lavorativo e la consolidata capacità reddituale da questo garantita, così come la partecipazione attiva dello stesso e dei suoi familiari alla vita della comunità, nei diversi settori - sociale, religioso, scolastico e, appunto, lavorativo - in cui essa si esplica.
Deve quindi ritenersi che il provvedimento impugnato, esclusivamente incentrato sull'episodio criminoso di cui si è reso responsabile il ricorrente nel 2014 ed omettendo ogni approfondita considerazione del percorso rieducativo da lui proficuamente intrapreso, sia carente sotto i profili istruttorio e motivazionale: l'affermazione secondo cui "il pregiudizio penale... nonostante l'esito favorevole della messa alla prova... può essere valutato come fatto dal quale dedurre un comportamento irrispettoso delle regole poste a fondamento della comunità nazionale", appare invero eccessivamente riduttivo della portata rieducativa del suddetto istituto, la cui concreta efficacia risulta avvalorata dai successivi indicatori dell'integrazione conseguita dallo straniero.
I vizi evidenziati, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente ed in riforma della sentenza appellata, impongono quindi l'annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione appellata: resta assorbito il profilo censorio relativo al dispositivo di condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto travolto dall'accoglimento della domanda formulata in via principale dall'appellante e dal regolamento che segue delle spese di causa.
Sussistono in proposito, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. V, sent. n. 20522/2024.