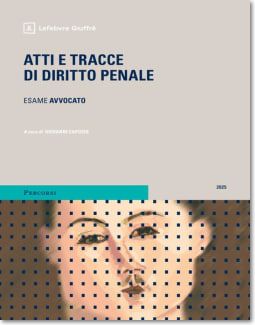Corte costituzionale
Sentenza 20 maggio 2025, n. 67
Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, nel procedimento penale a carico di A. B. e altri, con ordinanza del 12 settembre 2024, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Udita nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 12 settembre 2024, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto non sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento».
Il Collegio rimettente, chiamato a giudicare in composizione collegiale all'esito dell'udienza del 12 settembre 2024, riferisce preliminarmente che i difensori e il pubblico ministero «hanno prestato il consenso all'utilizzabilità», ai fini della decisione, delle dichiarazioni già rese da due testimoni nel corso della precedente udienza del 19 gennaio 2023, in occasione della quale il Tribunale aveva una diversa composizione collegiale e, in particolare, risultava «composto da due magistrati togati e un magistrato onorario».
Ciò premesso, il giudice a quo rileva che, a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, il giudice onorario di pace non può essere destinato a comporre i collegi del tribunale qualora si proceda per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Tale divieto, secondo «orientamento consolidato» della Corte di cassazione (vengono citate, in particolare, le sentenze della sezione terza penale, 9 gennaio-4 marzo 2024 n. 9199 e 6 luglio-26 settembre 2023, n. 39119), determinerebbe una «limitazione alla capacità del giudice», la cui violazione costituirebbe «causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1, lett. A) cod. proc. pen. [nullità] insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento». È anche richiamato un orientamento della Corte d'appello di Catania, secondo il quale la patologia che ne deriva andrebbe collocata «nella categoria dell'inesistenza dell'atto» (è citata la sentenza della sezione terza penale 5-8 luglio 2023, n. 3748).
Riferisce il rimettente che il processo della cui cognizione è investito ha ad oggetto uno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.: di conseguenza, il collegio dinanzi al quale sono state rese e verbalizzate le dichiarazioni dei due testimoni dovrebbe «considerarsi affetto da nullità insanabile»: da ciò deriverebbe la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Il giudice a quo richiama la disciplina della «acquisizione concordata della prova», di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., che configurerebbe «un'eccezione al principio della formazione dialogica della prova», potendo le parti, attraverso tale istituto, per ragioni di economia processuale, «disporre l'ingresso nel fascicolo del dibattimento di verbali formati di fronte al pubblico ministero (art. 362 c.p.p.), al difensore (art. 391 bis c.p.p.) o dinanzi ad ufficiali di p.g. (art. 351 c.p.p.) ovvero di documenti».
Nel caso di specie, invece, alla luce della richiamata interpretazione della Corte di cassazione, pur a fronte del consenso delle parti, non sarebbe possibile l'utilizzazione dei verbali di esame dei testimoni, «acquisiti di fronte ad un collegio formato da tre giudici, di cui due togati ed uno onorario, nonché alla presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato».
Sulla base di quanto rappresentato, ritiene il giudice a quo che non siano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017. Si apprezzerebbe, anzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce «il principio di uguaglianza» e che «non può consentire un trattamento deteriore ad una situazione che presenta maggiori garanzie per l'imputato». Infatti - osserva il rimettente - mentre l'acquisizione concordata della prova avviene pacificamente, come chiarito, «per atti formati senza contraddittorio, dinanzi a soggetti che non sono né terzi né imparziali (difensore, pubblico ministero, ufficiali di p.g.)», i verbali delle testimonianze, assunti alle «precedenti udienze», si sono formati «dinanzi ad un giudice terzo e imparziale», capace, peraltro, di giudicare in tutte le materie diverse da quelle indicate dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., e nel contraddittorio delle parti.
Sarebbe, del resto, «irragionevole» che al verbale contenente la «testimonianza "processuale"», proprio perché «correttamente» formato dinnanzi ad un organo «certamente non "minore" rispetto a quelli dinanzi ai quali si formano i verbali c.d. "extraprocessuali"» venga riconosciuto «meno valore». Pertanto, la pur affermata incapacità «a giudicare» del collegio non potrebbe tradursi in nullità dell'atto, non potendosi considerare quel collegio addirittura come «meno legittimo o meno garantito rispetto ad uno studio di un difensore, ad una caserma dei carabinieri o a un ufficio della Procura della Repubblica».
Sotto altro profilo sarebbe violato l'art. 111 Cost. con riferimento alle previsioni del secondo comma, che «disciplina il giusto processo», e del quinto comma, che affida alla legge la regolazione dei casi in cui la formazione della prova «non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato». Impedire l'utilizzo di un atto, pur formatosi nel contraddittorio delle parti, «facendo leva sull'incapacità dell'organo giudicante», determinerebbe «un vulnus al principio del contraddittorio, nonché a quello della ragionevole durata del processo»: la disposizione censurata, infatti, richiede la rinnovazione di un'attività processuale già espletata, con i conseguenti rischi di «vittimizzazione secondaria della vittima del reato», senza che venga considerato l'istituto, pur «di rilievo costituzionale», del consenso dell'imputato all'utilizzazione dei verbali. Ne conseguirebbe, in sostanza, il travolgimento di «tutta l'attività svolta dal c.d. collegio misto», con evidenti conseguenze sulla ragionevole durata dei processi («dovendosi citare nuovamente testimoni già sentiti e rinnovare in taluni casi l'intera istruttoria dibattimentale già svolta») e con sacrificio dell'interesse alla «genuinità della prova», in quanto il testimone dovrebbe essere sentito ripetutamente nel corso del processo, senza che peraltro le sue prime dichiarazioni, che «essendo spesso molto più vicine nel tempo ai fatti, sono certamente le più attendibili», possano essere utilizzate.
Infine, il Tribunale di Catania osserva che l'assoluta inutilizzabilità dei verbali di assunzione della prova dinanzi a un collegio "misto" finirebbe per ridurre tali atti «ad un grado inferiore ai "documenti", certamente sempre acquisibili dal tribunale». Al contrario, si sottolinea, tali atti «esist[ono] nella realtà fenomenica» e non potrebbero essere considerati, «con una finzione giuridica», come inesistenti, ma dovrebbero almeno ritenersi quali atti liberamente valutabili dal tribunale ai fini della decisione.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Catania, quarta sezione penale, nel corso di un processo per uno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto» per tale dovendosi intendere, secondo l'ordinanza di rimessione, quello composto da almeno un giudice onorario di pace, in violazione del divieto stabilito nella medesima disposizione «non sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento».
Il rimettente premette che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, la violazione del divieto, contenuto nella disposizione censurata, di destinare il giudice onorario di pace a comporre i collegi del Tribunale qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il giudice a quo richiama quindi la disciplina di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., che consente alle parti del processo penale di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
Ciò posto, il rimettente ritiene che l'inutilizzabilità dei verbali di assunzione delle prove (nella specie, di due testimonianze), derivante dalla nullità da cui sono affetti, come si è visto, gli atti compiuti dinanzi a un collegio, come nel caso di specie, illegittimamente formato in quanto composto da due magistrati togati e uno onorario, ridondi in violazione degli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost.
Per un verso, infatti, verrebbe irragionevolmente penalizzata una situazione, quale quella che si è venuta a determinare nel processo a quo, in cui l'esame dei testimoni è comunque avvenuto nel processo dinnanzi a un «giudice terzo e imparziale», con successivo accordo delle parti ai fini dell'utilizzo dei relativi verbali. Per ciò solo, tale situazione si presenterebbe «maggiormente garantita», per l'imputato, rispetto alle ipotesi in cui la prova venga assunta, al di fuori del processo, dal difensore, dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.
Per altro verso, la conseguente necessità di rinnovare, dinanzi ad un collegio correttamente formato, l'attività preordinata all'acquisizione delle prove comporterebbe la violazione dei principi della ragionevole durata del processo e del contraddittorio, oltre a porsi in conflitto con l'esigenza della «genuinità della prova».
2.- Occorre preliminarmente precisare che la formula (poc'anzi riportata) utilizzata dal rimettente per delineare il petitum additivo chiesto a questa Corte è affetta da un evidente errore materiale, il quale, comunque, non ne ostacola la comprensione.
Nonostante, infatti, la ripetizione dell'avverbio «non» che si rinviene in tale formula «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova [...] non sono utilizzabili», il generale impianto argomentativo dell'ordinanza di rimessione rimane, con chiarezza, percepibile: si mira a ottenere una pronuncia di accoglimento di questa Corte che consenta l'utilizzabilità dei verbali di prova, pur se acquisiti dinnanzi al collegio formato in violazione del divieto di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, allorché le parti abbiano manifestato il proprio consenso.
3.- Così chiarito il senso dell'addizione richiesta, è opportuno un preliminare inquadramento delle questioni sollevate, al fine di calarle nel panorama normativo di riferimento.
Questa Corte, con la sentenza n. 41 del 2021, ha avuto già occasione di esaminare le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, che fissano le condizioni affinché i giudici onorari di pace, inseriti nell'ufficio per il processo, possano essere eccezionalmente destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Si tratta - come messo in luce nel richiamato precedente - di ipotesi residuali, ammesse solo per situazioni straordinarie e contingenti, allorquando, per la particolare situazione di sofferenza della sede giudiziaria, non è possibile adottare misure organizzative diverse. A tali ipotesi, il richiamato art. 12 affianca la previsione di alcune ipotesi di tassativa esclusione, disponendo che il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e quelli delle sezioni specializzate e, quanto alla competenza nella materia penale, non può comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero - fattispecie che viene in rilievo per le odierne questioni - qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
Secondo la Corte di cassazione, la ratio del divieto in esame «risponde alla chiara finalità di precludere a collegi non composti da giudici esclusivamente togati decisioni in ordine [a] questioni di particolare delicatezza quali sono i provvedimenti in materia di libertà personale o di presiedere procedimenti richiedenti peculiari competenze tecniche quali si configurano quelli indicati dall'art. 407 secondo comma cod. proc. pen.» (così Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 1° ottobre-11 novembre 2024, n. 41236).
Va pertanto ribadito che, con l'introduzione del divieto in esame, l'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 ha "corroborato" la lettura già offerta da questa Corte alle previsioni dell'art. 106, secondo comma, Cost., a norma del quale la nomina di magistrati onorari è ammessa per le sole «funzioni attribuite a giudici singoli» (in tal senso, sentenza n. 41 del 2021, punto 19 del Considerato in diritto). Solo in via del tutto eccezionale, infatti, i magistrati onorari possono essere assegnati ai collegi del tribunale, proprio perché la richiamata previsione costituzionale impone «un perimetro invalicabile della magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, il quale, unicamente a determinate condizioni e in via di supplenza, può anche partecipare allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale» (così, ancora, sentenza n. 41 del 2021, e ivi altri precedenti richiamati).
Se, a livello costituzionale, il travalicamento di tale perimetro comporta la violazione dell'art. 106, secondo comma, Cost. (come affermato dalla richiamata sentenza n. 41 del 2021), sul piano della disciplina processuale esso si traduce nel venir meno della legittimazione dell'organo giudicante. Nel processo penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 178, comma 1, lettera a), e 179 cod. proc. pen., gli atti compiuti dinanzi al collegio formato contra legem sono affetti da nullità insanabile. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di un vizio che travolge l'intero giudizio, anche quando, in ipotesi, esso si riferisca a reati connessi, pur se estranei all'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 novembre-10 dicembre 2024, n. 45242).
4.- Tanto premesso, le questioni sono inammissibili.
Nel richiamare l'istituto della prova concordata - che discende dalle previsioni dell'art. 111, quinto comma, Cost. e la cui applicazione è dalla legge limitata alla possibilità di acquisire, al fascicolo per il dibattimento, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e i documenti relativi all'attività di investigazione difensiva, formati senza l'ausilio del contraddittorio (artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, cod. proc. pen.) - il rimettente mira a censurare, nella sostanza, l'effetto invalidante (sub specie di nullità) che, secondo la ricostruzione normativa già esaminata, deriva dalla violazione del divieto ex art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, insieme al conseguente regime di inutilizzabilità delle prove formate dinanzi al collegio illegittimamente formato. Sul punto, il giudice a quo afferma, infatti, che «[l]a ritenuta incapacità del collegio giudicante formato con la partecipazione ad alcune udienze di un giudice onorario non può tradursi in una nullità dell'atto formatosi dinanzi ad esso».
Tuttavia, il testo dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, unica disposizione che viene selezionata ai fini della declaratoria di illegittimità costituzionale, contiene solo il divieto di composizione dei collegi da parte del giudice onorario, senza riferirsi né all'ambito di applicazione dell'istituto della prova concordata (cui esso neanche minimamente accenna), né alle conseguenze invalidanti discendenti dalla violazione del divieto, che propriamente costituiscono i bersagli del giudice a quo e che sono aliunde stabiliti.
In coerenza con il vulnus lamentato, le censure avrebbero quindi dovuto investire, in parte qua, le norme generali che, nel codice di procedura penale, riconnettono la violazione del divieto in esame al venir meno della capacità del giudice (art. 33) e ne fanno discendere la sanzione processuale della nullità insanabile (artt. 178 e 179). Le considerazioni spese dal rimettente, pertanto, incorrono in una evidente aberratio ictus, «che si verifica quando "sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 107 del 2021)» (così, ex plurimis, sentenza n. 48 del 2023).
Nella doverosa considerazione di questi profili, inoltre, il giudice a quo - alla luce del descritto quadro normativo, arricchito dalla giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto altresì constatare l'eccezionalità della previsione che ammette la partecipazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti del tribunale e interrogarsi sull'effettiva idoneità del collegio formato in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 a rendere il giudizio e a essere considerato titolare della funzione giurisdizionale (alla luce della nozione di capacità del giudice, fatta propria anche da questa Corte: sentenza n. 419 del 1998). Ciò anche nella considerazione del fondamento costituzionale del regime di nullità insanabile che assurge [a] presidio del perimetro invalicabile della magistratura onoraria, secondo i dettami dell'art. 106, secondo comma, Cost. (ancora, sentenza n. 41 del 2021).
5.- Per quanto sopra esposto, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.