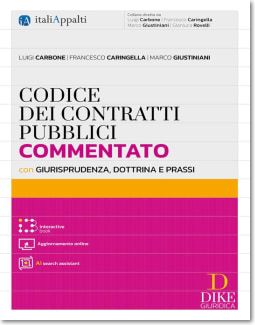Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 17 giugno 2025, n. 5295
Presidente: Chieppa - Estensore: Di Carlo
FATTO E DIRITTO
1. Torna in decisione la causa sulla quale la Sezione, con ordinanza collegiale n. 7706 del 23 settembre 2024, ha rimesso alla Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato questione interpretativa ai sensi dell'art. 99 c.p.a., decisa con sentenza 25 gennaio 2025, n. 1 relativamente alla enunciazione del solo principio di diritto, e per il resto rimessa alla decisione di questo giudice.
2. Con ricorso n. 13115/2023 proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza-ter, l'appellante ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca del 30 giugno 2023, con il quale è stata respinta la proposta di conferimento in suo favore del titolo di professore emerito, inoltrata dall'Università degli Studi "Roma Tre" in data 26 luglio 2022.
Il provvedimento rilevava l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, secondo cui «Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari».
L'appellante ha svolto l'attività di professore universitario di ruolo per 22 anni presso l'Università "Roma Tre", con la qualifica, per alcuni anni, di professore associato, divenendo poi professore ordinario. Nel dettaglio, egli è stato chiamato dall'Università "Roma Tre" in qualità di professore associato a decorrere dal 1° novembre 1999, mentre dal 1° marzo 2002 ha conseguito la qualifica di professore ordinario, mantenuta fino al suo pensionamento, avvenuto il 31 ottobre 2021.
Il ricorrente, quindi, ha svolto per diciannove anni e nove mesi l'attività quale professore ordinario presso l'Università "Roma Tre", e non per i venti anni richiesti dall'art. 111 del r.d. n. 1592/1933: per tale ragione, il MUR ha respinto la richiesta di conferimento dell'onorificenza di "professore emerito" presentata dall'Ateneo in suo favore.
3. Nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'atto sotto i seguenti profili:
i) per erronea interpretazione dell'art. 111 del r.d. n. 1592/1933 e dell'art. 15, secondo comma, della l. 18 marzo 1958, n. 311, anche alla luce della disciplina attuale sullo status di professore universitario, prevista dal d.P.R. n. 382/1980 e dalla l. n. 240/2010, che ha istituito il ruolo unico per i professori universitari, distinguendoli in due fasce all'interno del medesimo ruolo;
ii) per violazione del regolamento dell'Università degli Studi "Roma Tre", relativo al conferimento del titolo onorifico di "professore emerito", adottato con la delibera del Senato accademico n. 564 del 2021.
3.1. Il ricorrente ha anche prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 del r.d. n. 1592/1933, per contrasto con l'art. 3 Cost., sostenendo che l'interpretazione seguita dal Ministero dell'Università sarebbe "anacronistica" e, come tale, irragionevole alla luce del contesto normativo radicalmente mutato, che ha riconosciuto l'autonomia universitaria, ha introdotto la figura del professore associato e ha mutato il regime sul pensionamento dei professori universitari, passato da 75 a 70 anni, rendendo più difficile per i professori ordinari il raggiungimento del limite dei venti anni nella relativa qualifica, necessario per conseguire l'onorificenza.
4. Con la sentenza impugnata, l'adito T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso ritenendo non condivisibile l'interpretazione dell'art. 111 del r.d. n. 1592/1933 e dell'art. 15 della l. n. 311/1958 prospettata dal ricorrente.
Il T.A.R. ha inoltre disatteso la tesi volta a sostenere l'unitarietà della funzione docente svolta dai professori associati e ordinari, rilevando all'opposto che, per un verso, sussiste "la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale" sulla base dell'art. 1 del d.P.R. n. 382/1980), mentre, per un altro verso, con riferimento all'art. 22 dello stesso d.P.R. n. 382/1980, che la invocata equiparazione dello stato giuridico dei professori associati a quello degli ordinari sussiste "salvo che non sia diversamente disposto", con la conseguenza che continuerebbe a persistere il regime giuridico differenziato tra le due posizioni.
In merito al regolamento dell'Università "Roma Tre", il T.A.R. del Lazio ha poi ritenuto che il regolamento di Ateneo non avrebbe potuto disporre diversamente da quanto previsto dalla legge, in quanto «il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"», limiti che sono inderogabili, a fronte della necessità di disciplinare in modo uniforme il conferimento di un titolo avente valore su tutto il territorio nazionale.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la distinzione dei professori in due fasce, con differenti modalità di accesso alle rispettive qualifiche di professore associato e di professore ordinario, non consentirebbe di ritenere affetta da irragionevolezza la previsione recata dall'art. 111 cit. Peraltro, non sarebbe nemmeno possibile individuare, in via ermeneutica, una disciplina alternativa quanto al periodo minimo di svolgimento del servizio come professore ordinario, al fine di conseguire il titolo di professore emerito, non potendo ritenersi equivalenti i due profili, tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore.
5. Nell'impugnare la sentenza, l'appellante ha lamentato il vizio di "errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 R.D. n. 1592 del 1933; violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge n. 311 del 1958; contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione".
La doglianza è stata articolata sulla base di tre profili, che possono così riassumersi:
I) mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle due pronunce di questo Consiglio di Stato in precedenza richiamate, secondo cui l'art. 111 r.d. n. 1592/1933 dovrebbe essere interpretato in stretta correlazione con l'art. 15, secondo comma, della l. n. 311/1958, il quale - pur rinviando all'art. 111 del r.d. n. 1592/1933, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito - ne avrebbe innovato il perimetro applicativo, estendendolo all'intera categoria dei professori universitari;
- l'art. 15, secondo comma, cit., infatti, dopo aver disciplinato in modo unitario il collocamento a riposo dei professori universitari senza considerare la fascia di appartenenza, ha disposto che "Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato";
- secondo l'appellante l'art. 15, secondo comma, della l. n. 311 del 1958 avrebbe innovato la risalente disciplina recata del r.d. n. 1592 del 1933, poiché, in merito al conferimento dell'onorificenza di "professore emerito" o di "professore onorario", si riferisce genericamente ai "professori" universitari collocati a riposo, anziché ai soli "professori ordinari", a differenza di quanto previsto dall'art. 111 del r.d. n. 1592/1933;
- ciò sarebbe confermato dall'ultimo comma dello stesso art. 15 cit., secondo cui "Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato": secondo l'appellante tale previsione confermerebbe la volontà del legislatore di innovare la disciplina recata dall'art. 111 del r.d. n. 1592/1933, in quanto il legislatore - qualora avesse inteso ribadire le regole precedenti - si sarebbe premurato di aggiungere all'art. 110, ultimo comma, del t.u. n. 1592/1933 anche il richiamo all'art. 111 dello stesso t.u. in modo che fosse chiaro che "nulla era stato innovato" a tal proposito;
II) mancata interpretazione storico-sistematica del dato normativo: l'appellante ha dedotto che sussiste, ormai, un unico ruolo per i professori universitari anche se articolato sulla base di due fasce, rilevanti, soprattutto, a livello retributivo, tenuto conto della unitarietà della funzione docente con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca;
- i professori universitari hanno identità di status e svolgono la medesima attività didattica; residuano tra le due fasce di professori differenze che riguardano il reclutamento, le funzioni di coordinamento, tali da non incidere sull'identità delle funzioni svolte;
- inoltre, la tesi del Ministero dell'università, secondo cui non sarebbe valutabile per il professore ordinario, ai fini della nomina come "professore emerito", l'anzianità di servizio maturata quando era professore associato, avrebbe effetti distorsivi e irragionevoli alla luce del mutato ordinamento della materia;
III) erronea interpretazione del regolamento dell'Università "Roma Tre" (art. 2, comma 1) che disciplina la concessione del titolo di professore emerito: con tale doglianza l'appellante ha censurato la decisione del T.A.R., secondo cui il potere delle Università di dotarsi di un regolamento autonomo non deve superare "i limiti stabiliti dallo Stato", in quanto tale titolo ha valore sull'intero territorio nazionale;
- secondo l'appellante, invece, il regolamento universitario avrebbe valenza dirimente, laddove stabilisce che tale titolo può essere conferito ai "professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni";
- tale disposizione, riferendosi ai professori ordinari con venti anni di servizio nella qualità di "professori di ruolo", posizione nella quale ricadono sia i professori ordinari che gli associati, tenuto conto dell'unicità del ruolo in base all'art. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, implicherebbe la valutabilità - nel caso di specie - del breve periodo di tempo nel quale l'appellante ha prestato servizio in qualità di professore associato presso l'Università "Roma Tre";
- tale disposizione sarebbe stata introdotta, infatti, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in precedenza richiamati (parere n. 2203/2015 e sentenza n. 1506/2021);
- quanto alla autonomia dell'Università e al suo potere regolamentare, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sezione Sesta, n. 696/2017), secondo cui occorre tener conto di quanto stabilito con il regolamento dell'Università: pertanto, se il regolamento ha ritenuto computabili anche gli anni di servizio come professore associato, tali anni si sarebbero dovuti valutare, in quanto la disciplina della materia ricade nella piena autonomia del singolo Ateneo.
5.1. In via subordinata, l'appellante ha anche riproposto la questione di legittimità costituzionale incentrata sull'anacronismo legislativo nel continuare a prevedere, nonostante il riconoscimento dell'autonomia universitaria, che debba esservi il decreto del MUR (in origine decreto reale) a recepire la deliberazione del singolo Ateneo.
6. Ha resistito il Ministero dell'università e della ricerca, insistendo sulla legittimità del proprio operato, stante: (i) la perdurante differenza tra le qualifiche di professore ordinario e associato; (ii) la valutabilità ex lege dei soli anni di servizio resi nella qualifica di professore ordinario; (iii) la insuperabilità dei "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" con riferimento al potere delle Università di darsi un ordinamento autonomo.
7. Come si è poc'anzi detto, con ordinanza collegiale n. 7706 del 23 settembre 2024, rilevato il possibile contrasto con i precedenti giurisprudenziali rappresentati dal parere della Sezione Seconda n. 2203 del 29 luglio 2025 e dalla sentenza della Sezione Sesta 19 febbraio 2021, n. 1506, la Sezione ha rimesso alla Adunanza plenaria la questione di diritto "se alla luce del combinato disposto dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in relazione all'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l'attribuzione della qualifica di professore emerito".
8. Con la citata sentenza 23 gennaio 2025, n. 1, la Plenaria ha statuito che:
(i) al quesito formulato va data risposta nel senso che: "ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1959, n. 311, e dell'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l'attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato";
(ii) tenuto conto della specificità del quesito posto, il prefato principio trova applicazione con riferimento alla sola questione relativa all'interpretazione della normativa nazionale (art. 111 del r.d. n. 1592/1933 e art. 15, secondo comma, della l. n. 311/1958), e non anche in relazione alla diversa questione concernente la interpretazione e rilevanza, ai fini della decisione di merito, dell'art. 2, comma 1, del "Regolamento di ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario" dell'Università "Roma Tre" (adottato nella sua ultima versione con delibera del Senato accademico n. 564 del 2021), secondo cui il conferimento del titolo di "professore emerito" può essere proposto "per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni".
In particolare, secondo la Plenaria, di tale questione, oggetto dei restanti motivi di appello, si dovrà occupare la Sezione rimettente con riferimento a due aspetti:
- quale sia la corretta interpretazione della disciplina regolamentare dell'Università "Roma Tre", modificata con la delibera n. 564 del 2021;
- quale rilievo abbia tale regolamento, qualora sia ritenuto contrastante con la legislazione nazionale;
(iii) quanto, infine, alla problematica relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 111 del r.d. n. 1592/1933 e 15, comma secondo, della l. n. 311 del 1958, per contrasto con l'art. 3 Cost., nel condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, la Plenaria ha ritenuto che la questione non superi il necessario vaglio della non manifesta infondatezza.
9. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
In particolare, all'esito della sentenza della Plenaria, l'appellante ha prospettato due questioni: per un verso, ha sostenuto che il principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria non è in contraddizione con la propria tesi che punta al riconoscimento del periodo effettivo di servizio durante il quale sussisteva in concreto il requisito della piena maturità scientifica: non si tratterebbe, infatti, di considerare il periodo che va dal 1° novembre 2001 (inizio dell'anno accademico) al 1° marzo 2002 (presa di servizio come ordinario) come periodo svolto, sic et simpliciter, nella mera qualità di professore associato, bensì come periodo di servizio durante il quale sussisteva già in pieno il requisito della piena maturità scientifica che caratterizza la posizione del professore ordinario, solo, non formalmente acclarato dalla presa di servizio.
E ha anche aggiunto che, laddove si prescindesse dal computare nel calcolo della piena maturità scientifica anche il suddetto periodo di tempo, ossia quello intercorso tra il formale accertamento della piena maturità e la presa effettiva di servizio nel ruolo di ordinario, si porrebbe una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 del r.d. n. 1592/1933, nella parte in cui cioè non si prevede che, ai fini del calcolo dei venti anni, si debba tener conto anche del momento in cui si è materialmente accertato il requisito della piena maturità scientifica del professore ordinario, solo formalmente "slittato" in avanti, di qualche mese, a causa degli effetti applicativi legati all'adozione, da parte dell'Università, della formale presa di servizio.
Per un altro verso, invece, l'appellante ha prospettato che la lite potrebbe comunque trovare una soluzione a sé favorevole, anche prescindendo da tale decisivo rilievo, ove il giudice, nel decidere le ulteriori questioni restituite dalla Plenaria, oggetto dei restanti motivi di appello, interpreti il regolamento dell'Università di Roma Tre come il frutto della autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta alle università, in quanto tale legittimo e conforme a legge.
10. Alla udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
11. L'appello, ripropositivo delle censure del ricorso di primo grado, è infondato con riferimento al primo motivo e fondato per la restante parte.
12. È in particolare infondata la censura con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 r.d. n. 1592 del 1993 e dell'art. 15 l. n. 311 del 1958.
Con la succitata sentenza n. 1/2025, la Plenaria ha infatti enunciato i principi e le coordinate esegetiche sulla base delle quali deve essere interpretato il quadro giuridico di riferimento risultante dal combinato disposto dell'art. 111 del r.d. n. 1592 del 1933 e dell'art. 15, secondo comma, della l. n. 311 del 1958, dando conto anche delle ragioni per le quali vanno superati i precedenti principi affermati da questo Consiglio di Stato con il parere della Sezione Seconda n. 2203 del 20 luglio 2015 e con la sentenza della Sezione Sesta n. 1506 del 19 febbraio 2021, e, rispondendo al quesito interpretativo posto da questa Sezione, ovverossia se, sulla base della normativa nazionale, nel computo dei venti anni di anzianità nel ruolo dei professori universitari, necessari per conseguire il titolo di professore emerito, debba essere computato anche il periodo di servizio prestato in qualità di professore associato, ha chiaramente enunciato il principio che "ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1959, n. 311, e dell'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l'attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato".
A questa esegesi la Plenaria è pervenuta privilegiando l'applicazione del criterio di interpretazione letterale delle leggi, argomentando nello specifico che:
(i) l'art. 15, secondo comma, della l. n. 311/1958 prevede che "Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592";
(ii) tale disposizione prevede, quindi, che il titolo di professore emerito può essere assegnato solo ai professori ordinari collocati a riposo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 111 del t.u. n. 1592/1933, e dunque dello svolgimento per almeno venti anni di servizio dell'attività quale professore ordinario;
(iii) la disposizione è chiara e anche coerente con la ratio dell'onorificenza, che è quella di premiare il professore ordinario che vanti una eccezionale carriera accademica universitaria, caratterizzata, in primis, dalla durevole presenza nella posizione apicale della docenza universitaria;
(iv) il d.P.R. n. 382/1980 e la l. n. 240/2010 hanno ribadito la distinzione tra professori ordinari e associati, individuando le prerogative spettanti ai soli professori ordinari, sicché il dato letterale e la perdurante distinzione di compiti e funzioni esistente tra i professori ordinari e gli associati giustificano l'attuale regime e quindi la non valutabilità dell'anzianità conseguita nella qualifica di professore associato ai fini del conferimento dell'onorificenza di "professore emerito";
(v) in particolare, per l'art. 22 del d.P.R. n. 382/1980, sussiste la equiparazione dello stato giuridico dei professori ordinari e di quello dei professori associati "salvo che non sia diversamente disposto": siccome in materia di conferimento dell'onorificenza il legislatore ha sempre attribuito rilievo esclusivamente alla qualifica di professore ordinario, questo è uno di quei casi in cui opera la suddetta clausola di eccezione.
13. Non sussistendo ragioni oggettive ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a., il collegio recepisce quindi integralmente il principio di diritto enunciato e, preso atto che la corretta esegesi dell'art. 111 del r.d. n. 1592/1933 è nel senso di ritenerlo ancora integralmente in vigore in quanto non inciso da leggi successive, respinge la censura con cui si è dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa nazionale.
14. A diverse conclusioni giunge il collegio, invece, con riferimento alle restanti censure con cui il ricorrente si doleva della illegittimità dell'operato del Ministero appellato anche per contrasto con la normativa regolamentare universitaria e per contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione rispetto alla unanime proposta proveniente, sulla base della prefata normativa regolamentare, sia dal Dipartimento dal quale era partita la proposta sia, soprattutto, dal Senato accademico dell'Ateneo.
Per tale parte, infatti, l'appello va accolto.
Va in proposito rammentato che la Plenaria, nella sua fondamentale premessa contenuta al primo punto della parte in diritto, ha specificatamente chiarito che «1. - La Sezione Settima ha rimesso a questa Adunanza Plenaria la seguente questione di diritto: "se alla luce del combinato disposto dell'art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in relazione all'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l'attribuzione della qualifica di professore emerito". Tenuto conto della specificità del quesito, questa Adunanza Plenaria si limiterà a decidere la sola questione relativa all'interpretazione della normativa nazionale (art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e art. 15, secondo comma, della L. n. 311/1958), prescindendo dalle ulteriori doglianze sollevate nell'appello, la prima delle quali riguarda l'interpretazione e la rilevanza, ai fini della decisione di merito, dell'art. 2, comma 1, del "Regolamento di ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario" dell'Università "Roma Tre" adottato nella sua ultima versione con delibera del Senato accademico n. 564 del 2021), secondo cui il conferimento del titolo di "professore emerito" può essere proposto "per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni". Tale questione - da approfondirsi da parte della Sezione Settima - riguarda due aspetti: - quale sia la corretta interpretazione della disciplina regolamentare dell'Università "Roma Tre", modificata con la delibera n. 564 del 2021; - quale rilievo abbia tale regolamento, qualora fosse ritenuto contrastante con la legislazione nazionale».
Procedendo quindi a questo approfondimento, si rammenta anzitutto il quadro costituzionale entro cui si muovono tanto la legge dello Stato, quanto i regolamenti delle Università.
Sul piano costituzionale, i principi dell'autonomia universitaria e del rapporto tra regolamenti universitari e legge statale rappresentano uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento accademico italiano, trovando il loro fondamento costituzionale nell'art. 33 della Costituzione, che al sesto comma stabilisce che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Il fondamento costituzionale dell'autonomia universitaria si configura quindi come un principio di rango costituzionale che trova la sua ratio nella necessità di garantire la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, come sancito dal primo comma del medesimo art. 33 della Costituzione, e si declina nel suo senso più ampio come autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
La Corte costituzionale ha in particolare chiarito che l'autonomia universitaria si esprime non solo nel tutelare l'autodeterminazione dei docenti, ma anche nel demandare agli organi accademici l'ordinamento dell'istituzione e la conduzione della stessa, configurando un'autonomia di livello non secondario, considerata pari a quella riconosciuta alle regioni (sent. 17 giugno 1992, n. 281).
I principi sanciti dalla Costituzione hanno trovato una prima attuazione con la l. 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi Ministero dell'università e della ricerca.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».
Per il successivo art. 6, rubricato "Autonomia delle università": "1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare".
La qualificazione delle università come enti autonomi, e non come articolazioni dello Stato, risulta poi anche dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente confluito nell'art. 1 del vigente testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale le annovera in modo esplicito fra le amministrazioni pubbliche non statali.
Coerentemente con ciò, da ultimo, l'art. 1, comma 2, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 ha ribadito che «In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità», e che «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", le università possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi», e il successivo comma 4 ha previsto che «Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti».
I prefati commi 2 e 4 confermano quindi, rispettivamente, che: (i) nei rapporti organizzativi e funzionali, il Ministero non è titolare di alcun potere di supremazia sulle istituzioni universitarie, con le quali coopera, di massima, attraverso accordi di programma, e cioè attraverso l'utilizzo di uno strumento che presuppone il pari rango di chi vi partecipa (accordo); (ii) nei rapporti di direzione e coordinamento, il Ministro indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, ma sempre sul presupposto del rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università.
In applicazione di questi principi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ad esempio estranea alle competenze del Ministero la materia dei concorsi per docenti universitari, sì da escluderne la legittimazione passiva nei ricorsi giurisdizionali proposti contro gli atti relativi (C.d.S., Sez. VI, sent. 25 gennaio 2018, n. 507, argomentando per implicito dalla propria precedente sent. 22 aprile 2004, n. 2364).
Le dimensioni dell'autonomia universitaria che rilevano ai fini della decisione sono la autonomia organizzativa, che consente alle università di strutturarsi secondo modelli organizzativi propri, definendo organi, competenze e procedure interne, e la autonomia statutaria e regolamentare, che riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi attraverso statuti e regolamenti propri.
Si tratta di forme di autonomia ampie, ma non illimitate.
Per comprenderne il contenuto, bisogna quindi conoscerne i limiti.
Sulla base del cit. art. 33 Cost., l'autonomia si esercita "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Indicazioni più precise e di dettaglio si rinvengono nella l. 9 maggio 1989, n. 168, di prima applicazione della prefata normativa costituzionale.
In particolare, l'art. 6, al comma 2, prevede che "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare".
In via ermeneutica, si traggono i seguenti principi: (i) l'autonomia non è illimitata; (ii) il limite deve essere previsto dalla legge; (iii) attesa la particolare collocazione delle università nell'organizzazione costituzionale, il limite inderogabile, e cioè il limite al di là del quale l'autonomia universitaria non può esprimersi, non può essere desunto in via ermeneutica dalla legge, né contenuto in atti amministrativi attuativi della legge medesima (tra cui le circolari), ma deve essere previsto esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.
È quindi solo in parte corretta l'affermazione del Ministero appellato secondo cui l'autonomia universitaria va contenuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, perché ciò è vero nella misura in cui il suddetto principio sia completato con la necessaria specificazione che i suddetti limiti provengano esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.
15. Rispondendo, quindi, al primo tema di approfondimento suggerito dalla Plenaria, ovverossia quale sia la corretta interpretazione della disciplina regolamentare dell'Università "Roma Tre", modificata con la delibera n. 564 del 2021, si fa anzitutto osservare come il suddetto regolamento non sia stato impugnato, nemmeno in via incidentale, dal Ministero intimato.
Si fa poi rilevare come il rapporto tra normativa statale e regolamenti universitari sia chiaramente definito: la normativa primaria statale prevale sempre sulla disciplina regolamentare di autonomia universitaria quando ad essa vi faccia esclusivo ed espresso riferimento.
Di conseguenza, il regolamento universitario in genere, e nello specifico quello dell'Università di Roma Tre, presentano una valenza sub-primaria rafforzata sia dalla guarentigia costituzionale, sia dalla specifica previsione di legge primaria dello Stato (art. 6, comma 2, l. 9 maggio 1989, n. 168), che legittima la incisione della autonomia universitaria non attraverso qualsivoglia limite, ma solo per il tramite di un limite previsto esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.
Applicando le suddette coordinate e principi al caso all'esame, si ritiene dunque che il quadro normativo devoluto alla cognizione della Plenaria ai sensi dell'art. 99 c.p.a. non contenga un limite con siffatte caratteristiche.
In particolare, l'art. 15, secondo comma, della l. n. 311 del 1958 prevede che "Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato".
A sua volta, l'art. 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, dispone che «Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari».
Sulle orme della Plenaria, che ha privilegiato come primario criterio di interpretazione della legge quello letterale (arg. ex art. 12 delle preleggi: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore; art. 101 Cost.: i giudici sono soggetti soltanto alla legge), si ritiene che le formulazioni linguistiche utilizzate dal legislatore primario (nell'art. 15 cit.: può essere conferito; nell'art. 111 cit.: potrà essere conferito) risultano sì univoche e inderogabili quanto alla discrezionalità del conferimento e alla soglia temporale minima per accedere al riconoscimento del beneficio, come in via nomofilattica statuito dalla Plenaria (si veda, in particolare, il punto 5.7 della motivazione: "Ritiene dunque questa Adunanza che l'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 sia ancora integralmente in vigore, sia perché non inciso dalle leggi successive, sia perché - ai fini del conferimento dell'onorificenza in questione - a suo tempo il legislatore ha fissato un inderogabile requisito di ordine temporale"), ma che, al contempo, le medesime proposizioni linguistiche non contengano (pure) un limite inderogabile all'autonomia universitaria, esclusivamente ed espressamente previsto (art. 6, comma 2, l. 9 maggio 1989, n. 168), di diversamente articolare all'interno il periodo minimo previsto dalla legge sulla base dello sviluppo di carriera maturato dal professore, prima come associato e poi come ordinario.
Questo equilibrio garantisce, da un lato, la necessaria autonomia delle istituzioni accademiche per lo svolgimento delle loro funzioni, dall'altro, la imprescindibile unitarietà del sistema universitario nazionale.
L'autonomia universitaria, infatti, pur essendo costituzionalmente garantita, deve sempre confrontarsi con i principi generali dell'ordinamento e con le esigenze di tutela dei diritti soggettivi che richiedono una disciplina uniforme a livello nazionale. D'altro canto, è proprio la tutela dei diritti soggettivi che a volte esige, come nel caso all'esame, di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio nel mutato quadro normativo che disciplina la figura del professore universitario di ruolo, attesa la identità di stato giuridico ai sensi dell'art. 6 della l. n. 240 del 2010, che, nel disciplinare lo «Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo», utilizza la parola «professori» senza alcuna specificazione ulteriore legata alla fascia di appartenenza.
16. Con riferimento al primo approfondimento indicato dalla Plenaria («quale sia la corretta interpretazione della disciplina regolamentare dell'Università "Roma Tre", modificata con la delibera n. 564 del 2021») dalla lettura della norma regolamentare emerge in modo chiaro come l'Università abbia inteso prevedere come requisito per la nomina a professore emerito l'essere professore ordinario e aver prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professore universitario di ruolo, ordinario o associato.
Infatti, il suddetto regolamento, adottato nella sua ultima versione con delibera del Senato accademico n. 564 del 2021 prevede, all'art. 2, comma 1, che il conferimento del titolo di "professore emerito" possa essere proposto "per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni".
Il termine "professori universitari di ruolo" è inequivoco nel non limitare la valutazione del periodo alla sola attività come professore ordinario.
17. Rispondendo al secondo approfondimento indicato dalla Plenaria, ovverossia quale rilievo abbia il regolamento universitario, si osserva che il suddetto regolamento rappresenta, in una lettura costituzionalmente orientata, un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di uniformità a livello nazionale nel prevedere un limite temporale minimo per accedere al beneficio secondo la ratio premiale del merito alla carriera, e l'autonomia universitaria di diversamente articolare i periodi maturati come professore associato e come professore ordinario, valorizzando e premiando il complessivo percorso professionale svolto dal professore universitario, nella avvenuta evoluzione della disciplina in tema di conferimento del titolo di "emerito", rispettosa della evoluzione del comune sentire del mondo accademico, entro i limiti della logicità, razionalità e non disparità di trattamento.
L'appellante ha svolto l'attività di professore universitario di ruolo per 22 anni presso l'Università "Roma Tre", con la qualifica, per alcuni anni, di professore associato, divenendo poi professore ordinario. Nel dettaglio, egli è stato chiamato dall'Università "Roma Tre" in qualità di professore associato a decorrere dal 1° novembre 1999, mentre dal 1° marzo 2002 ha conseguito la qualifica di professore ordinario, mantenuta fino al suo pensionamento, avvenuto il 31 ottobre 2021.
L'appellante, quindi, ha svolto per diciannove anni e nove mesi l'attività quale professore ordinario presso l'Università "Roma Tre", e non per i venti anni richiesti dall'art. 111 del r.d. n. 1592/1933: per tale ragione, il MUR ha respinto la richiesta di conferimento dell'onorificenza di "professore emerito" presentata dall'Ateneo in suo favore.
Considerata la diversa previsione regolamentare dell'Università, qui ritenuta compatibile con i principi in tema di autonomia universitaria (e quindi non disapplicabile), si ritiene dunque illegittimo l'operato del Ministero, sia in quanto contrasta con la legittima disposizione regolamentare, sia perché si pone in contraddizione con la motivazione posta alla base della unanime proposta presentata dal Senato accademico al Ministro, senza peraltro tenere conto della proporzione tra i due periodi di riferimento, in cui è nettamente preponderante quello nella qualifica di professore ordinario.
18. In definitiva, per le considerazioni appena illustrate, l'appello va in parte respinto con riferimento al primo motivo e per la restante parte accolto.
19. Di conseguenza, va assorbito l'esame della ulteriore questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellante con l'ultima memoria difensiva, non potendo la medesima ottenere maggior soddisfazione della propria pretesa.
20. Nel riesercitare il potere, l'Amministrazione osserverà i vincoli conformativi nascenti dal presente giudicato, e in particolare: (i) l'obbligo di considerare come definitivamente acclarata la legittimità del regolamento universitario che disciplina il conferimento dell'onorificenza di "professore emerito" dell'Università di Roma Tre; (ii) l'obbligo di tenere nei sensi sopra indicati conto del periodo trascorso come professore ordinario e di quello come professore associato, e precisamente: il ricorrente è stato chiamato dall'Università "Roma Tre" in qualità di professore associato a decorrere dal 1° novembre 1999, mentre dal 1° marzo 2002 ha conseguito la qualifica di professore ordinario, mantenuta fino al suo pensionamento, avvenuto il 31 ottobre 2021, svolgendo quindi per diciannove anni e nove mesi l'attività quale professore ordinario presso l'Università "Roma Tre".
21. Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la novità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Nel riesercitare il potere, l'Amministrazione osserverà i vincoli conformativi nascenti dal presente giudicato, come illustrati diffusamente in motivazione e nello specifico nel punto 19.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 17912/2023.
V. anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 23 gennaio 2025, n. 1.