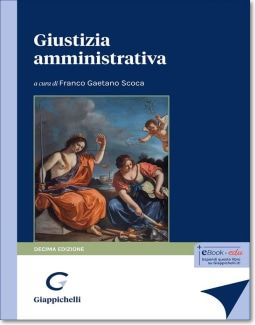Corte costituzionale
Sentenza 17 luglio 2025, n. 110
Presidente: Amoroso - Redattrice: Sciarrone Alibrandi
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, nel procedimento vertente tra M. C. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 4 novembre 2024, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di M. C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
uditi gli avvocati Giorgio Borri per M. C. e Sergio Preden per l'INPS, nonché l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 4 novembre 2024 (r.o. n. 225 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono che, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima».
2.- Il giudizio principale origina dal ricorso presentato da M. C., titolare di una pensione di vecchiaia «in regime di cumulo» - ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» - liquidata, al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni e sette mesi, a far data dal 1° maggio 2018.
3.- In fatto, il rimettente riferisce che l'importo del trattamento pensionistico risulta calcolato in base alla contribuzione versata, in periodi compresi tra il 17 aprile 1976 e il 28 aprile 2018 (per un totale di trentacinque anni e quattro mesi), in cinque diverse «gestioni previdenziali INPS», alle quali il ricorrente è stato iscritto nel corso della propria carriera lavorativa, maturando altrettante quote di trattamento, successivamente cumulate.
Più nello specifico, il rimettente espone che M. C. è stato iscritto: a) nella «gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti privati», per circa un anno e due mesi; b) nella «gestione commercianti», per circa un anno e nove mesi; c) nella «gestione dei dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI)», per circa cinque anni e dieci mesi; d) nella «gestione separata», per circa tredici anni e un mese; e) nella «gestione pubblica», per circa tredici anni e sei mesi.
Con particolare riferimento a quest'ultima gestione, risulta che il ricorrente è stato dipendente a tempo indeterminato della Regione Toscana dal 17 aprile 1976 al 30 novembre 1980, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Siena dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1999, dipendente a tempo determinato del Comune di Firenze dal 1° aprile 2007 al 24 settembre 2009 e, da ultimo, dipendente a tempo determinato del Ministero dell'istruzione dall'8 ottobre 2015 al 30 aprile 2018, in base ad una pluralità di contratti quale docente supplente.
A fronte del rifiuto opposto dall'INPS di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con ricalcolo della cosiddetta «"quota A"» della pensione retributiva previa neutralizzazione dei periodi di retribuzione relativi ai rapporti di lavoro intercorsi con il Ministero dell'istruzione, il pensionato ha riproposto la domanda in sede giudiziaria.
Riferisce ancora il rimettente che, dalla simulazione operata dall'INPS in esecuzione di apposita istruttoria, la sterilizzazione della contribuzione versata per gli incarichi di supplenza alle dipendenze del Ministero dell'istruzione restituirebbe un importo del trattamento pensionistico «a titolo di quota ex INPDAP» pari a euro 2.497,08 lordi mensili, superiore alla somma di euro 1.104,13 lordi mensili attualmente riconosciuta per il medesimo titolo.
4.- La Sezione regionale della Corte dei conti rimettente individua le disposizioni rilevanti ai fini della decisione della controversia nell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e nell'art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965.
Di entrambe sospetta l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non prevedono la possibilità di neutralizzare il periodo che incide negativamente sull'importo della pensione».
In particolare, l'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene censurato perché impone di considerare come base di calcolo l'ultima retribuzione percepita e, quindi, nel caso di specie, quella ricevuta dal pensionato come dipendente del Ministero dell'istruzione. L'art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965, invece, viene denunciato perché, «nell'ambito della cd. "gestione Enti Locali"», fa riferimento alla retribuzione annua contributiva in godimento alla data di cessazione dal servizio, sicché «per poter considerare l'ultima retribuzione [...] quale dipendente del Comune di Firenze occorre che la neutralizzazione di quanto percepito nell'altra gestione previdenziale pubblica sia ammessa anche dalla norma di riferimento della gestione "di risulta"».
Ciò fonderebbe la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su entrambe le disposizioni.
5.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama alcune pronunce con le quali questa Corte, «nell'ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico», ha elaborato il principio della cosiddetta neutralizzazione di quella contribuzione che, accreditata successivamente alla maturazione del requisito contributivo minimo richiesto, produca - perché relativa a un'attività lavorativa meno retribuita rispetto a quella svolta prima del periodo considerato utile ai fini pensionistici - un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato (in particolare, è citata la sentenza n. 264 del 1994).
Si tratterebbe di un principio che, pur espresso nell'ambito del lavoro subordinato privato, questa Corte ha esteso al lavoro autonomo, attribuendogli, quindi, una «valenza generale», tale da imporsi «nell'ordinamento pensionistico al di là del pluralismo delle gestioni e dei regimi» (sentenza n. 173 del 2018).
Peraltro, il rimettente evidenzia che, pure nel caso trattato dalla sentenza n. 173 del 2018, la questione avrebbe riguardato un caso di «calcolo della quota della pensione di cumulo tra due gestioni, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo» e, dunque, analogo a quello oggetto dell'odierno scrutinio.
5.1.- La Corte rimettente esclude, peraltro, la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che porti ad applicare direttamente il principio di neutralizzazione anche ai casi regolati dalle disposizioni censurate, in considerazione del chiaro tenore testuale di queste ultime.
6.- Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per il giudice contabile emergerebbero plurimi profili di illegittimità costituzionale.
6.1.- In primo luogo, vi sarebbe un contrasto con il principio di ragionevolezza.
Per il rimettente, l'unica differenza rispetto alle vicende che fanno da sfondo alle citate pronunce sarebbe costituita dal fatto che, nella gestione pubblica, la base pensionabile è temporalmente ridotta, rispetto ai periodi più ampi previsti nelle altre gestioni, in quanto individuata in riferimento alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio. Questa peculiarità di disciplina - più favorevole ai dipendenti pubblici, per i quali, normalmente, risulterebbe più elevata la retribuzione percepita «all'ultimo scatto della progressione economica raggiunta» - non potrebbe impedire la fruizione del rimedio plasmato dalla giurisprudenza costituzionale per tutti i casi in cui, nel sistema (in tutto o in parte) retributivo di computo del trattamento pensionistico, l'accredito di contribuzione aggiuntiva rispetto a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto «determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione».
6.2.- Tale depauperamento, inoltre, incidendo sulla necessaria «proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo», violerebbe anche l'art. 36 Cost., oltre che il principio di adeguatezza rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., poiché tale effetto non rispetterebbe «la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica».
6.3.- Inoltre, e «[p]er completezza», il rimettente ritiene che, qualora il «diritto alla neutralizzazione [...] dovesse essere escluso per i soli iscritti alla gestione pubblica», sarebbe violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).
Infine, sarebbe evidente il contrasto «con il dovere del legislatore di tutelare "il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"» (art. 35, primo comma, Cost.), in quanto «principio fondante della Repubblica» (art. 1, primo comma, Cost.), nonché «con il riconoscimento del particolare valore sociale dell'attività di "pubblici impiegati [che] sono al servizio esclusivo della Nazione"» (art. 98, primo comma, Cost.): l'esito normativo più volte denunciato, «ove non espunto dall'ordinamento», dissuaderebbe il lavoratore «dal praticare prestazioni lavorative meno remunerate rispetto alle precedenti», in tal modo conculcandone la dignità, in quanto indotto «sulla base di un mero calcolo di convenienza economica, ad un prematuro collocamento a riposo».
7.- M. C. si è costituito in giudizio, ripercorrendo i passaggi essenziali dell'ordinanza di rimessione e aderendo alle conclusioni ivi rassegnate.
8.- Si è costituito in giudizio anche l'INPS, che, in punto di fatto, ha confermato l'avvenuto esercizio, da parte del ricorrente nel giudizio principale, «della facoltà di cumulo gratuito della contribuzione», di cui all'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012: la pensione sarebbe stata calcolata «con il criterio misto», a fronte di un'anzianità contributiva «al 31 dicembre 1995» inferiore «ai 18 anni», e il relativo importo sarebbe stato determinato «in conformità al disposto dell'art. 1, comma 245» della stessa legge, ai sensi del quale le singole gestioni interessate dall'operazione di cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, «determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento».
8.1.- Ciò premesso, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, sotto diversi profili.
8.1.1.- In primo luogo, sarebbero irrilevanti le questioni sollevate sull'art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965.
Tale disposizione, si osserva, non sarebbe stata applicata nel calcolo del trattamento pensionistico di cui si discute e, in ogni caso, qualora fosse consentita la neutralizzazione nei termini richiesti, la retribuzione che verrebbe valorizzata ai fini pensionistici in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 della legge n. 965 del 1965 andrebbe a coincidere, «senza necessità di alcuna operazione di neutralizzazione», proprio con quella che lo stesso rimettente reputa maggiormente favorevole.
8.1.2.- In secondo luogo, l'ordinanza di rimessione sarebbe viziata «in ragione della incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento».
In particolare, pacifica la circostanza della liquidazione della pensione con il sistema del cumulo gratuito consentito ex art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, il rimettente non avrebbe adeguatamente valutato che il successivo comma 243 dispone che la relativa facoltà «deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239».
Tale previsione legislativa, a giudizio dell'INPS, precluderebbe «in radice la possibilità di procedere alla neutralizzazione della contribuzione», perché una tale operazione comporterebbe necessariamente che la provvista contributiva dell'interessato non sia utilizzata «per intero».
Non avendo il giudice a quo in alcun modo argomentato sul punto, ne risulterebbe inficiato lo stesso percorso logico dell'ordinanza di rimessione.
8.1.3.- Infine, il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'individuazione della «data di maturazione del requisito di accesso alla pensione», al cui conseguimento l'interessato avrebbe acquisito il diritto solo in seguito alla presentazione della domanda di cumulo: anche tale omissione vizierebbe la motivazione del rimettente, dal momento che il principio di neutralizzazione sarebbe applicabile alla «sola contribuzione che, a qualsiasi titolo, sia stata accreditata» in epoca successiva.
8.2.- Nel merito, tutte le questioni sarebbero, comunque, non fondate.
La «stessa ratio sottesa all'istituto del cumulo» impedirebbe la neutralizzazione della contribuzione meno conveniente: l'esercizio della relativa facoltà consente ai lavoratori con «carriere discontinue e frammentarie» di aggregare gratuitamente tutti i «segmenti di assicurazione maturati nelle diverse gestioni, così da poter conseguire un'unica pensione senza dover ricorrere» ai diversi istituti della «ricongiunzione (onerosa)» o della «totalizzazione (dalla quale deriva l'applicazione del sistema di calcolo interamente contributivo)». Di conseguenza, sostiene l'INPS, sarebbe «del tutto logico», in un sistema - di natura meramente opzionale - finalizzato a ottenere l'impiego integrale della complessiva provvista contributiva, che «all'assicurato sia preclusa la possibilità di eliminare dalla base di calcolo del trattamento i segmenti di contribuzione che reputa meno favorevoli».
In ogni caso, la pluralità dei sistemi di calcolo applicati escluderebbe che il trattamento liquidato sia stato «condizionato solo ed esclusivamente dalla consistenza dell'ultimo stipendio» e ciò, per l'ente previdenziale, renderebbe «evidente la sostanziale differenza» fra la fattispecie odierna e quella esaminata dalla citata sentenza n. 264 del 1994: «la valorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del montante contributivo prodotto dalle retribuzioni percepite da quella data in poi», assicurerebbe «la proporzionalità fra l'importo della pensione e la quantità e qualità del lavoro prestato», ai sensi dell'art. 36 Cost.
Sarebbe, invece, del tutto generica la prospettata violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali non implicherebbe un «rapporto di stretta corrispondenza fra il trattamento pensionistico e la retribuzione percepita in servizio», quanto piuttosto «una tendenziale correlazione fra i due valori», con il solo limite - che sarebbe nella specie rispettato - della salvaguardia della possibilità di soddisfare le esigenze di vita.
9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, sostenendo l'inammissibilità e, in ogni caso, la non fondatezza delle questioni sollevate.
L'interveniente ritiene non pertinente il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in relazione a fattispecie differenti da quella oggetto dell'odierno scrutinio ed evidenzia come, in quella stessa giurisprudenza, sia stata affermata «la persistenza di "elementi di motivata diversità"» che giustificherebbe una differente disciplina «per le pensioni dei dipendenti iscritti alle casse di previdenza pubbliche», rispetto a «quella prevista per i dipendenti privati» (viene citata la sentenza n. 148 del 2017).
Anche la difesa erariale evidenzia che il diritto alla pensione di vecchiaia si sarebbe perfezionato, nel caso di specie, «solo nel momento in cui l'assicurato ha esercitato la facoltà di cumulo della contribuzione», ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e che il ricorrente non potrebbe beneficiare degli effetti di un'eventuale pronuncia «circa la legittimità del (solo) art. 43» del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La pensione in godimento, in ogni caso, sarebbe «la risultante di più quote», disciplinate da diverse fonti, che non considerano la sola retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro; sicché l'importo complessivo non potrebbe ritenersi lesivo dei principi di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico.
10.- Con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte privata, oltre a ribadire gli argomenti esposti nell'atto di costituzione, ha controdedotto rispetto alle difese dell'INPS e dell'Avvocatura generale dello Stato.
Con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, che l'INPS e l'Avvocatura considerano ostativa alla neutralizzazione, la parte privata ritiene che la richiesta "sterilizzazione" possa operare anche in caso di cumulo gratuito, dal momento che il successivo comma 245 dell'art. 1 della stessa legge dispone che ciascuna gestione interessata, per la parte di propria competenza, deve applicare le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e, dunque, nel caso di specie, anche quelle del sistema retributivo, che ammette appunto la neutralizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 225 del 2024), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali.
Di entrambe le disposizioni si prospetta il contrasto con gli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di neutralizzare - ossia di non considerare ai fini del calcolo - periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo.
Nel caso oggetto del giudizio principale, risulta che il ricorrente, in periodi compresi tra il 1976 e il 2018, ha versato contributi in cinque diverse «gestioni previdenziali», tutte attualmente facenti capo all'INPS.
In nessuna di tali gestioni la contribuzione accreditata sarebbe stata sufficiente per la maturazione di un autonomo diritto alla pensione.
Tuttavia, l'interessato ha potuto usufruire del meccanismo di cumulo gratuito previsto dall'art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012 e, aggregando i vari spezzoni contributivi, ha conseguito un'unica pensione di vecchiaia, previo calcolo delle varie quote da parte delle singole gestioni previdenziali interessate, in base ai rispettivi ordinamenti.
In particolare, nella gestione pubblica risulta accreditata contribuzione in forza di rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, svolti presso vari enti locali e, da ultimo, dall'8 ottobre 2015 al 30 aprile 2018, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, in virtù di «più contratti quale docente supplente».
La retribuzione percepita nell'ultimo periodo, tuttavia, in quanto inferiore alla precedente, avrebbe determinato, per le regole di calcolo dettate dalle disposizioni censurate, una drastica riduzione della quota pensionistica pubblica.
Ciò sarebbe avvenuto, in particolare, per effetto del computo di contribuzione non necessaria ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, perché la legge n. 228 del 2012 ritiene sufficiente il versamento, in qualunque gestione interessata, di venti anni di contributi, pacificamente raggiunti prima dell'assunzione degli incarichi di supplenza di cui si discute nel giudizio principale.
Il pensionato ha quindi chiesto il ricalcolo della cosiddetta «"quota A"» della pensione - quella appunto liquidata con il sistema retributivo - previa esclusione dal computo dei periodi di contribuzione accreditati per gli incarichi ricevuti dal Ministero dell'istruzione.
2.- In punto di non manifesta infondatezza, l'ordinanza di rimessione richiama alcune pronunce di questa Corte (in particolare le sentenze n. 264 del 1994 e n. 224 del 2022), che, con riguardo al sistema retributivo di calcolo del trattamento pensionistico nel settore privato, hanno elaborato il principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva. In forza di esso, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all'incremento della pensione.
La Corte dei conti rimettente, inoltre, sostiene che, avendo la sentenza n. 173 del 2018 esteso anche al lavoro autonomo l'applicabilità del principio, quest'ultimo avrebbe assunto valenza generale, sicché esso s'imporrebbe anche nell'ordinamento pensionistico pubblico.
Si riconosce che, in quest'ultimo, vigono regole diverse, ma si evidenzia pure che esse sono tese a valorizzare - a vantaggio del lavoratore - un periodo molto più breve della fase finale della vita lavorativa.
Escludere la neutralizzazione richiesta, quindi, rovescerebbe la ratio stessa di quelle previsioni normative peculiari, volte alla maggiore tutela dei dipendenti pubblici, per i quali, normalmente, risulta più elevata proprio la retribuzione percepita «all'ultimo scatto della progressione economica raggiunta».
Si produrrebbe, quindi, un risultato lesivo non solo del principio di eguaglianza rispetto ai lavoratori privati, ma anche del principio di proporzionalità tra il lavoro prestato durante il servizio attivo e il trattamento pensionistico, rendendo, altresì, quest'ultimo inadeguato a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore in quiescenza.
Ancora, sarebbe evidente il contrasto «con il dovere del legislatore di tutelare "il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"» (art. 35, primo comma, Cost.), in quanto «principio fondante della Repubblica» (art. 1, primo comma, Cost.), nonché «con il riconoscimento del particolare valore sociale dell'attività di "pubblici impiegati [che] sono al servizio esclusivo della Nazione"» (art. 98, primo comma, Cost.), la cui dignità sarebbe lesa dall'induzione a «un prematuro collocamento a riposo».
3.- Così ricostruite le censure, è utile premettere che, per i casi in cui un lavoratore si trovi accreditati contributi versati in diverse gestioni, senza raggiungere in nessuna di esse i requisiti minimi per la maturazione di un autonomo diritto a pensione, l'ordinamento ha approntato nel tempo diversi meccanismi attraverso i quali, a domanda dell'interessato, è possibile porre rimedio alla frammentazione del rapporto previdenziale.
Con la legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), è stato disciplinato l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi, con il quale è possibile chiedere che tutti i contributi versati nelle diverse gestioni siano ricongiunti - ossia trasferiti effettivamente - presso una sola di esse, per ottenere la liquidazione di un unico trattamento pensionistico, sulla base delle regole e con gli importi previsti dal fondo prescelto. In ragione dei diversi criteri di computo vigenti nelle differenti strutture assicurative, si tratta di uno strumento normalmente oneroso per l'interessato, chiamato il più delle volte a versare una somma, individuata secondo i criteri previsti dalla legge, al fine di determinare una parità di valore per tutti i periodi di contribuzione da conteggiare.
Con la sentenza n. 61 del 1999, questa Corte ha segnalato la necessità di introdurre un'alternativa alla ricongiunzione, dal momento che l'onere economico previsto per la medesima poteva risultare talmente elevato da precludere l'esercizio del diritto alla valorizzazione di tutti i periodi assicurativi.
L'invito è stato raccolto dal legislatore, il quale, con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), ha disciplinato il diverso istituto della totalizzazione: al titolare di differenti posizioni assicurative presso diverse gestioni pensionistiche viene attribuita, senza alcun onere finanziario aggiuntivo, la facoltà di sommare «tutti e per intero» (art. 1, comma 3) i singoli segmenti contributivi - purché non coincidenti - al fine del conseguimento di un'unica pensione, di cui si prevede la liquidazione esclusivamente con il sistema contributivo (art. 4).
Ancora, per ulteriormente agevolare l'ottenimento di un unico trattamento pensionistico attraverso l'aggregazione di scampoli contributivi sparsi in differenti gestioni, l'art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012 ha previsto il meccanismo del cumulo gratuito, utilizzato dal ricorrente nel giudizio a quo.
Il comma 239 dispone, in particolare, che i soggetti iscritti «a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata [...] e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima», nonché alle casse professionali, «che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione».
A differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun reale trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, diversamente dalla totalizzazione, non impone il computo con il sistema contributivo: ai sensi del comma 245, «[l]e gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento». Le suddette quote, quindi, possono essere liquidate anche con il sistema retributivo o misto, fermo restando che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo (comma 246).
Infine, come per la totalizzazione, l'operazione è senza oneri economici per l'interessato e si prevede espressamente che il cumulo deve avere a oggetto «tutti e per intero» i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative (comma 243).
4.- Nel quadro normativo appena tracciato, è possibile ora scrutinare le questioni sollevate, cominciando a esaminare le eccezioni preliminari.
5.- L'INPS ha eccepito l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle censure mosse anche all'art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 che, nella «"gestione Enti Locali"», fa riferimento alla «retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio».
L'eccezione è fondata.
La suddetta disposizione non ha trovato applicazione nella liquidazione del trattamento pensionistico oggetto del giudizio principale e potrebbe venire in rilievo solo una volta neutralizzata la contribuzione "dannosa" versata per gli incarichi di supplenza alle dipendenze del Ministero dell'istruzione.
In tal caso, tuttavia, non vi sarebbe alcun bisogno di "sterilizzare", neppure in parte, la contribuzione residua, rispetto alla quale, non a caso, il ricorrente nel giudizio principale non ha avanzato alcuna domanda di neutralizzazione. In sostanza, la retribuzione che verrebbe valorizzata ai fini pensionistici, in applicazione dei criteri dettati dalla citata disposizione, finirebbe per coincidere, come correttamente evidenziato dall'INPS, proprio con quella che lo stesso rimettente reputa maggiormente favorevole.
6.- Pur così circoscritto il thema decidendum, l'esame nel merito delle questioni sollevate sull'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 è, comunque, precluso dall'incompleta considerazione del quadro normativo, parimenti eccepita dall'INPS.
Come illustrato in precedenza (punto 3 del Considerato in diritto), ai sensi del chiaro disposto dell'art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, per ottenere un'unica pensione attraverso il cumulo gratuito devono essere utilizzati «tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati» presso le diverse gestioni.
Tale previsione normativa costituisce perciò un autonomo ostacolo all'accoglimento della domanda di neutralizzazione, come peraltro rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4845, citata dall'INPS nelle proprie difese) rispetto all'analoga regola scandita dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale.
Ciò nondimeno, la sezione regionale della Corte dei conti rimettente non coinvolge nelle censure l'art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, né si confronta con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, fosse anche solo per operare un distinguishing rispetto alla disciplina della totalizzazione. Un tale tentativo è stato fatto, invece, dalla parte privata nella memoria illustrativa, ove è stato sostenuto che la normativa sul cumulo gratuito non avrebbe mutuato, dall'istituto della totalizzazione, il vincolo del calcolo esclusivamente contributivo.
A prescindere dalla decisività o meno di tale argomento, tuttavia, non v'è dubbio che, qualora tale profilo non fosse stato trascurato dal giudice a quo, per portare il meccanismo del cumulo gratuito all'attenzione di questa Corte al fine di invocare l'applicazione anche a quest'ultimo del principio di neutralizzazione, sarebbe stato necessario il promuovimento di un'autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla relativa disciplina. E ciò proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che con riguardo al suddetto principio, ha ripetutamente riservato a se stessa la valutazione delle fattispecie di volta in volta oggetto di giudizio, nei loro rapporti con le regole relative alla determinazione della retribuzione pensionabile, per la rilevata necessità di modulare la portata della neutralizzazione sulle specificità delle situazioni coinvolte (sentenze n. 112 del 2024 e n. 224 del 2022).
Né può sopperire a tale omissione l'affermazione - ancora una volta segnalata dalla parte privata - con la quale la Corte dei conti rimettente sostiene che, nel caso trattato dalla sentenza n. 173 del 2018 e deciso con l'applicazione del principio di neutralizzazione, la questione avrebbe riguardato «il calcolo della quota della pensione di cumulo tra due gestioni, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo». In realtà, come correttamente evidenziato dalla difesa pubblica nella discussione in udienza, la questione qui in esame è del tutto nuova, perché il cumulo preso in considerazione dal richiamato precedente di questa Corte non era certo quello disciplinato dalla legge n. 228 del 2012, non fosse altro perché, in quella vicenda, il trattamento pensionistico oggetto del giudizio principale aveva avuto decorrenza da una data - 1° luglio 2010 - anteriore a quella di entrata in vigore della legge da ultimo citata.
7.- In definitiva, l'insufficiente o, comunque, incompleta considerazione del quadro normativo, nei termini innanzi indicati, compromette l'iter logico-argomentativo delle censure (tra le tante, sentenze n. 20 del 2025, n. 184 del 2024; ordinanza n. 152 del 2023), sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza, determinando l'inammissibilità delle questioni sollevate (sentenza n. 177 del 2024).
8.- È appena il caso di aggiungere che la Corte dei conti rimettente neppure si confronta, anche solo per escluderne eventualmente la pertinenza, con l'art. 2, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo il quale «[i]l trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: [...] al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.