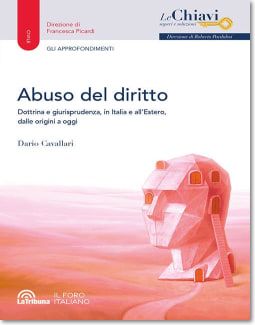Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 1º agosto 2025
Presidente: Jarukaitis - Relatrice: Frendo
«Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Divieto di assoggettare a imposizione gli utili percepiti dalla società madre - Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi - Ambito di applicazione - Imposta regionale sulle attività produttive - Inclusione del 50% dei dividendi percepiti dalle società madri nella base imponibile di tale imposta».
Nelle cause riunite da C‑92/24 a C‑94/24, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia), con ordinanze del 6 ottobre 2023, pervenute in cancelleria il 24 gennaio 2024, nei procedimenti Banca Mediolanum SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia.
[...]
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).
2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra Banca Mediolanum SpA e l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia (Italia) (in prosieguo: l'«amministrazione finanziaria») in merito a istanze di rimborso parziale dell'imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo: l'«IRAP»).
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. Il considerando 4 della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2004, L 7, pag. 41), così recitava:
«L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE [del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6),] definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. (...)».
4. Ai sensi dei considerando 1 e 3 della direttiva 2011/96:
«(1) La direttiva [90/435] ha subito numerose e sostanziali modificazioni (...). Poiché essa deve ora essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di razionalità e chiarezza, alla sua rifusione.
(...)
(3) La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre».
5. L'articolo 2 della direttiva 2011/96 così prevede:
«Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:
a) "società di uno Stato membro" qualsiasi società:
(...)
iii) che (...) sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate;
(...)».
6. Nella sua versione anteriore alle modifiche apportate dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014 (GU 2014, L 219, pag. 40), che gli Stati membri dovevano recepire nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 2015, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96 disponeva quanto segue:
«Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione; o
b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta».
7. A seguito delle modifiche apportate dalla direttiva 2014/86, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 è così formulato:
«(...)
a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; (...)».
8. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/96:
«Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre.
In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».
9. L'allegato I, parte B, di detta direttiva, intitolato «Elenco delle imposte di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii)», enumera le seguenti imposte:
«(...)
- imposta sul reddito delle società in Italia,
(...)».
Diritto italiano
10. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 31 dicembre 1986) (in prosieguo: il «TUIR»), enuncia quanto segue:
«(...)
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione (...), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. (...)
(...)».
11. L'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (supplemento ordinario alla GURI n. 298, del 23 dicembre 1997) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 446/1997»), prevede quanto segue:
«1. Presupposto dell'[IRAP] è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. (...)».
12. Ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo:
«L'[IRAP] si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
(...)».
13. Il decreto legislativo n. 446/1997 è stato modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244. - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (supplemento ordinario alla GURI n. 300, del 28 dicembre 2007) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 446/1997 modificato»). L'articolo 6 del decreto legislativo n. 446/1997 modificato, intitolato «Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari», così dispone:
«1. (...) la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi (...):
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
(...)».
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
14. Nel corso degli esercizi fiscali 2014 e 2015, Banca Mediolanum, una banca fiscalmente residente in Italia, e Mediolanum SpA, una società figlia di Banca Mediolanum anch'essa fiscalmente residente in Italia e incorporata da tale banca prima dell'avvio dei procedimenti giurisdizionali all'origine delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, detenevano partecipazioni in diverse società fiscalmente residenti in altri Stati membri dell'Unione europea.
15. Banca Mediolanum e Mediolanum percepivano dividendi da tali società figlie e li includevano nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle società (in prosieguo: l'«IRES»), che figura nell'allegato I, parte B, della direttiva 2011/96, entro il limite del 5% del loro importo, conformemente all'articolo 89, comma 2, del TUIR.
16. Dette società, nella loro qualità di intermediari finanziari, includevano detti dividendi anche nella base imponibile dell'IRAP, nella misura del 50% del loro importo, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997 modificato.
17. In seguito, Banca Mediolanum, ritenendo che tale disposizione fosse contraria all'articolo 4 della direttiva 2011/96, ha presentato all'amministrazione finanziaria tre istanze dirette a ottenere il rimborso della quota dell'IRAP versata in ragione dell'inclusione, nella base imponibile di tale imposta, degli importi corrispondenti al 50% dei dividendi che Banca Mediolanum aveva percepito dalle società figlie residenti in altri Stati membri.
18. L'amministrazione finanziaria ha respinto tali istanze con la motivazione che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997 modificato non sarebbe contrario all'articolo 4 della direttiva 2011/96, in quanto tale disposizione sarebbe applicabile soltanto alle imposte sui redditi, e non anche all'IRAP.
19. Banca Mediolanum ha proposto dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto dell'amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (Italia), la quale ha emesso tre sentenze che hanno confermato tali decisioni.
20. Conseguentemente, Banca Mediolanum ha interposto appello contro tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia), giudice del rinvio.
21. Detto giudice, facendo riferimento all'articolo 4 della direttiva 2011/96 nella sua versione anteriore alla modifica apportata dalla direttiva 2014/86, ritiene che il divieto, derivante da tale articolo 4, di trattare gli utili distribuiti da una società figlia residente in uno Stato membro a una società madre residente in un altro Stato membro come imponibili, in misura superiore al 5% del loro importo, potrebbe applicarsi anche all'IRAP.
22. A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che l'IRAP, conformemente agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 446/1997, tramite il quale tale imposta è stata introdotta, da un lato, ha come presupposto l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e, dall'altro, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione italiana interessata.
23. Tuttavia, tale giudice ritiene che dalle sentenze del 17 maggio 2017, AFEP e a. (C-365/16, EU:C:2017:378), nonché del 17 maggio 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379), risulti che l'articolo 4 della direttiva 2011/96 comporta, a carico degli Stati membri, il divieto di assoggettare a qualunque forma di imposizione i dividendi distribuiti alle società madri residenti in uno Stato membro dalle società figlie residenti in altri Stati membri, in misura superiore al 5% dell'ammontare di tali dividendi.
24. Secondo detto giudice, qualora si potesse ritenere che l'IRAP rientri in tale divieto, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997 modificato sarebbe incompatibile con la direttiva 2011/96, laddove tale disposizione impone alle banche e agli altri intermediari finanziari che si qualifichino come società madri ai sensi di tale direttiva di assoggettare ad IRAP il 50% dei dividendi che tali società hanno percepito da società residenti in altri Stati membri che si qualifichino come società figlie ai fini di detta direttiva.
25. Alla luce di tali circostanze, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha deciso, in ciascuno dei procedimenti di appello dinanzi ad essa pendenti, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la pretesa della Repubblica Italiana, recata dal comma 1 dell'articolo 6 del [decreto legislativo n. 446/1997], di assoggettare ad IRAP il 50 per cento dei dividendi incassati da intermediari finanziari residenti in Italia che si qualifichino come società madri agli effetti della direttiva [2011/96] e distribuiti da società residenti in altri Stati Membri dell'Unione Europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall'IRAP la frazione dell'imposta societaria relativa a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri residenti in uno Stato Membro abbiano incassato dalle società figlie residenti in altri Stati Membri ad imposizione per una percentuale superiore al 5 per cento del relativo importo sancito dall'articolo 4 della predetta direttiva».
Sulla questione pregiudiziale
26. Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottoposta alla sua cognizione. In tale prospettiva, incombe alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia [sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 78 e giurisprudenza citata].
27. Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, diversi da quelli distribuiti in occasione della liquidazione di detta società figlia, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/96 lascia esplicitamente agli Stati membri la scelta tra il sistema previsto da tale paragrafo 1, lettera a) (in prosieguo: il «sistema dell'esenzione») e il sistema previsto da detto paragrafo 1, lettera b) (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2025, John Cockerill, C‑135/24, EU:C:2025:176, punti 27 e 28 e giurisprudenza citata). Qualora uno Stato membro abbia scelto uno di questi sistemi, la disposizione relativa all'altro sistema non è pertinente (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C‑389/18, EU:C:2019:1132, punto 32, e del 12 maggio 2022, Schneider Electric e a., C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 63 e giurisprudenza citata).
28. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/96, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire, segnatamente, che gli oneri relativi alla partecipazione della società madre nel capitale della società figlia non sono deducibili dall'utile imponibile della società madre. Risulta parimenti da tale disposizione che se, in tal caso, le spese di gestione relative alla partecipazione sono fissate forfettariamente, tale importo non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia (sentenze del 17 maggio 2017, AFEP e a., C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 23, nonché del 17 maggio 2017, X, C‑68/15, EU:C:2017:379, punto 72).
29. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la Repubblica italiana applica il sistema dell'esenzione. Tuttavia, oltre ad assoggettare ad imposizione, a titolo di IRES, i dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro controllate nella misura del 5% del loro importo, conformemente all'articolo 89, comma 2, del TUIR, la normativa nazionale richiede, in sostanza, di includere il 50% di tali dividendi nella base imponibile di un'altra imposta, ossia l'IRAP, indipendentemente dall'origine di detti dividendi.
30. Alla luce di tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4 della direttiva 2011/96 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro che ha scelto il sistema dell'esenzione può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.
31. Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, da un lato, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, punto 27). Dall'altro lato, un'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione non può avere come risultato di privare di ogni effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell'Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest'ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenze del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 39, e del 13 ottobre 2022, Gmina Wieliszew, C‑698/20, EU:C:2022:787, punto 83).
32. In primo luogo, sul piano letterale, dalla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risulta chiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistema dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri.
33. A tal riguardo, per quanto riguarda la versione di tale disposizione risultante dalla modifica introdotta dalla direttiva 2014/86, la Corte ha constatato che l'applicazione di detta disposizione non è limitata ad un'imposta in particolare (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a., C‑365/16, EU:C:2017:378, punti 5 e 33). Essa ha proceduto a tale constatazione anche per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Schneider Electric e a., C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 47), che corrisponde alla versione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 menzionata dal giudice del rinvio, nonché da tutte le parti nelle loro osservazioni scritte.
34. La Corte ha quindi dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2014/86, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di residenza di una società madre che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli provenienti dalle società figlie non residenti di tale società (sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a., C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 35).
35. Di conseguenza, dal punto di vista letterale, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 deve essere interpretato nel senso che il sistema dell'esenzione da esso previsto riguarda qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri.
36. In secondo luogo, sul piano contestuale, occorre ricordare che il considerando 4 della direttiva 2003/123 che ha modificato la direttiva 90/435 - direttiva, questa, di cui la direttiva 2011/96, come indicato nel suo considerando 1, effettua la rifusione - enuncia che l'articolo 2 della direttiva 90/435 definisce le società che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva e che l'allegato di quest'ultima contiene un elenco delle società alle quali essa si applica.
37. A tal riguardo, l'articolo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/96 e l'allegato I, parte B, di quest'ultima elencano, al fine di designare le società degli Stati membri che si reputano incluse nell'ambito di applicazione di tale direttiva, le imposte nazionali alle quali tali società sono normalmente assoggettate (v., per analogia, sentenza dell'8 giugno 2000, Epson Europe, C‑375/98, EU:C:2000:302, punto 22).
38. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, se l'articolo 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, tale articolo non è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva.
39. In terzo e ultimo luogo, sul piano teleologico, come risulta dal suo considerando 3, la direttiva 2011/96 persegue l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre a livello di società madre.
40. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità, sul piano fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro, la direttiva 2011/96 mira ad evitare, in particolare, mediante la regola prevista dal suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), una doppia imposizione di tali utili, in termini economici, vale a dire ad evitare che gli utili distribuiti siano colpiti, una prima volta, a livello della società figlia e, una seconda volta, a livello della società madre (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 maggio 2022, Schneider Electric e a., C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 45; v. anche, in tal senso, sentenza del 13 marzo 2025, John Cockerill, C‑135/24, EU:C:2025:176, punto 33).
41. Di conseguenza, nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, include nella propria base imponibile anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione.
42. Nel caso di specie, il decreto legislativo n. 446/1997 modificato prevede, al suo articolo 6, paragrafo 1, che, per quanto riguarda gli intermediari finanziari, la base imponibile dell'IRAP sia costituita dalla somma algebrica di diversi elementi, tra i quali figura, alla lettera a) di tale disposizione, il margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi.
43. Poiché, come precisato dal governo italiano, il margine d'intermediazione include tutti i dividendi, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997 modificato determina come effetto che il 50% dei dividendi sia incluso nella base imponibile dell'IRAP cui sono assoggettati gli intermediari finanziari, indipendentemente dall'origine di tali dividendi.
44. Ciò premesso, si deve ritenere che il sistema dell'esenzione osti a una normativa nazionale la quale consente l'inclusione dei dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri nella base imponibile di un'imposta, quale l'IRAP, in aggiunta all'inclusione di tali dividendi, nella misura del 5% del loro importo, nella base imponibile di un'imposta sui redditi delle società, come l'IRES.
45. Peraltro, relativamente all'argomento del governo italiano secondo cui, in sostanza, la soluzione indicata al punto precedente può dar luogo ad una discriminazione alla rovescia in danno di una società madre residente in Italia che percepisce dividendi dalle sue società figlie italiane, in asserita violazione del principio di parità di trattamento, è giocoforza constatare che la situazione così evocata da tale governo sarebbe puramente interna alla Repubblica italiana.
46. Orbene, secondo la giurisprudenza, il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione non può essere fatto valere in una situazione puramente interna. In una situazione del genere, spetta ai giudici nazionali valutare se vi sia una discriminazione vietata dal diritto interno e, se del caso, stabilire come essa debba essere eliminata (ordinanza del 5 aprile 2004, Mosconi e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C‑3/02, EU:C:2004:224, punto 53 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C‑830/18, EU:C:2020:275, punto 35 e giurisprudenza citata).
47. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 4 della direttiva 2011/96 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema dell'esenzione può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.
Sulle spese
48. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.