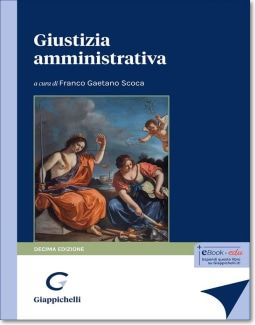Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 7 luglio 2025, n. 18427
Presidente: Giusti - Relatore: Tricomi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. B.S., cittadino dell'Algeria, ha impugnato ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 in data 10 giugno 2024, dinanzi al Tribunale di Milano, il provvedimento del 14 febbraio 2024 (notificatogli il 16 maggio 2024) con cui la Commissione nazionale per il diritto d'asilo (d'ora in avanti, CNA) gli ha revocato lo status di rifugiato, altresì comminandogli il divieto di reingresso nel territorio italiano per 10 anni, status di rifugiato che gli era stato riconosciuto con provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 6 dicembre 2013 in quanto riconosciuto vittima di persecuzione per appartenenza al gruppo sociale LGBTI.
1.2. Come esposto nel decreto, con una nota del 17 gennaio 2024 trasmessa dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo venne informata del fatto che la permanenza in Italia del cittadino straniero avrebbe potuto esporre il Paese a gravi rischi per la sicurezza dello Stato.
Quindi, la Commissione nazionale, emesso l'avviso di avvio del procedimento di revoca dello status di rifugiato, il 1° febbraio 2024 effettuò l'audizione del cittadino straniero e con provvedimento Id. MI0003711 del 14 febbraio 2024 (notificato il 16 maggio 2024) - impugnato dinanzi al Tribunale di Milano - dispose la revoca dello status di rifugiato del cittadino straniero ritenendo che la fattispecie rientrava integralmente nelle ipotesi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 13 e 12 del d.lgs. n. 251/2007 e che doveva applicarsi anche l'art. 33, comma 3, che rinvia all'art. 32, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 25/2008, secondo cui il provvedimento adottato dal Collegio in tale ipotesi reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso e soggiorno dell'interessato di cui all'art. 13, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 286/1998, che quantificava in anni dieci, attesa la accertata pericolosità dell'interessato per la sicurezza dello Stato.
In particolare la CNA ha ravvisato la ricorrenza di una prima fattispecie di revoca, di cui al combinato disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007 ("quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato") «(...) CONSIDERATO che la segnalazione della situazione di pericolosità del beneficiario sopra indicato deve essere in primo luogo inquadrata nel contesto attuale delle minacce alla sicurezza dello Stato, così come attualmente rappresentato dai competenti organi di sicurezza. In particolare, la minaccia derivante da persone non stabilmente incardinate in organizzazioni terroristiche, ma instradate in un percorso di radicalizzazione solitario o on-line (c.d. lupi solitari) sono stati rappresentati nella Relazione Annuale sulla Politica di Informazione per la Sicurezza del 2021...» e che «Nel contesto sopra descritto, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rappresentato che l'interessato costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato in quanto esprime attraverso i social media contenuti violenti e minacciosi, di matrice politica e religiosa, che si inseriscono nel quadro di rischio determinato dalle attuali contingenze geopolitiche». La CNA ha affermato che si determina, pertanto, sotto tale versante, la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007.
Con il medesimo provvedimento la CNA ha ritenuto, sotto altro profilo, che dagli esiti istruttori fossero emerse circostanze che deponevano per una seconda fattispecie di revoca in ragione dell'insussistenza attuale di rischi legati alla supposta condizione personale del cittadino straniero e alla sua presunta discriminazione nella famiglia di origine a causa del suo orientamento sessuale e ne ha dedotto che ciò integrava la fattispecie di revoca cui all'art. 13, comma 12, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007 ("Il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti"), con l'effetto che non potevano dirsi integrate le condizioni che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, avrebbero comportato l'applicazione del principio di non refoulement.
1.3. Nel giudizio di primo grado il Ministero dell'interno ha resistito, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria giudiziale è stato audito il cittadino straniero e, all'esito, i suoi difensori - come si evince dal controricorso (fol. 12/13) - hanno insistito perché fosse ordinato all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio la nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dell'interno, con termine per osservazioni sulla stessa in caso di eventuale ostensione, insistendo, per il resto, nel ricorso.
Il Tribunale, dopo avere ascoltato il cittadino straniero, con decreto n. cron. 9439/2024 ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di revoca dello status di rifugiato emesso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo il 14 febbraio 2024 nonché gli atti ad esso conseguenti, avendo riguardo ad entrambe le cause di revoca dello status espresse, disponendo il ripristino ad ogni effetto, in capo al ricorrente, dello status di rifugiato, con integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
Il Tribunale ha riportato gli ampi stralci del provvedimento della CNA impugnato di cui sopra e ha evidenziato che risultava centrale nella motivazione della CNA il contenuto di due pubblicazioni: come si legge nel decreto impugnato (fol. 2) «L'immagine su WhatsApp, rimasta nel profilo personale del B.S. per due giorni, mostrava il portavoce militare di Hamas, vestito in modo militare e col volto travisato da una kefiah bianca e rossa, che ammonisce che "la vittoria di Allah è vicina"» e un post su Instagram, su un profilo privato «a commento di una foto di un gruppo di bambini terrorizzati e feriti e menzionando le migliaia di bambini palestinesi uccisi a quella data nell'ambito dell'operazione militare avviata nella c.d. Striscia di Gaza dopo i massacri perpetrati in Israele da Hamas il 7 ottobre 2023, il B.S., sul presupposto che trattasi di Paesi che sostengono lo "stato sionista terrorista" (Israele) e hanno le mani sporche di sangue, minaccia (anche l'Italia, espressamente indicata fra di essi) che "questi assassini" saranno rintracciati e puniti "se non loro, la loro prole"; concludendo "occhio per occhio dente per dente viva Hamas e viva la Resistenza"» (fol. 2 del decr. imp.).
Il Tribunale ha, quindi, dato atto delle contestazioni mosse dal cittadino straniero che, nel ricorso, aveva riferito che la nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dell'interno, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, non era stata allegata, né messa a sua disposizione, nonostante fosse l'atto presupposto sul quale si basava il provvedimento impugnato, e che alla pregressa richiesta avanzata formalmente dal cittadino straniero era stata opposta la preclusione ex art. 24 della l. n. 241/1990; ha richiamato le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato.
Per quanto di interesse, il Tribunale, esaminate le richieste istruttorie, ha disatteso la richiesta di acquisizione della nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato avanzata dal cittadino straniero, ed ha affermato che «E).2 L'acquisizione della Nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato non è necessaria, e non ne va quindi ordinata l'esibizione in causa. La conseguenza della sua mancata produzione, legittimamente fondata su ragioni di secretazione, giova infatti al ricorrente: atteso che, - avendo egli sin ab origine ed ancora in sede di ricorso introduttivo eccepito la sconoscenza del suo contenuto - ed avendo, ciò nonostante, deciso l'Amministrazione di non svelarlo, detta Nota è per questo giudice tamquam non esset e non se ne potrà trarre alcuna conseguenza probatoria sfavorevole al B.S. Il che significa che, per quanto riguarda il primo e principale capo del provvedimento impugnato, che la pericolosità del ricorrente per la sicurezza dello Stato italiano non potrà che esser interamente ed esclusivamente desunta dal contenuto dei messaggi cui s'è detto al superiore § B).2».
Quindi, ha proceduto all'esame del merito della controversia.
Innanzi tutto ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revoca dello status di rifugiato per un'erroneità della rappresentazione dei fatti posti nel 2013 a fondamento della domanda di protezione internazionale; ha evidenziato che non vi erano elementi idonei a dimostrare la supposta erroneità di quanto rappresentato in relazione alle discriminazioni subite a causa dell'orientamento sessuale e che nel provvedimento di revoca mancava qualsiasi riferimento ad un mutamento del quadro culturale e giuridico dell'Algeria in proposito, di guisa che il riconoscimento dello status di rifugiato meritava piena conferma.
Quindi, passando all'esame dell'altra causa di revoca il Tribunale, pur non dubitando «della gravità intrinseca delle esternazioni effettuate dal ricorrente», su cui si è soffermato, ha dedotto che «G).2 E tuttavia, ad avviso del Collegio, ciò non rende ex se solo il ricorrente quel concreto pericolo per la sicurezza dello Stato che solo può giustificare la revoca del suo status di rifugiato. Perché veramente B.S. possa essere considerato tale, occorre che quei messaggi - dal contenuto oggettivamente minaccioso, violento e vendicativo - si siano inseriti in un contesto personale e sociale concretamente rivelatore del rischio di una sua evoluzione verso la c.d. radicalizzazione, sino a indurlo potenzialmente ad intenti omicidiari e terroristici del tipo di quelli menzionati nel provvedimento impugnato» ha concluso «È dunque credibile, come dichiarato dal B.S. anche in questa sede e non smentito dal resistente (di ciò, evidentemente, onerato), che egli non frequenta (né in Italia, né altrove) gli ambienti del radicalismo islamico e neppure la moschea per la preghiera del venerdì (...) Il che esclude che sussista quel livello di concretezza del rischio di passaggio all'azione "offensiva", che solo può assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare - sia pur preventivamente - la revoca dei benefici concessigli con lo status di rifugiato» (fol. 9).
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso, chiedendo la cassazione del decreto impugnato con due mezzi illustrati con memoria.
Il cittadino straniero ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, va rimarcato che il ricorso per cassazione svolge due motivi che concernono questioni procedurali e di merito riferite alla statuizione riguardante il provvedimento di revoca adottato ai sensi del combinato disposto costituito dall'art. 13, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007 ("quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato").
Di contro, la statuizione di annullamento del provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 13, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007 (perché "Il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti") non risulta attinta da censure, come si evince anche dalla memoria depositata dalla Avvocatura generale.
Tanto premesso, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dedotta dal controricorrente sul rilievo che la mancata impugnazione della statuizione relativa alla revoca del rifugio ex art. 13, lett. b), d.lgs. 251/2007 escluderebbe in toto l'interesse l'impugnazione: ciò non è, in quanto il provvedimento di revoca esponeva due distinte ed autonome ragioni ciascuna di per sé sufficiente a privare il cittadino straniero dello status e le differenti vicende processuali non interferiscono sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, circoscritto ad una sola di esse.
Per il resto, non si ravvisa alcuna ragione di inammissibilità, perché il ricorso di legittimità delinea in maniera chiara ed esauriente le vicende di causa, le contestazioni sollevate e le questioni in diritto sottoposte all'esame di questa Corte.
Ne segue, quindi, l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente.
3. Il Ministero dell'interno ha svolto due motivi di ricorso con cui ha denunciato:
I) la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007, degli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008; nonché la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
II) la nullità del decreto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della direttiva 2011/95 e degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 251/2007.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura il decreto nella parte in cui ha escluso la necessità di acquisire la nota del 17 gennaio 2024 della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dell'interno, ritenendo la stessa tamquam non esset ai fini della decisione.
Più nello specifico, si impugnano i seguenti passaggi motivazionali: "E).2 L'acquisizione della Nota ministeriale menzionata nel provvedimento impugnato non è necessaria, e non ne va quindi ordinata l'esibizione in causa. La conseguenza della sua mancata produzione, legittimamente fondata su ragioni di secretazione, giova infatti al ricorrente: atteso che, - avendo egli sin ab origine ed ancora in sede di ricorso introduttivo eccepito la sconoscenza del suo contenuto - ed avendo, ciò nonostante, deciso l'Amministrazione di non svelarlo, detta Nota è per questo giudice tamquam non esset e non se ne potrà trarre alcuna conseguenza probatoria sfavorevole al B.S. Il che significa che, per quanto riguarda il primo e principale capo del provvedimento impugnato, che la pericolosità del ricorrente per la sicurezza dello Stato italiano non potrà che esser interamente ed esclusivamente desunta dal contenuto dei messaggi veicolati nei social network (e solo parzialmente riprodotti in questa sede) di cui s'è detto al superiore § B).2".
Il Ministero, nello svolgere la sua critica, ha dedotto di avere precisato sin dal primo grado, in sede di comparsa di costituzione e risposta, che la nota della polizia di prevenzione posta a fondamento della revoca non risultava ostensibile alla luce di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/1990, che rimandava al d.m. 16 marzo 2022 per la individuazione delle categorie di atti sottratti al diritto di accesso. Ha rimarcato che il predetto d.m. contempla espressamente i documenti relativi ai procedimenti di revoca e di cessazione dello stato di protezione internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
Ha quindi evidenziato che, al fine di realizzare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di segretezza e il diritto di difesa, soccorre l'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007 che disciplina una specifica procedura giudiziale volta a consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti individuati dal predetto d.m.
Ha ricordato che, per i documenti con classifica di "riservato", la procedura è avallata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 12 giugno 2023, n. 5753).
Ha anche ricordato che ai sensi della direttiva 2013/32, come interpretata dalla CGUE, qualora gli Stati membri limitino l'accesso ad informazioni o a fonti la cui divulgazione comprometterebbe, segnatamente, la sicurezza nazionale o la sicurezza delle fonti, essi devono non soltanto consentire l'accesso a tali informazioni o a tali fonti ai giudici competenti al fine di pronunciarsi sulla legittimità della decisione relativa alla protezione internazionale, ma anche istituire, nel loro ordinamento nazionale, delle procedure che garantiscano che i diritti della difesa della persona interessata vengano rispettati.
Poste queste premesse, il ricorrente deduce che apoditticamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l'Amministrazione avesse deciso di non svelare il contenuto della nota ministeriale ed ha ritenuto di poter decidere senza acquisirla.
Rimarca che non rientra nella disponibilità dell'Amministrazione la produzione della nota, attesa la circostanza decisiva che tale nota ha un contenuto segretato.
Sostiene che la nota aveva carattere indispensabile e che, ai fini della prova della pericolosità dell'interessato, il giudice avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al citato art. 42, unico procedimento che consente l'ostensione della comunicazione in oggetto.
Deduce che nel presente caso non potrebbe trovare applicazione l'orientamento consolidato di legittimità che individua il carattere discrezionale dell'ordine di esibizione di cui agli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., come tale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Deduce il ricorrente anche la violazione dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che impone il potere, e soprattutto il dovere, dell'autorità giurisdizionale di esperire poteri di accertamento ufficiosi al fine di vagliare la valutazione operata dall'Amministrazione e, correlativamente, la situazione del privato (Cass. civ., Sez. lav., ord. 21 settembre 2021, n. 25596).
Denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 116 c.p.c., laddove il Giudice ha desunto dal contegno processuale dell'Amministrazione - necessitato ai sensi della normativa in materia di tutela della segretezza dei documenti - prova della "non pericolosità" dell'odierno resistente.
Lamenta, infine, a causa della mancata procedura di ostensione della nota, anche un vizio motivazionale osservando che il decreto si pone in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE, sentenza del 22 settembre 2022, C-159/21), ai sensi della quale l'autorità accertante deve disporre di tutte le informazioni pertinenti, usandole per determinare la propria valutazione dei fatti e delle circostanze.
Lamenta, inoltre, che dalla mancata ostensione siano stati illegittimamente tratti indizi di prova contraria.
4.2. Il motivo è fondato e va accolto.
4.3. È opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.
La l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'art. 24 stabilisce la disciplina dell'esclusione del diritto di accesso e prevede che «1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo (...)», con la precisazione che «2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1» e che «5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso», infine è precisato che «7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (...)».
Il Ministero dell'interno con il d.m. 16 marzo 2022 ha dettato la "Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15" ed ha stabilito all'art. 2, comma 1, lett. m), che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lett. a), del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali [art. 2, lett. m)] «m) i documenti relativi ai procedimenti di riconoscimento, di revoca e di cessazione dello stato di protezione internazionale nonché di rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19 comma 1.2 e comma 2 lettera d)-bis e 22, comma 12-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali».
La l. 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) all'art. 42 definisce le "classifiche di segretezza" - segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato - attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali e prevede, al comma 8, che «8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia».
Ne consegue che in tutti i casi in cui non è opposto il segreto di Stato (artt. 39-41 della l. n. 124/2007), all'esito dell'ordine di esibizione gli atti vanno consegnati all'autorità giudiziaria che provvede nei termini indicati.
4.4. È principio cardine del nostro ordinamento che la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e concreta e che il diritto di azione non è suscettibile di limitazioni, né formali, né sostanziali, a meno che non siano volte ad attuare altri principi o interessi di rango costituzionale.
L'art. 42 della l. n. 124 del 2007, nel ridisciplinare l'attribuzione delle classifiche di segretezza, che sono volte a circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, non ha soppresso la disciplina dell'accesso difensivo, dettata dall'art. 24 della l. n. 241 del 1990, semmai l'ha presupposta ed integrata, attribuendo all'Autorità giudiziaria che dispone l'accesso un ruolo attivo, a garanzia del corretto equilibrio tra esigenze di riservatezza e legittime istanze difensive. In ogni caso, a meno che non sia apposto il segreto di Stato, l'Amministrazione non potrà opporre vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi, compreso l'oscuramento di parte dei documenti se non condivisa dal giudice, e dovrà attenersi alle prescrizioni di detta autorità giurisdizionale (cfr. C.d.S., parere della Sez. I, n. 2226 del 1° luglio 2014).
4.5. Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie il provvedimento di revoca impugnato si componeva in parte di una motivazione evocata per relationem alla nota del 17 gennaio 2024 del Dipartimento di pubblica sicurezza - Polizia di prevenzione, per la quale il ricorrente aveva avanzato già prima dell'avvio del giudizio istanza di accesso agli atti, respinta dal Ministero dell'interno con comunicazione del 31 maggio 2024 nella quale si dava atto che si trattava di documento classificato e della necessità di seguire la specifica procedura giudiziale di cui all'art. 42, comma 8, della l. n. 124 del 2007 per conseguire l'ostensione.
4.6. In proposito, va rammentato che il provvedimento amministrativo può essere motivato per relationem, con espresso rinvio ad un proprio precedente atto in quanto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, tale motivazione è legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, non incidendo siffatto modus operandi sull'essenza dell'operazione valutativa, la quale non ne risulta sminuita (Cass. n. 7273/2023), purché questo espliciti i presupposti di fatto e diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa; qualora, invece, il provvedimento richiamato sia, a sua volta, motivato per relationem, si verifica una doppia relatio, che, non consentendo alcun controllo sulle ragioni della decisione, equivale a motivazione omessa (Cass. n. 26051/2024). È stato affermato (in tema di sanzioni amministrative emesse dalla Consob) che il decreto che commina la sanzione può essere motivato per relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Cass. n. 10212/2024).
4.7. Alla luce di questi principi, va osservato che anche nel caso di un provvedimento di revoca dello status di rifugiato, come quello in esame, non sussistono ragioni ostative ad una motivazione per relationem, perché ciò che rileva è che, ai sensi dell'art. 46 della direttiva 2013/32/UE, il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. Ebbene, quando la motivazione per relationem intercetta un atto presupposto o un documento munito di classificazione di segretezza, l'esercizio del diritto di accesso deve avvenire mediante l'attivazione delle specifiche modalità predisposte dall'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007.
In effetti, nel caso in esame l'odierno controricorrente aveva chiesto sin dal primo grado di procedere all'ordine di esibizione del documento. La stessa Amministrazione, costituitasi, aveva dedotto la possibilità di ostensione del documento in sede giurisdizionale.
Va aggiunto, a confutazione delle osservazioni svolte dal controricorrente circa la effettiva classificazione di segretezza del documento, che lo stesso Tribunale ha accertato che la mancata produzione era «legittimamente fondata su ragioni di segretazione».
Come si è visto il Governo o l'Autorità competente possono prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, ove la loro conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali e nel caso in esame la ricorrenza della classificazione non è stata esclusa dal Tribunale.
In proposito va ricordato che la Corte costituzionale (v. Corte cost. 10 aprile 1998, n. 110), pur pronunciandosi in riferimento a distinta fattispecie ha affermato che «la sicurezza interna ed esterna dello Stato costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro» e «pertanto, nel caso in cui si tratti di agire per la salvaguardia dei supremi interessi dello Stato, può trovare legittimazione il segreto, quale strumento necessario per raggiungere il fine di quella sicurezza e per garantire l'esistenza, l'integrità e l'assetto democratico dello Stato, valori tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost.».
E tuttavia, va posto in evidenza, in quanto trattasi di previsione normativa che concorre alle garanzie del giusto processo, che l'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 prevede, al contempo, quale norma di chiusura, che debba essere comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
La richiamata disposizione si coniuga con le ulteriori prescrizioni nella specifica materia dettate dall'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007 che disciplina le modalità di esibizione dei documenti classificati, per i quali non sia stato opposto il segreto di Stato.
In particolare, la disposizione, da un lato, ribadisce il diritto di accesso ai fini della difesa in giudizio, dall'altro, ne circoscrive le modalità di esercizio, consentendo la sola visione dei documenti classificati a chi ne abbia interesse per motivi di difesa, senza che sia possibile estrarne copia.
Una lettura coordinata delle richiamate disposizioni induce a concludere nel senso che il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, costituendo il diritto alla tutela giurisdizionale uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale (così in motiv. C.d.S., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1849).
Ciò significa che le esigenze di riservatezza recedono, sia pure nei termini previsti, ove sussistano le esigenze processuali, mentre ove tali esigenze non siano manifestate mediante la procedura di accesso le esigenze di riservatezza prevalgono.
Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di collaborare lealmente con l'Autorità giudiziaria ai fini dell'acquisizione delle prove, sull'attendibilità delle quali l'organo giudicante è chiamato ad esprimersi, va ricordato che il contesto di cautela entro il quale l'acquisizione deve avvenire è chiaramente definito dall'art. 42, comma 8, della l. n. 124 del 2007, a tenore del quale le cautele devono essere disposte caso per caso dal magistrato, sentita l'Amministrazione, e svilupparsi con modalità diverse a seconda della situazione generale e del momento, senza tuttavia spingersi al punto di vanificare l'esercizio del diritto di agire in giudizio con interpretazioni elusive dei principi costituzionali e della legislazione nella specifica materia (C.d.S., Sez. I, 13 gennaio 2016, n. 1882).
È, dunque, nel solco di questi principi, punto di equilibrio di contrapposte e rilevanti esigenze, che va scrutinata la res iudicanda.
4.8. Orbene, muovendo da tale premessa, ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia viziata per plurime ragioni.
4.9. Invero, posto che il provvedimento impugnato non era privo di motivazione, ma motivato in parte per relationem alla nota già ricordata, il Tribunale, indiscussa la necessaria strumentalità della nota per la complessiva e compiuta conoscenza delle ragioni e dei fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca dello status di rifugiato, non poteva esimersi - come invece ha fatto - anche a garanzia del diritto al giusto processo dal richiedere all'Amministrazione competente di esibire la documentazione, perché, nell'ambito della disciplina che viene in rilievo, la tutela delle esigenze difensive della parte sono assicurate proprio dalla procedura di cui all'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007, che colloca la discovery in sede processuale ed onera il giudice anche del dovere di conservazione dei documenti con modalità che ne tutelino la riservatezza; questa è la disciplina che assicura l'assolvimento degli oneri motivazionali e probatori dell'Amministrazione e la conoscibilità dei documenti secretati, a meno che non sia opposto il segreto di Stato, e, a seguito dell'ostensione, il diritto di difesa può compiutamente dispiegarsi nel rispetto del contradditorio, così come il controllo giurisdizionale di proporzionalità che non si sovrappone alla valutazione discrezionale dell'autorità competente.
Pertanto, diversamente da quanto opina il Tribunale, non può giovare al ricorrente la scelta di non acquisire la documentazione secretata nella forma procedimentalizzata - come, peraltro, chiesto e rappresentato da entrambe le parti ed a cui il Collegio giudicante avrebbe potuto procedere anche d'ufficio nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2013/32/UE, in ragione del dovere di cooperazione istruttoria che connota la specifica materia della protezione internazionale -, perché le esigenze di riservatezza poste a tutela della sicurezza dello Stato rimangono intatte e sono accompagnate da una presunzione relativa destinata a prevalere ove non sia esercitato il diritto di accesso perché «in presenza di informative con classifica di "riservato" il richiamo per relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e le garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza» (C.d.S., sent. 12 giugno 2023, n. 5753): ne consegue che la decisione di non attivare la procedura di ostensione non priva il provvedimento impugnato della complessiva motivazione anche per relationem, come invece ritenuto dal Tribunale, ma è piuttosto destinata a riverberarsi negativamente sulle concrete possibilità di valutazione in sede giurisdizionale e di difesa delle parti.
4.10. Va, pertanto, affermato che «In materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato per relationem ad un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la "classifica di segretezza", la conoscibilità di quest'ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l'esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007, che persegue la finalità di bilanciare le esigenze di sicurezza e le garanzie difensive del giusto processo in sede giurisdizionale; la omessa attivazione del procedimento di ostensione ex art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007 non è idonea, né sufficiente ad inficiare la motivazione per relationem».
Nel caso in esame, pertanto il Tribunale ha errato a non dare corso all'istanza di esibizione e a ritenere che la nota in questione, in tal modo, fosse deprivata di valore giuridico; la decisione va cassata e in sede di riesame il Tribunale dovrà procedere ai sensi dell'art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007, con le cautele necessarie previste dal legislatore, consentendo il dispiegarsi delle difese nel contraddittorio delle parti in applicazione del principio enunciato.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il decreto gravato per aver violato e/o falsamente applicato l'art. 14 della direttiva 2011/95, nonché gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 251/2007.
A parere del ricorrente, il Tribunale ha errato perché ha subordinato la legittimità della revoca dello status di rifugiato disposta ai sensi dell'art. 14, par. 4, lett. a), della direttiva 2011/95 alla sussistenza di un «livello di concretezza del rischio di passaggio all'azione "offensiva", che solo può assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare - sia pur preventivamente - la revoca dei benefici concessigli con lo status di rifugiato».
Nel fare ciò, il Tribunale avrebbe applicato, erroneamente, il parametro di valutazione previsto per la (diversa) fattispecie di cui all'art. 14, par. 4, lett. b), della citata direttiva, consistente nell'"accertamento di un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società" (CGUE, C-159/21, 22 settembre 2022), al diverso accertamento richiesto dalla lett. a) dell'art. 14 cit., che si accontenta di uno standard, per così dire, "più attenuato" atteso la rilevanza degli interessi in gioco.
Sostiene il ricorrente che la rilevanza degli interessi protetti dalla disposizione di cui si tratta non può che determinare, quindi, un arretramento della soglia richiesta ai fini della legittimità della revoca dello status di rifugiato, escludendo, pertanto, la necessità di "concreti" indici e ritenendo, al contrario, sufficiente una valutazione, necessariamente preventiva, di periculum, come correttamente ritenuto dall'Amministrazione in epigrafe, con conseguente rilevanza anche di condotte - o, in questo caso, di messaggi - "dal contenuto oggettivamente minaccioso, violento e vendicativo" (cfr. pag. 8 del decreto gravato).
5.2. Sul piano normativo va rammentato che:
- l'art. 14 della direttiva 2011/95/UE, prevede:
al par. 3, «Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:
a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato»;
al par. 4, «Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:
a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro».
Questa normativa è stata trasposta a livello interno dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. 251/2007, che riproducono le fattispecie eurounitarie, di guisa che la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia costituisce indiscusso canone esegetico.
L'art. 12 stabilisce che «1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».
L'art. 13 stabilisce che «1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che: a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12; b) il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti».
5.3. Il motivo è fondato e va accolto.
Va evidenziato che la Corte di giustizia ha già avuto modo di affermare che due sono le tipologie di pericolo che l'autorità accertante, prima, e il giudice, dopo, devono vagliare al fine di procedere alla revoca dello status di rifugiato e che «da un confronto tra queste due disposizioni emerge che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva [direttiva 2011/95/UE] fa riferimento a un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo, mentre l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di quest'ultima riguarda un pericolo per la comunità di tale Stato membro. Pertanto, queste due disposizioni si riferiscono a due diversi tipi di pericolo» (cfr. CGUE, sent. del 6 luglio 2023, nella causa C-8/22).
5.4. Nel caso in esame la revoca è stata disposta in relazione alla fattispecie rientrante nella previsione di cui all'art. 14, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2011/95/UE, che trova corrispondenza nella previsione nazionale di cui al combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251/2007, e che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se vi sono fondati e ragionevoli motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova.
5.5. Ulteriore giurisprudenza europea ha esaminato la questione dell'interpretazione della nozione di pericolo per la sicurezza nazionale e ordine pubblico nel contesto del diritto d'asilo.
Sul punto è stato evidenziato che: "i motivi (...) per considerare il richiedente protezione internazionale come un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico nel territorio dello stato membro (...) devono essere ragionevoli e non gravi e non si riferiscono necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave non politico commesso al di fuori del paese di rifugio prima che l'interessato fosse ammesso come rifugiato, ma richiedono solo la prova di un pericolo per la sicurezza nazionale o per la sicurezza o ordine pubblico, lasciano chiaramente agli Stati membri un margine di discrezionalità più ampio rispetto ai gravi motivi per applicare le disposizioni di esclusione contenute negli artt. 12 e 17 della direttiva 2011/95" (CGUE, sent. del 22 [settembre] 2022, in causa C-159/21).
5.6. La CGUE, con la recente sentenza del 27 febbraio 2025 in causa C-454/23, ha preso in esame il rischio di pregiudizio alla sicurezza interna o esterna dello Stato membro e ha ribadito la differenza tra le due fattispecie affermando «49 - Più precisamente, la nozione di "sicurezza dello Stato membro in cui si trova [il rifugiato]", di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, corrisponde a quella di "sicurezza nazionale", di cui all'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. A tal riguardo, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo la quale la nozione di "pubblica sicurezza" ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2014, L 305, pag. 116), comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché alla sopravvivenza della popolazione, così come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, punto 78 e giurisprudenza ivi citata)».
La CGUE, sempre nella sentenza del 27 febbraio 2025 in causa C-454/23, ha quindi aggiunto «52 - Inoltre, il fatto che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 faccia riferimento a "fondati motivi per ritenere che" il richiedente protezione internazionale costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione, mentre l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di quest'ultima riguarda il caso in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, tale richiedente "costituisce" un pericolo per la comunità di tale Stato membro, tende a indicare che la prima di tali disposizioni può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C-715/17, C-718/17 e C-719/17, EU:C:2020:257, punto 157 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C-8/22, EU:C:2023:542, punti 52 e 53]» con la successiva precisazione che l'autorità competente deve procedere alla valutazione delle circostanze specifiche per ciascun caso e che «54 - Risulta infatti dai termini di tali disposizioni che detta autorità deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest'ultimo, ciò che esclude che la constatazione dell'esistenza di un pericolo per tale sicurezza implichi automaticamente tale decisione».
5.7. In linea con la giurisprudenza eurounitaria va, quindi affermato che «Il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251/2007, che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se "sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato" tende a indicare che tale disposizione può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest'ultimo; spetta al giudice del procedimento di impugnazione ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, senza sovrapporsi alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità competente, il controllo, nel contraddittorio tra le parti che connota il giusto processo, di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bene della sicurezza dello Stato e del diritto soggettivo allo status di rifugiato».
Nel caso in esame, il Tribunale non si è attenuto a questi principi perché il controllo di proporzionalità e adeguatezza è stata centrata sulla concretezza del rischio (fol. 9 del decr. imp.), che non è stata ravvisata; tale valutazione non risulta, quindi, conforme al parametro normativo ed alla giurisprudenza eurounitaria maturata sul punto che attesta la nozione di pericolo rilevante, nella fattispecie legale, nel più ampio spettro della sussistenza di "fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato".
L'applicazione del criterio di giudizio prescelto dal Tribunale - ossia la necessaria sussistenza di un livello di concretezza del rischio di passaggio all'azione offensiva, che solo potrebbe assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare la revoca dei benefici che si ricollegano allo status di rifugiato - finisce irragionevolmente con il delimitare la possibilità di revoca ai soli casi in cui la condotta si sia estrinsecata sul piano fenomenico, così escludendo ogni rilevanza a comportamenti ex ante idonei ad attentare al bene superindividuale della sicurezza nazionale.
6. In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
- accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese di giudizio del presente grado;
- dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.