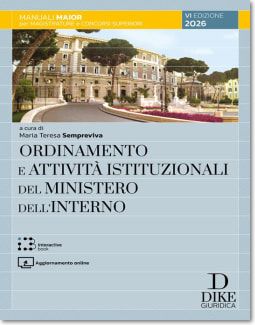Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 18 agosto 2025, n. 668
Presidente: de Francisco - Estensore: Francola
FATTO
Durante l'esecuzione di un appalto di lavori commissionato dal Comune di Montelepre per il recupero dei locali di pertinenza della Chiesa parrocchiale "Gesù, Maria e Giuseppe" sita nel territorio di Montelepre lungo la S.P. stazione Zucco-Bivio Giardinello e di proprietà della Curia arcivescovile, la Edilfond s.r.l. ha danneggiato la Chiesa intaccandone gli intonaci e gli apparati decorativi in stucco interni e, per siffatta ragione, è stata destinataria della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei suoi confronti dal Soprintendente ai BB.CC.AA. di Palermo nella misura di euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Edilfond s.r.l. impugnava il predetto provvedimento, domandandone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 2947 c.c. e dell'art. 28 l. n. 689/1981 per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti al 1997;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 160 d.lgs. n. 42/2004;
3) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990;
4) violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.
L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 2040/2022 pubblicata il 23 giugno 2022, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione resistente poiché:
1) l'obbligazione di cui all'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 non avrebbe carattere afflittivo o punitivo ma ripristinatorio e, quindi, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della l. n. 689/1981. Inoltre, non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 2947 c.c. in quanto concernente la prescrizione dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito e non l'esercizio di un potere pubblico;
2) la disciplina contemplata dall'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 sarebbe applicabile ad un abuso commesso nel 1997 in ragione della natura permanente del danno perpetrato ai beni culturali e, comunque, la disciplina previgente contemplava previsioni analoghe (in tal senso art. 59, commi 3 e 4, l. n. 1089/1939 ed art. 131 d.lgs. n. 490/1999) già applicabili al tempo dell'accaduto;
3) nessun difetto di istruttoria e di motivazione sarebbe evincibile dagli atti impugnati. Inoltre, la società ricorrente non avrebbe dedotto alcuna specifica censura, né in sede procedimentale, né con il proposto ricorso, in ordine alla misura dell'obbligazione pecuniaria controversa. Anche l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non può legittimare l'annullamento dell'impugnato provvedimento poiché la censura sarebbe meramente formale non essendo stato avviato nell'ambito del procedimento l'eventuale fase di arbitraggio per contestare la misura dell'obbligazione pecuniaria pretesa dall'Amministrazione resistente. Con riguardo, poi, all'omessa indicazione dei termini di impugnazione e dell'autorità giudiziaria da adire, si tratta di un profilo rilevante al più a giustificare l'ammissibilità di un ricorso tardivo, ma non l'annullamento del provvedimento impugnato;
4) la violazione dei termini di conclusione del procedimento non può costituire causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, considerato che il termine previsto per l'irrogazione dell'obbligazione pecuniaria in questione non sarebbe perentorio.
Con l'appello notificato il 20 gennaio 2023 e depositato il 9 febbraio 2023 la Edilfond s.r.l. domandava la riforma della predetta sentenza in ragione dell'asserita fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso di primo grado che venivano in questa sede integralmente riproposti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.
L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana si opponeva all'accoglimento dell'appello.
L'appellante replicava alle difese avversarie con una memoria conclusiva.
All'udienza pubblica del 20 febbraio 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti presenti, tratteneva l'appello in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve, preliminarmente, esaminare il motivo d'appello con il quale si lamenta l'erroneità della decisione assunta dal T.A.R. con riguardo alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per maturata prescrizione quinquennale dell'illecito sanzionato.
Secondo l'appellante, infatti, la pretesa economica vantata dall'Amministrazione sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981 poiché oggetto di un provvedimento sanzionatorio, o, in subordine, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto preordinata ad ottenere il risarcimento per equivalente del danno patito.
Per una corretta qualificazione giuridica del provvedimento impugnato occorre procedere all'esame della norma attributiva del potere nell'occasione esercitato, ossia l'art. 160 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui:
"1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato".
Come è agevole evincere dalla lettura del riportato dato normativo, il legislatore ha introdotto un rimedio di tipo non punitivo-afflittivo, ma risarcitorio, essendo lo scopo perseguito il ripristino non tanto della legalità violata quanto e soprattutto del patrimonio culturale danneggiato.
Centrale rilevanza assume, infatti, il danno patito dal bene culturale e non la condotta illecita del danneggiante, non essendo rilevanti tutte le caratteristiche tipiche delle sanzioni, quali l'elemento soggettivo (ossia il dolo o la colpa), l'intrasmissibilità agli eredi della sanzione e i criteri di quantificazione delle sanzioni, come la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Nonostante, dunque, l'art. 160 sia inserito nel titolo I del d.lgs. n. 42/2004 dedicato alle "Sanzioni amministrative", il concetto di "reintegrazione" più volte evocato dalla norma induce il Collegio a ritenere il rimedio ivi previsto privo dei connotati tipici degli istituti sanzionatori, costituendo, invece, uno strumento unicamente preordinato ad assicurare il risarcimento del danno patito dall'Amministrazione mediante la reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino dello status quo ante alla commissione dell'illecito amministrativo, ovvero il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del depauperamento arrecato al bene culturale danneggiato.
Il che esclude l'applicabilità della l. n. 689/1981 e, quindi, del relativo art. 28, che prevede la prescrizione quinquennale per le sanzioni, ma non anche della disciplina di cui all'art. 2947 c.c., tenuto conto della rilevanza civilistica del nocumento cagionato al patrimonio culturale quale illecito aquiliano in danno dell'Amministrazione.
L'art. 160 d.lgs. n. 42/2004, infatti, contempla una speciale disciplina di risarcimento del danno giustificata dalla peculiare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti dai beni culturali.
Al riguardo occorre precisare che le esigenze di salvaguardia degli interessi della collettività soddisfatti dai beni pubblici, in generale, hanno indotto il legislatore ad attribuire all'Amministrazione speciali poteri di autotutela esecutiva, onde garantire la tempestiva salvaguardia sia dei beni che dei relativi interessi pubblici senza dover attendere l'ordinaria tempistica caratterizzante l'esperimento dei rimedi giurisdizionali all'uopo previsti.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che «l'art. 823 co. 2 c.c. soddisfa un'esigenza di tutela non connessa al possesso, né alla mera proprietà pubblica, ma dipendente dagli interessi pubblici che il bene può soddisfare» (C.d.S., Sez. VII, 19 maggio 2023, n. 4987).
Con riguardo al caso in esame, l'art. 160 d.lgs. n. 42/2004 ha attribuito all'Amministrazione un potere propriamente di autotutela esecutiva sul piano risarcitorio, in quanto preordinato a conseguire la reintegrazione in forma specifica o il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del nocumento patito senza dover adire alcun giudice.
La specialità della disciplina in esame rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c. si coglie in relazione a diversi profili, quali in particolare: a) la condotta lesiva, dovendo necessariamente scaturire dalla violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni della parte seconda, titolo I, capo III, del d.lgs. n. 42/2004; b) l'elemento soggettivo del danneggiante, non essendo rilevante né la sua assenza quale possibile causa esimente di responsabilità, né la sua intensità con riguardo alla dosimetria dell'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004; c) il rapporto tra la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento per equivalente, essendo la prima sempre obbligatoria (e quindi non rimessa a una valutazione discrezionale dell'Amministrazione danneggiata), salvo il solo limite dell'impossibilità (ma non anche quello dell'eccessiva onerosità per il danneggiante com'è, invece, contemplato dall'art. 2058 c.c.).
Trattandosi, dunque, di un rimedio previsto a fronte di una fattispecie di responsabilità oggettiva per il danneggiante, l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 ha chiaramente natura risarcitoria ed è, quindi, soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
Il che impone un'attenta qualificazione del danno arrecato dall'appellante all'Amministrazione quale illecito permanente o quale illecito istantaneo ad effetti permanenti, essendo la differenza rilevante per il decorso della prescrizione.
Valutazione del tutto analoga, in ogni caso, sarebbe stata necessaria anche qualora si fosse trattato di un provvedimento sanzionatorio, pur se al diverso fine di verificare (la sussistenza de-) il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa punitiva dell'amministrazione ai sensi del cit. art. 28 della l. n. 689 del 1981, con la precisazione che si sarebbe, comunque, giunti alla medesima conclusione.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso d'illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa» (Cass., 24 agosto 2007, n. 17985; Cass., 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. civ., Sez. III, ord. 8 febbraio 2024, n. 3571).
Trattasi di un orientamento ormai consolidato secondo cui i criteri distintivi della dicotomia illecito permanente/illecito istantaneo con effetti permanenti devono delinearsi nel senso che è «permanente l'illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell'attività lesiva del soggetto agente, mentre l'illecito è istantaneo allorché la condotta lesiva si esaurisce in un fatto quod unico actu perfecitur, ovvero in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti» (cfr. Cass. n. 9711/2013; Cass., Sez. VI, ord. n. 24146/2014; Cass. civ., Sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Con riguardo al caso in esame, l'illecito commesso dall'appellante non ha natura permanente poiché il danno arrecato al patrimonio culturale, mediante la distruzione degli intonaci e degli apparati decorativi in stucco interni alla Chiesa, è scaturito da una condotta istantanea, del tutto analogamente al caso del danno provocato da un sinistro stradale, protraendosi nel tempo soltanto i suoi effetti ma non anche l'evento dannoso e l'illecito commesso dal danneggiante.
Al riguardo, occorre precisare che la violazione della disciplina prevista a tutela dei beni paesaggistici spesso scaturisce da una non consentita attività edificatoria che, in quanto abusiva, è sottoposta al generale potere repressivo di cui al d.P.R. n. 380/2001 per il quale, com'è noto, non assume rilevanza il decorso del tempo.
L'Adunanza plenaria n. 7/2019 ha chiarito che «non sarebbe in alcun modo concepibile l'idea stessa di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta - e inammissibile - forma di sanatoria automatica o praeter legem.
5.2. Una chiara conferma di quanto appena rappresentato si desume dal terzo periodo del comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 [per come introdotto dal comma 1, lett. q-bis), dell'art. 17 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133], secondo cui "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".
La disposizione appena richiamata chiarisce che il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l'amministrazione del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche - e diverse - conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo».
Il che potrebbe indurre a ritenere estensibile il medesimo principio di diritto con riguardo alla tutela dei beni culturali.
Sennonché, a prescindere dalla condivisione o meno di siffatta tesi, non possono, comunque, ritenersi sussistenti i presupposti per affermare la perduranza dei poteri previsti a tutela dei beni culturali in generale allorché il fatto lesivo, come nella circostanza in esame, non sia costituito dalla realizzazione di un manufatto abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ma soltanto dalla non corretta esecuzione di lavori autorizzati, poiché è diversa nei due casi la posizione dell'Amministrazione.
Se, infatti, con riguardo all'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 l'interesse tutelato è il ripristino della legalità violata e, quindi, si esclude l'attitudine del decorso del tempo a consumare il potere repressivo del Comune per salvaguardare il preminente interesse pubblico al pieno ed effettivo controllo del territorio, l'art. 160 d.lgs. n. 42/2004 tende a garantire, invece, l'integrità del patrimonio culturale quale bene in sé considerato e rispetto al quale l'Amministrazione agisce nella qualità di ente esponenziale preposto alla sua tutela e non soltanto al suo controllo.
Il che onera l'Amministrazione ad agire entro un termine ben preciso, al pari dei proprietari che intendano tutelare il proprio patrimonio, decorso il quale il diritto (patrimoniale) si estingue per prescrizione.
Donde, la necessità di attivare i rimedi risarcitori previsti dall'art. 160 d.lgs. n. 42/2004 entro il termine di prescrizione (quinquennale) previsto dall'art. 2947 c.c. per gli illeciti extracontrattuali, decorrente dal momento in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza del danno.
Nel caso in esame, dei danni arrecati dall'appellante agli intonaci decorativi interni la Soprintendenza era a conoscenza sin dal 18 marzo 1997, allorché la direzione lavori ha reso noto l'evento con apposita comunicazione ed è, quindi, da siffatto momento che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per ordinare la reintegrazione o per domandare il pagamento della somma pretesa a titolo di risarcimento per equivalente.
Poiché il danno arrecato alla Chiesa è qualificabile come illecito istantaneo ad effetti permanenti e non quale illecito permanente, il provvedimento di cui alla nota n. 3073/VII del 20 aprile 2011 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro 15.000,00, è illegittimo per maturata prescrizione, non essendo stato adottati nelle more atti interruttivi del termine prescrizionale.
E, invero, il primo atto successivo all'evento dannoso del 1997 è stato adottato dalla Soprintendenza solo con la nota assunta al prot. 1542/A del 4 maggio 2005 (successivo, comunque, di oltre un quinquennio all'evento dannoso), con la quale si prospettava l'opportunità di un incontro con i progettisti per la definizione della pratica, ma non anche la necessità di provvedere al ripristino delle parti della Chiesa danneggiate o, in alternativa, il pagamento della somma pretesa a titolo di risarcimento danni.
Come noto, la prescrizione può essere interrotta, secondo quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore" e che, quindi, manifesti la volontà di ottenere, nella circostanza, il risarcimento del danno patito. Mentre l'unico atto con il quale siffatta volontà è stata formalmente manifestata dall'Amministrazione nella circostanza è soltanto quello qui impugnato, che è stato emanato nel 2011.
Pertanto, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., estintiva della pretesa risarcitoria in questa sede attivata dall'Amministrazione.
L'accoglimento del motivo esaminato esonera il Collegio dalla necessità di procedere all'esame degli ulteriori motivi, in ragione del suo carattere tanto assorbente di ogni altra questione, quanto interamente satisfattivo dell'interesse per la cui tutela l'appellante ha agito in giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività difensiva espletata dall'appellante, vanno liquidate in suo favore e a carico dell'Amministrazione regionale appellata nella misura di euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., come per legge, per il doppio grado di giudizio, con rifusione dei c.u. versati.
Dichiara irripetibili le spese processuali del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ed il Comune di Montelepre.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione regionale appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con rifusione dei c.u. versati.
Dichiara irripetibili le spese processuali del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ed il Comune di Montelepre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 2040/2022.