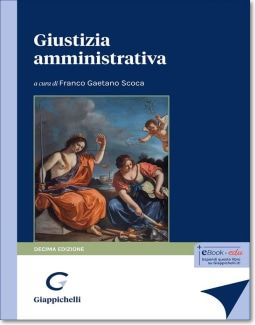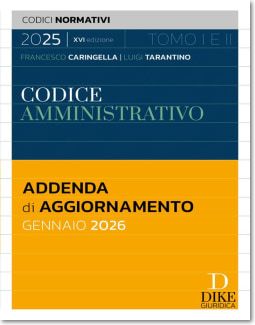Corte costituzionale
Sentenza 28 luglio 2025, n. 137
Presidente: Amoroso - Redattore: Antonini
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 3 e 4 (recte: commi quarto e quinto), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, nel procedimento vertente tra I. C. e Agenzia delle entrate con ordinanza dell'8 luglio 2024, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza dell'8 luglio 2024, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28 (di seguito: CGT di Roma), ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, della Costituzione, e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 3 e 4 (recte: commi quarto e quinto), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso.
2.- La rimettente espone di dovere decidere sul ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria aveva contestato a I. C. di avere conseguito, nell'anno d'imposta 2015, ai sensi degli artt. 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), una plusvalenza di euro 39.853,00, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto di terreni edificabili, di cui ai contratti del 5 agosto 1997 e del 30 dicembre 1981, e quello di vendita del 28 aprile 2015 dei medesimi beni.
Specifica che, prima di emettere l'atto impositivo, l'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, un invito con il quale le aveva richiesto di documentare le eventuali spese sostenute che potessero giustificare l'incremento dei valori dei terreni edificabili e che, non avendo ricevuto la relativa documentazione, aveva «determinato la plusvalenza recuperata in funzione della sola differenza tra i prezzi di vendita e di acquisto».
La CGT di Roma pone in evidenza che, nel giudizio a quo, la ricorrente aveva prodotto le fatture con le quali intendeva fornire la prova del fatto che l'aumento di valore dei terreni edificabili era conseguente a spese incrementative da essa sostenute, ma l'Agenzia delle entrate, nell'atto di costituzione, aveva eccepito, ai sensi «dell'art. 32, comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti prodotti, atteso che, nonostante l'invito rivolto alla contribuente in sede di controllo, la documentazione non era stata esibita o trasmessa e non vi era prova di un impedimento oggettivo e incolpevole che giustificasse la mancata consegna.
3.- In punto di rilevanza, la CGT di Roma afferma che, in considerazione della previsione di cui «all'art. 32, co. 3 [recte: quarto comma], d.P.R. 600 del 1973», sarebbe tenuta a dichiarare non utilizzabile la documentazione prodotta dalla contribuente e comprovante le spese incrementative sostenute.
Ritiene peraltro che non sarebbe applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'«art. 32, co. 4 [recte: quinto comma], del d.P.R. n. 600 del 1973 [che] permette la non applicazione della misura processuale afflittiva al verificarsi di una causa esimente specifica che abbia impedito al contribuente di adempiere all'onere della presentazione sin dalla fase amministrativa, purché tale causa sia a lui non imputabile».
Ciò in quanto «dalla narrazione dei fatti e dalla prospettazione di parte si evince con chiarezza come l'inadempimento sia stato causato da leggerezza, da grande confusione e da un comportamento contrario alla ordinaria diligenza e alla buona fede, assertivamente ricondotto all'Ufficio, ma in realtà addebitabile al figlio delegato. Infatti, molti sarebbero stati, gli strumenti per sottoporre comunque alla attenzione dell'ufficio la documentazione, al limite anche mediante l'utilizzazione dei tradizionali canali postali cartacei».
3.1.- La rimettente esclude che la disposizione censurata possa prestarsi a un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di ritenere che il mancato deposito della documentazione costituisca una mera irregolarità superabile a seguito di una valutazione discrezionale del giudice, attesa la «totale incontrovertibilità della lettera della norma».
Ritiene, inoltre, di non potere disapplicare la disposizione censurata per contrasto con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in quanto il considerato n. 11 della direttiva consentirebbe la sua applicazione solo per la materia del processo penale e quindi «non cont[errebbe] alcuna norma che vieti una restrizione nei mezzi di prova nell'ambito del processo tributario».
4.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che l'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 sia in contrasto con gli strumenti pattizi internazionali che riconoscono come diritto fondamentale e inviolabile quello al «processo equo e giusto», e specificamente l'art. 6 CEDU, gli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, gli artt. 47 e 48 CDFUE, e l'art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP.
Pertanto, la violazione di queste norme pattizie obbligatorie «[costituirebbe] per sé violazione degli obblighi costituzionali di conformarsi al diritto pattizio previsti dagli art. 10 e 117 [primo comma, Cost.]».
Inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25 e 111, primo comma, Cost.
5.- Il giudice a quo pone in rilievo che gli strumenti pattizi internazionali evocati assicurerebbero «un ampio sistema di protezioni di specifiche situazioni giuridiche soggettive, operante in tutti i campi del diritto, ivi compreso quello propriamente processuale che qui ci interessa, che possono essere sussunte sincreticamente nella indefettibilità di garantire a tutti un "giusto processo", obbiettivo finale degli istrumenti pattizi internazionali vigenti».
5.1.- Rivolge particolare attenzione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, che prevede che il diritto a un equo processo trova applicazione per «le controversie sui [..] diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
Nel valutarne la portata applicativa al caso di specie, si mostra consapevole del fatto che questa disposizione è stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel senso che non potrebbe trovare applicazione nel procedimento tributario (si citano le sentenze 12 luglio 2001, grande camera, Ferrazzini contro Italia, e 9 dicembre 1994, Schouten e Meldrun contro Paesi Bassi). Tuttavia, secondo il rimettente, la non applicabilità del citato articolo alla materia tributaria sarebbe stata superata dalla successiva giurisprudenza della Corte EDU elaborata in materia di «sanzioni europenali» anche con riferimento a quelle tributarie.
5.2.- A tal proposito, il giudice a quo richiama la giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato «la equiparazione tra le norme penali vere e proprie e fattispecie normative caratterizzate dalla presenza di tre c.d. Engel-criteria: [i] il carattere afflittivo, [ii] la finalità di deterrenza, [iii] l'applicabilità alla generalità dei cittadini».
5.2.1.- Evidenzia quindi che la Corte EDU «ha modificato in parte la sua opinione», avendo riconosciuto (con la sentenza Ferrazzini) che «anche le sanzioni tributarie, ove sussista anche uno solo degli Engel criteria [...], appartengono alla categoria delle sanzioni europenali» e che anche per il processo tributario, quando ha a oggetto la legittimità di una sanzione che in concreto non assolve ad una funzione compensativa del danno prodotto, ma assume una valenza punitiva, oltre che deterrente, dovrebbero essere rispettate le garanzie dell'art. 6 CEDU (si cita la sentenza 23 novembre 2006, grande camera, Jussila contro Finlandia).
Seguendo le coordinate tracciate dalla giurisprudenza della Corte EDU, la disposizione censurata sarebbe riconducibile alla categoria delle «sanzioni europenali», perché alla mancata esibizione dei documenti richiesti dall'amministrazione finanziaria «segue una limitazione della facoltà probatoria, cioè a dire una compressione del diritto di difesa con finalità afflittive [...] impedendo de facto secondo la prospettazione del ricorso la determinazione di una minore capacità contributiva e quindi un minor carico fiscale».
6.- La CGT di Roma esamina, quindi, alla luce delle disposizioni pattizie e di quelle costituzionali, le garanzie che devono sempre essere riconosciute quando l'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione comporti l'irrogazione nei confronti della persona di misure sanzionatorie sostanzialmente punitive.
6.1.- Sarebbero violati, in primo luogo, il diritto all'azione e il diritto di adire il giudice naturale, che troverebbero riconoscimento, oltre che nell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, anche nell'art. 6 CEDU, nell'art. 47 CDFUE, nell'art. 14 PIDCP, oltre che negli artt. 24 e 25 Cost. e che si esplicherebbero, sotto il profilo oggettivo, nel diritto di portare la pretesa dinanzi ad un giudice e, sotto il profilo soggettivo, nella necessità che la decisione sia assunta da un giudice imparziale, indipendente e precostituito.
Secondo il giudice a quo, limitare l'accesso al giudice dei contenuti, anche probatori, della pretesa, corrisponderebbe a negare l'azione e, quindi, la conseguente possibilità di tutela, elidendo in radice il rapporto con la giurisdizione.
6.2.- Sarebbe poi leso il diritto alla pubblica udienza, riconosciuto dalle medesime norme nonché dall'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 25 Cost.
Questo diritto non avrebbe solo natura formale, in quanto non si esaurirebbe nella celebrazione pubblica del processo, ma si porrebbe anche a tutela dell'esigenza della «massima trasparenza della procedura» e, pertanto, la limitazione dei mezzi di prova prevista dalla disposizione censurata impedirebbe «il controllo sociale su una parte del giudizio».
6.3.- Sarebbe anche violato il diritto alla difesa, previsto dall'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dall'art. 6 CEDU, dall'art. 14 PIDCP, dagli artt. 47 e 48 CDFUE, nonché dall'art. 24, secondo comma, Cost.
Infatti, nell'ambito del diritto alla difesa dovrebbe essere ricondotto anche il «diritto ad addurre prove a discarico», che sarebbe compresso dalla disposizione censurata, in quanto non consentirebbe al contribuente di potere efficacemente far valere la propria prospettazione in giudizio e, quindi, di tutelare la sua posizione giuridica soggettiva. Sotto tale profilo, «il divieto di utilizzare i documenti [...] di cui all'art. 32 vuol dire il rifiuto di delibare la prospettazione e quindi necessariamente concludere a priori per la sua inesistenza giuridica, perché non provata».
6.4.- Secondo la CGT di Roma, inoltre, dal diritto alla difesa deriverebbero, ulteriori «diritti-corollari», quali: «il diritto alla parità delle armi, cioè a una posizione di uguaglianza con la controparte pubblica o privata, ad una difesa equa su un piano di parità con la controparte, alla scelta dei mezzi di difesa e quindi anche al diritto al silenzio».
6.5.- La violazione del diritto al silenzio si porrebbe in contrasto con l'art. 6 CEDU nonché con l'art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP che espressamente riconosce il diritto a non deporre contro se stesso e a non confessarsi colpevole, nonché con gli artt. 24 e 111, Cost.
Secondo la CGT di Roma, il diritto al silenzio, seppure ispirato dal giudizio penale, assurgerebbe a principio generale, in quanto il diritto alla difesa comprenderebbe in sé il diritto di non difendersi sotto costrizione, consentendo a ciascuno di modulare e disciplinare la propria strategia difensiva a tutela di qualunque posizione giuridica soggettiva, anche non penale, senza che da esso possa derivare un aggravamento della sua posizione processuale.
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con questo diritto, in quanto porrebbe il contribuente dinanzi a una non giustificata alternativa tra la rinuncia alla strategia difensiva che ritiene per sé più vantaggiosa e la perdita irreparabile di strumenti difensivi.
6.6.- Il giudice a quo aggiunge che, se è vero che il legislatore può disciplinare il processo in conformità alle esigenze dei singoli procedimenti e che, inoltre, il regime delle decadenze processuali ha lo scopo di rendere il processo ordinato e celere, tuttavia, la preclusione configurata dalla disposizione censurata «non sembra avere una funzione ordinatrice e acceleratoria del processo. Non incide sui tempi ed ha come unica conseguenza quella di punire il contribuente per non avere dimostrato una volontà di collaborazione contro se medesimo».
7.- Nella parte conclusiva della motivazione il giudice a quo afferma che «[i]l dubbio di costituzionalità e la conseguente questione che in questa sede si solleva, riguarda altresì il [quinto comma] del medesimo articolo 32 [...]» che dispone che l'inutilizzabilità della documentazione non opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Ritiene che la «norma, infatti, costituisce eccezione alla disposizione del comma [quarto] e come tale conferma la vigenza e applicabilità della norma generale contenuta nel comma 3, di cui deve quindi seguire le sorti».
8.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
8.1.- Osserva la difesa statale che il giudice rimettente avrebbe solo genericamente affermato che alla ricorrente sarebbe stata preclusa la possibilità di produrre in giudizio i documenti che le erano stati richiesti, in quanto «dalla stessa ordinanza risulta la non veridicità del rilievo che [la] contribuente non abbia richiesto l'accertamento della non imputabilità del fatto». Pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto procedere alla verifica della eventuale non imputabilità della mancata produzione dei documenti richiesti, tenuto conto del fatto che la richiesta era stata effettuata a ridosso «dello scatenarsi dell'emergenza pandemica» e ciò avrebbe dovuto essere considerato, «se non una prova diretta dell'esistenza di una causa di forza maggiore, quantomeno un elemento indiziario che il giudice a quo avrebbe dovuto ponderare nel valutare la non imputabilità alla contribuente del comportamento omissivo».
Inoltre, secondo la difesa statale, l'inammissibilità deriverebbe anche dalla circostanza che il giudice rimettente avrebbe omesso di verificare se l'invito a produrre la documentazione era stato prodotto in giudizio e se l'amministrazione finanziaria avesse assolto all'onere di provare quei presupposti che, secondo il diritto vivente della giurisprudenza della Corte di legittimità, sarebbero necessari affinché possa trovare applicazione la preclusione prevista dalla disposizione censurata.
8.2.- La difesa statale aggiunge che tale «omissione determina anche l'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, quantomeno nella parte in cui investe la violazione del diritto di azione e la compressione del diritto alla difesa».
9.- Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.
Secondo l'Avvocatura le disposizioni censurate si inserirebbero in un quadro normativo volto al rafforzamento del dialogo tra fisco e contribuente e sarebbero finalizzate a deflazionare il contenzioso tributario promuovendo tale confronto nella fase antecedente all'emanazione dell'atto impositivo. A questa finalità si aggiungerebbe anche quella di limitare la possibilità della prova quando sia lo stesso contribuente a sottrarsi a tale onere, poiché questo comportamento consentirebbe di dubitare della genuinità del documento che sia emerso solo in sede giudiziale.
Non potrebbe quindi ritenersi che l'inutilizzabilità della documentazione non esibita in fase di accertamento comporti la violazione dei diritti di azione, di difesa e alla prova nonché alla parità delle armi, perché la disposizione censurata troverebbe la sua radice nel peculiare rapporto tra l'amministrazione finanziaria, che deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità della propria azione, ai sensi dell'art. 97 Cost., e il contribuente, che è tenuto all'assolvimento degli obblighi di solidarietà economico-sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 53 Cost.
Peraltro, il rigore della preclusione probatoria sarebbe mitigato dalla disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 32, che consentirebbe al contribuente di dimostrare, anche in via presuntiva, che l'omessa consegna della documentazione richiesta sarebbe derivata da una causa a sé non imputabile.
9.1.- Quanto, poi, alla violazione del diritto al silenzio, la difesa statale osserva che la disposizione censurata non obbligherebbe il contribuente a esibire la documentazione o a rivelare dati che siano a sé sfavorevoli e, quindi, ad anticipare la propria strategia difensiva già in sede di contraddittorio endoprocedimentale: essendo invece il documento favorevole al contribuente e solo da lui posseduto, non ci sarebbe ragione per cui lo stesso non debba esibirlo quando richiesto, poiché in tal modo potrebbe evitare di subire l'accertamento.
La ratio della inutilizzabilità della documentazione dovrebbe, quindi, essere ricondotta alla «necessità di scoraggiare l'atteggiamento ostruzionistico del contribuente che rallenti o ostacoli l'attività accertativa degli Uffici, oltre che nella finalità di salvaguardare l'interesse giuridico al regolare accertamento dei tributi».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con ordinanza iscritta al n. 165 reg. ord. del 2024, la CGT di Roma, sezione 28, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25 e 111, primo comma, Cost., nonché, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli artt. 47 e 48 CDFUE, e dell'art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso.
L'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce al quarto comma che «[l]e notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».
Il successivo quinto comma prevede che «[l]e cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».
Secondo la rimettente, l'inutilizzabilità della documentazione sancita dalla disposizione censurata dovrebbe essere ricondotta nell'ambito delle «sanzioni euro-penali» - in forza dei principi enucleati dalle sentenze della Corte EDU circa l'ambito di applicazione dell'art. 6 CEDU e l'estensione dei "criteri Engel" -, con la conseguenza che dovrebbero trovare applicazione le garanzie del giusto processo.
Sarebbero pertanto violati, in primo luogo, il diritto all'azione e quello di adire il giudice naturale, che troverebbero riconoscimento nell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nell'art. 6 CEDU, nell'art. 47 CDFUE, nell'art. 14 PIDCP, oltre che negli artt. 24 e 25 Cost.; limitare la possibilità di offrire al giudice i contenuti, anche probatori, della pretesa, corrisponderebbe, infatti, a negare in radice l'azione e, quindi, la conseguente possibilità di tutela.
Sarebbe leso anche il diritto alla pubblica udienza, riconosciuto dalle medesime norme nonché dall'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 25 Cost., in quanto la limitazione dei mezzi di prova prevista dalla disposizione censurata non tutelerebbe l'esigenza della «massima trasparenza della procedura».
Verrebbe anche in specifica considerazione la tutela del diritto alla difesa, previsto dall'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dall'art. 6 CEDU, dall'art. 14 PIDCP, dagli artt. 47 e 48 CDFUE, nonché dall'art. 24, secondo comma, Cost., perché la disposizione censurata non consentirebbe al contribuente di potere efficacemente tutelare la sua posizione giuridica soggettiva.
Inoltre, dal diritto alla difesa deriverebbero ulteriori «diritti-corollari», fra i quali, oltre a quello della parità delle armi tra le parti del giudizio, anche il diritto al silenzio, tutelato dall'art. 6 CEDU nonché dall'art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP e dagli artt. 24 e 111 Cost.
Secondo il rimettente, poiché il diritto al silenzio comporterebbe quello di non difendersi sotto costrizione quando possa cagionarsi un aggravamento della posizione processuale, la disposizione censurata porrebbe il contribuente dinanzi a una non consentita alternativa tra la rinuncia alla strategia difensiva che ritiene per sé più vantaggiosa e la perdita irreparabile di strumenti difensivi.
2.- In rito vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa statale per difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice non avrebbe accertato se la mancata produzione dei documenti richiesti alla contribuente fosse conseguenza di un fatto ad essa non imputabile, nonché se l'invito a produrre la documentazione fosse stato prodotto in giudizio e se l'amministrazione finanziaria avesse assolto all'onere di provare quei presupposti che, secondo il diritto vivente della giurisprudenza della Corte di legittimità, sarebbero necessari affinché possa trovare applicazione la preclusione prevista dalla disposizione censurata.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla rilevanza formulata dal giudice a quo «è oggetto di un controllo meramente esterno» a opera di questa Corte, che si arresta «sulla soglia della non implausibilità della motivazione», sia quanto all'applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire «quest'ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata» (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2022).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha escluso, non avendo la contribuente prospettato alcuna contestazione in merito a tali profili, che si ponesse la necessità di accertare quanto ipotizzato dalla difesa erariale in riferimento al comportamento non imputabile della contribuente, alle forme dell'invito dell'amministrazione finanziaria e alla sua legittimità.
Per tali ragioni, non può ritenersi che sussista un difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente ha precisato, in modo non implausibile, l'oggetto del decidere e le ragioni per le quali era tenuto a fare applicazione della disposizione censurata.
Non può trovare accoglimento nemmeno l'ulteriore eccezione proposta dalla difesa statale di inammissibilità delle questioni per omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Nel caso di specie, la CGT di Roma ha chiaramente precisato le ragioni per cui la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa della contribuente.
2.1.- Va invece rilevata d'ufficio l'inammissibilità delle questioni sollevate in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, condizione - questa - alla quale è subordinata, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 85 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 69, n. 31 e n. 7 del 2025).
2.2.- Per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, d'ufficio deve essere dichiarata altresì l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
3.- Con riferimento al merito, in via preliminare, occorre evidenziare che le disposizioni censurate, nel diritto vivente, sono state già oggetto di un'interpretazione restrittiva, progressivamente elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che «la previsione normativa in esame deve essere interpretata con particolare rigore ed entro limiti specifici, posto che la sua applicazione comporta una chiara limitazione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato, di potere legittimamente produrre in giudizio, a fini difensivi, i documenti ritenuti idonei a sostenere le proprie ragioni di difesa avverso la pretesa impositiva dell'ufficio finanziario» (Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 1° agosto 2019, n. 20731).
A tal fine, la Corte di cassazione si è mossa su due linee interpretative tra loro correlate.
In primo luogo, si è preoccupata di tracciare quali adempimenti sono richiesti a carico dell'amministrazione finanziaria affinché la disposizione possa trovare applicazione senza pregiudicare il diritto di difesa del contribuente.
In secondo luogo, ha precisato in quali casi possa dirsi operante la previsione di non imputabilità della mancata esibizione a carico del contribuente.
3.1.- Con riferimento al primo profilo, si è chiarito che l'invito alla esibizione o consegna degli elementi informativi di cui all'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 660 del 1973, può produrre la preclusione al loro utilizzo in sede processuale solo a condizione che, in sostanza, la richiesta dell'amministrazione finanziaria: a) sia stata rivolta specificamente al contribuente o a un suo ausiliare, e non a un terzo (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3254); b) sia stata specifica e puntuale, non potendo operare la limitazione innanzi a una generica richiesta di informazioni o documenti (Corte di cassazione, quinta sezione civile, ordinanza 16 giugno 2017, n. 15021), secondo la tecnica della cosiddetta "pesca a strascico"; c) preveda un congruo termine per rispondere, in relazione alla tipologia di richiesta e in ogni caso non inferiore a quindici giorni, in ossequio al principio di buona fede (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 marzo 2023, n. 6275); d) non riguardi documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, trovando applicazione l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), per cui «[a]l contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2014, n. 8299).
3.2.- Con riguardo al secondo profilo, sul versante opposto, si è chiarito quando possa ritenersi scusabile il comportamento del contribuente e, quindi, non preclusivo della possibilità di produrre in giudizio la documentazione.
Da questo punto di vista, superando la più remota giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 30 dicembre 2009, n. 28049), si è precisato che «l'omissione deve essere obiettivamente cosciente e volontaria, diretta ad impedire l'ispezione documentale» (Corte di cassazione, sezione quinta tributaria, ordinanza 25 giugno 2019, n. 16962).
In sostanza, tra le cause non imputabili sono fatte rientrare non solo quelle che escludono l'elemento soggettivo della condotta, quali la forza maggiore, il fatto del terzo o il caso fortuito, ma anche i comportamenti non riconducibili alla sfera di controllo del contribuente (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 10 novembre 2023, n. 31345), come nel caso in cui «i documenti provengano dal terzo» (Cass. n. 3254 del 2021) o dipendano esclusivamente dal comportamento del consulente fiscale (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6092).
In tal modo, si è avviato un processo di tendenziale allineamento interpretativo tra la previsione dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e quella contenuta nell'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) che, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, prevede l'operare di un analogo effetto di inutilizzabilità della documentazione «di cui è rifiutata l'esibizione», e che ha, quindi, quale presupposto il «dolo» del contribuente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 febbraio 2000, n. 45).
Si tratta di un allineamento necessario, poiché non è ragionevole ritenere che le due ipotesi normative, in fondo differenziate solo per la modalità della verifica (a seguito dei controlli a tavolino dell'amministrazione finanziaria o presso la sede del contribuente), abbiano presupposti applicativi diversi l'una dall'altra.
4.- Una volta chiarito che le disposizioni censurate sono state interpretate dal diritto vivente in modo da recuperarne una maggiore rispondenza ai principi costituzionali, al fine di valutare la sufficienza del complessivo assetto così raggiunto a escludere il contrasto con i parametri evocati, deve essere considerata la natura della misura in oggetto, che si configura in termini qualificati dalla dottrina come una "sanzione impropria".
Si tratta di una figura non estranea al diritto tributario, che in alcuni casi colpisce il contribuente che non ha osservato determinate prescrizioni non solo con una sanzione formale (amministrativa o penale) ma anche con una situazione di svantaggio, che può rivestire carattere procedimentale (e/o processuale) o sostanziale.
Rientrano nell'ambito di questa tipologia, ad esempio: la perdita, ai sensi dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il contribuente che registri le fatture fuori termine; il divieto di prova previsto dall'art. 61, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, concernente le circostanze omesse nelle scritture contabili obbligatorie o in contrasto con le risultanze di queste; l'imputazione ai ricavi, ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, dei prelevamenti annotati nei conti bancari e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario.
5.- La giurisprudenza costituzionale, salvo qualche eccezione (tra cui sentenze n. 140 del 2022 - questa, in realtà, sugli oneri fiscali condizionanti l'accesso alla tutela giurisdizionale -, n. 338 del 2011 e n. 103 del 1967), ha ravvisato, al ricorrere di particolari requisiti, la non illegittimità costituzionale di tale tipo di sanzioni (sentenze n. 186 del 1982, n. 121 del 1982 e n. 201 del 1970; ordinanze n. 246 del 1993 e n. 385 del 1989).
Il sindacato di questa Corte si è, in sostanza, rivolto alla verifica in termini di ragionevolezza e di proporzionalità del bilanciamento operato dal legislatore, con una valutazione calibrata a seconda della specificità e della portata delle norme censurate e delle esigenze poste a giustificazione delle stesse.
5.1.- Essenziale è quindi soffermarsi su questa analisi, iniziando a rilevare che, dalla ricostruzione della Corte di cassazione, emerge che le norme qui censurate hanno lo «scopo di favorire il dialogo fra le parti, in vista di un chiarimento pre-contenzioso delle reciproche posizioni, con risparmio di energie economiche e processuali. Sicché il soggetto è posto in condizione di rispondere - e rendere in tal modo possibile un chiarimento utile ad entrambe le parti - o non rispondere ed attendere l'esito dell'accertamento in corso; fermo restando (ad ulteriore dimostrazione dello spirito di collaborazione e di dialogo cui la norma in esame è ispirata) che egli ha pur sempre facoltà di dimostrare con idonea documentazione, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6)» (Cass. n. 28049 del 2009).
6.- Tutto ciò premesso, le questioni non sono fondate nei termini di seguito chiariti.
Nella misura in cui sono funzionali all'instaurarsi di un dialogo anticipato, le norme censurate non si pongono in contraddizione con il cambio di paradigma che la Costituzione ha realizzato rispetto alle precedenti concezioni statualistiche, che esaurivano la dinamica fiscale nell'ambito dei doveri di soggezione cui il suddito era tenuto in forza dell'appartenenza allo Stato.
Infatti, «nella Costituzione il dovere tributario [...] è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale - come ritenevano risalenti concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione - alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali [...] sia gran parte di quelli civili» (sentenza n. 288 del 2019).
Si è così chiarito che il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, nella consapevolezza del suo essere funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce.
È proprio da questo legame tra diritti e doveri, «anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi ma in particolare al suddetto sistema dei diritti».
È quindi radicalmente cambiata la prospettiva rispetto al passato pre-costituzionale: quel che sta al centro non è più tanto lo Stato e il potere tributario, o addirittura la forza e l'arroganza del fisco, ma altre categorie concettuali che attengono alla persona situata dentro la comunità, ai rapporti che derivano dai legami sociali in cui è immersa, ai vincoli di solidarietà che ne conseguono e che spetta al legislatore definire, ispirandosi alla progressività e nel rispetto della capacità contributiva.
6.1.- È intorno a questi principi che ruotano i richiami, già operati da questa Corte, alla collaborazione nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il privato, quando «siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 della Costituzione), tra i quali quelli in materia tributaria» (sentenza n. 351 del 2000) e al fatto che «il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza» (ordinanza n. 246 del 1993).
Si tratta, in definitiva, di una prospettiva in cui, dato appunto il legame tra doveri e diritti, le ragioni del fisco possono tendere a non risultare più estranee e contrapposte a quelle del contribuente.
Ciò tuttavia richiede, per inverarsi, il rispetto di una duplice condizione.
Innanzitutto, sul piano legislativo, occorre che «il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si determina un'alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale» (ancora sentenza n. 288 del 2019).
Sul piano esecutivo, è poi necessario che l'amministrazione finanziaria modelli il proprio atteggiamento secondo i canoni di correttezza e buona fede, come richiesto, del resto, dall'art. 10, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), che prefigura doveri di informazione a carico della stessa amministrazione finanziaria (artt. 5 e 6), il diritto al contraddittorio (art. 6-bis) e alla motivazione (art. 7) nonché la non utilizzabilità delle prove raccolte oltre i termini di legge (art. 7-quinquies).
Quando questi principi sono disattesi, anche in questo caso ci si allontana dalle ragioni di civiltà giuridica che fondano i doveri inderogabili di solidarietà e il contribuente si ritrova a subire nuovamente il peso di una condizione di soggezione.
7.- Da queste precisazioni discende che la previsione dell'inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati in sede di controllo, per potere trovare giustificazione all'interno di questa dimensione costituzionale, deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portata applicativa.
Va infatti considerato che la sua struttura la pone sì tra le preclusioni di «natura processuale» (sentenza n. 26 del 2015 e ordinanza n. 181 del 2007), ma anche che dalla sua applicazione possono determinarsi riflessi sul piano sostanziale, allorché all'inutilizzabilità dei documenti e dei dati, ad esempio, consegua l'impossibilità di provare un reddito inferiore a quello accertato.
Da questo punto di vista, siccome dall'applicazione delle disposizioni censurate possono derivare, a seconda della portata del debito fiscale che si determina per l'inutilizzabilità dei dati informativi, sanzioni amministrative sostanzialmente punitive o anche sanzioni formalmente penali, la loro interpretazione deve renderle del tutto estranee alla portata del principio nemo tenetur se detegere, che «costituisce un "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", riconosciuto dall'art. 24 Cost. (ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002)» (sentenza n. 84 del 2021), e del giusto processo.
7.1.- Si palesa quindi l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata laddove l'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce alle «notizie», ai «dati», agli «atti», ai «documenti», ai «libri» e ai «registri» che «non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente».
In particolare, si deve ritenere, valorizzando l'espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Devono, pertanto, essere esclusi dall'ambito applicativo della sanzione dell'inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente.
È solo all'interno di questi confini che si giustifica, superando gli specifici profili di illegittimità costituzionale evocati dal rimettente, la portata delle norme censurate, che risultano allora rivolte a spingere il contribuente a cooperare all'attività dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria; tutto il meccanismo normativo risulta infatti funzionale a evitare, anche con scopo deflattivo, l'istaurazione di un giudizio tributario non necessario (sull'ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale e sulla finalità di deflazionare il contenzioso tributario, si veda, da ultimo, sentenza n. 36 del 2025).
7.2.- Infine, nella medesima prospettiva, deve anche essere ampliato il ricordato principio, già affermato in nuce dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014).
In forza dell'evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l'amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente interrogandole.
È ben vero che questa Corte, in altro contesto, ha affermato che un «sistema di fiscalità di massa» poggia «sull'architrave dell'autoliquidazione delle imposte, cui deve corrispondere, nell'ambito dell'imposta sui redditi, la fedele compilazione e la tempestiva presentazione della dichiarazione, che costituisce uno degli atti più importanti nell'ambito della disciplina attuativa di tale imposta», per cui l'inosservanza di quest'obbligo incide sull'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che «dovrà invece ricorrere ad altri e più impegnativi strumenti nei confronti di quei contribuenti che, non assumendo tale atteggiamento collaborativo, presumibilmente sono orientati a sottrarsi totalmente al versamento delle imposte dovute», con «un impegno ben superiore, in termini di risorse umane, rispetto a quello normalmente richiesto per la effettuazione degli altri controlli, e in particolare di quelli automatizzati e formali» (sentenza n. 46 del 2023).
Tuttavia, queste affermazioni, che hanno senso in riferimento alle dichiarazioni fiscali, non giustificano certo che al contribuente vengano richiesti oneri di attivazione (con il potenziale rischio, peraltro, di eventuali errori che determinino poi l'inutilizzabilità delle prove) per fornire elementi informativi di cui l'amministrazione finanziaria potrebbe facilmente disporre.
Le medesime affermazioni, al contrario, giustificano la norma nella misura in cui la stessa amministrazione finanziaria non potrebbe agevolmente ottenere i dati senza la collaborazione del contribuente, in mancanza della quale si espone, come detto, al rischio di attività di accertamento e contenziose che poi si possono rivelare, al momento della conoscenza di quei dati, inutilmente attivate, dal momento che la presentazione "a sorpresa" del documento favorevole da parte del contribuente conduce all'annullamento, totale o parziale, dell'atto di accertamento.
8.- È così interpretata che la norma censurata ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è «presupposto di ogni civile convivenza» (sentenza n. n. 351 del 2000).
Del resto, così ridimensionata e intesa, la norma censurata è idonea a inserirsi nel più ampio contesto dell'evoluzione dei rapporti tra "autorità" e "consenso" e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente a favore di una progressiva partecipazione di quest'ultimo al procedimento.
A partire dalla fine degli anni Novanta, infatti, questa evoluzione ha sancito un progressivo passaggio a un approccio fondato sulla collaborazione.
Tale approccio si basa sul presupposto che le relazioni improntate sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca siano, in molti casi, più efficaci del ricorso a strumenti autoritari e repressivi.
Nel solco di questa evoluzione si è collocato, ad esempio, il regime di adempimento collaborativo introdotto in Italia con gli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23), che ha sviluppato meccanismi di compliance fiscale basati proprio sul dialogo anticipato fra fisco e contribuente volti a ridurre, anche attraverso l'individuazione dei profili di maggior rischio fiscale, l'attività di accertamento successiva alla presentazione della dichiarazione.
Si tratta di una prospettiva che è stata rafforzata dalla recente riforma tributaria, che, con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo), ha apportato importanti modifiche al d.lgs. n. 128 del 2015, tra l'altro, ampliando la platea di contribuenti destinatari dell'istituto, implementando il regime premiale loro riservato, introducendo la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di professionisti indipendenti qualificati, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.
9.- In conclusione, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata qui individuata, operando all'interno di una logica tesa a favorire il dialogo anticipato, la cooperazione e l'intesa tra fisco e contribuente, le disposizioni censurate non violano i parametri evocati dal rimettente con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. sul diritto alla difesa, all'art. 25 Cost., evocato in relazione al diritto alla pubblica udienza, e all'art. 111, Cost. sul giusto processo, né all'art. 6 CEDU nonché all'art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe.